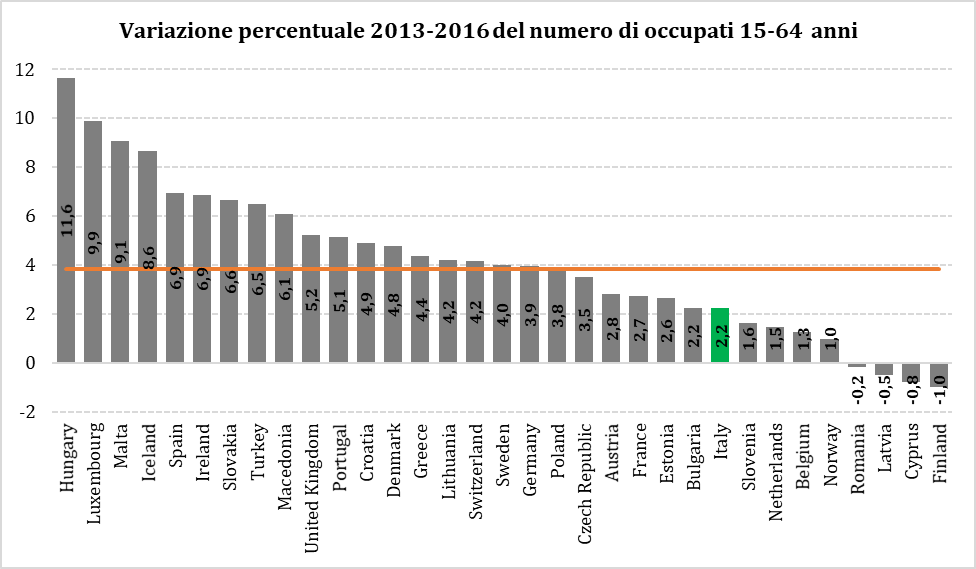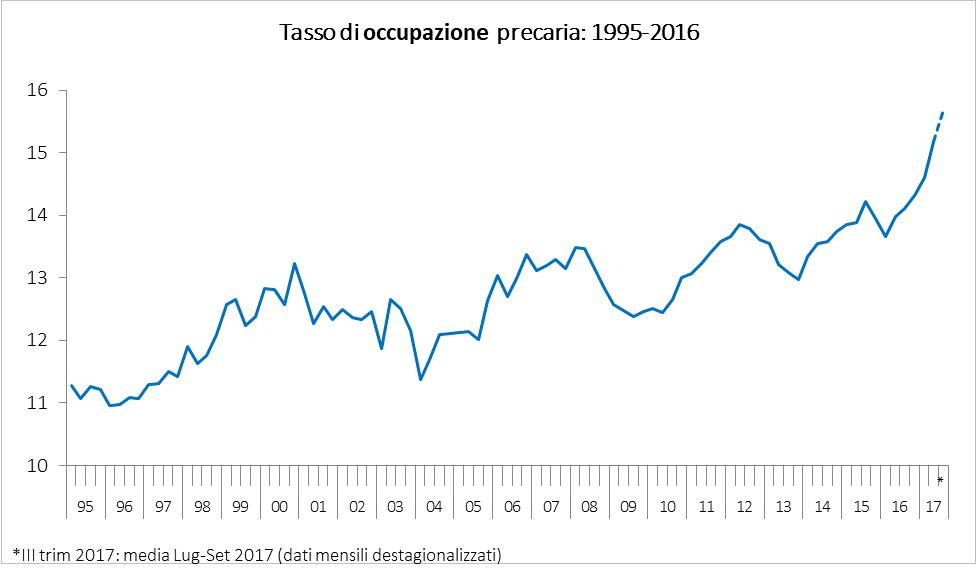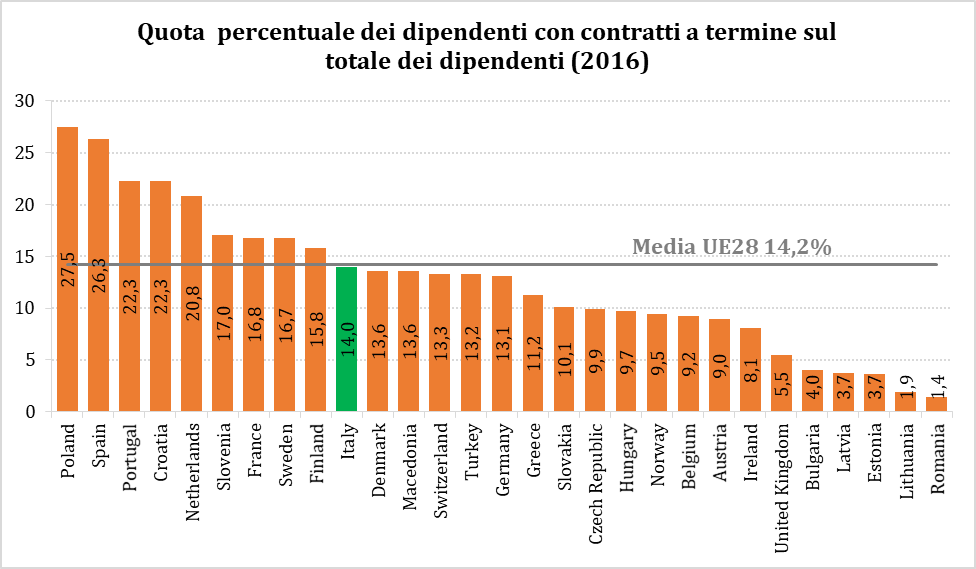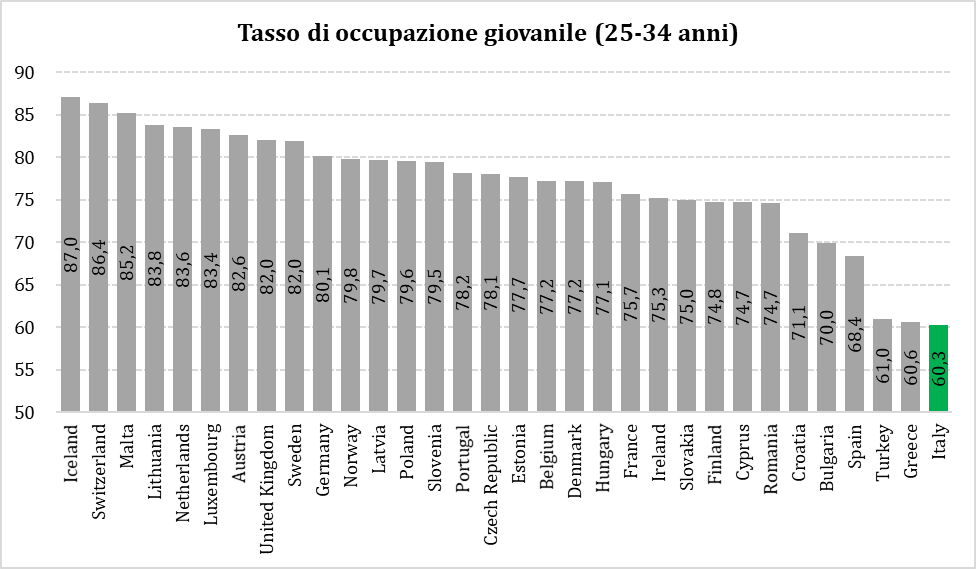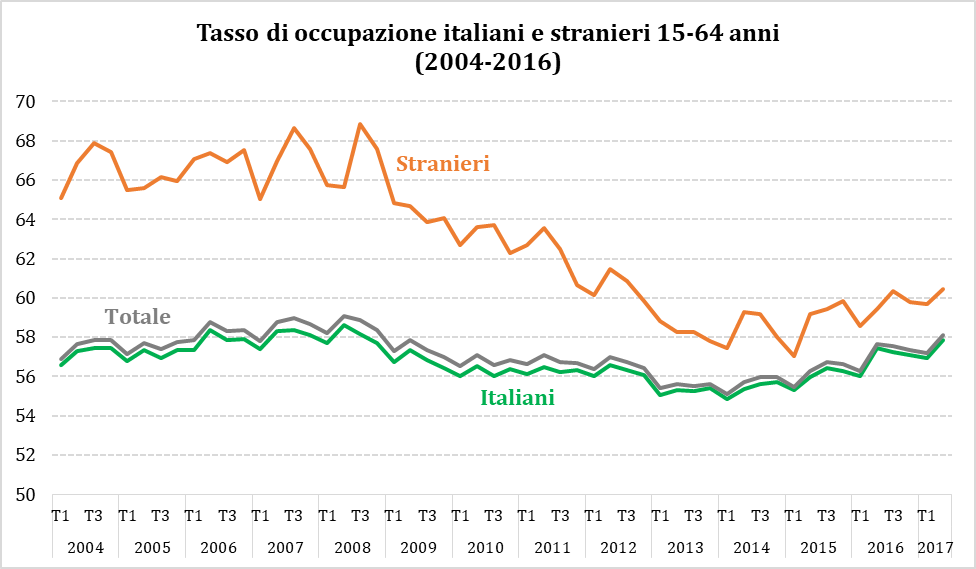L’affaire Scalfari. Di Maio o Berlusconi?
Anch’io sono rimasto sbalordito, incredulo, senza parole. Ma non perché Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica (e maestro riconosciuto di quel mondo), abbia osato dichiarare, o quantomeno far intendere, che Berlusconi è meno peggio di Di Maio, bensì per le reazioni che quella dichiarazione (rilasciata in tv, rispondendo a una domanda di Giovanni Floris) ha suscitato nel mondo che intorno a Repubblica è cresciuto e ha prosperato.
Reazioni scomposte, violente, cattive, intrise di disprezzo. C’è chi è arrivato a dire che un commento adeguato costringerebbe a usare il turpiloquio, e comunque non si è trattenuto dal qualificare la presa di posizione di Scalfari come “indecente”, frutto di una “parabola reazionaria”, ormai approdata su “lidi di ignominia che rinnegano e azzerano ogni suo merito progressista pregresso” (Flores D’Arcais). C’è chi non ha avuto nemmeno questa delicatezza, e ha attribuito l’uscita di Scalfari all’età e alla vanità, ovvero alla voglia di “riconquistare la scena” (Carlo De Benedetti, in una livorosa intervista rilasciata al “Corriere della Sera”). E vi risparmio le decine di invettive e offese reperibili sul web, come quelle che in questi giorni aprono il blog di Beppe Grillo, ove Scalfari è un “servo del Pd”, uno che “ormai è solo un vecchio ottuso e testardo, irrecuperabile che vomita oscenità”.
Ma anche la reazione del suo giornale e del suo ex editore (De Benedetti ha regalato il Gruppo L’Espresso ai figli) fa riflettere. Subito dopo l’uscita di Scalfari in Tv Repubblica ha cercato di mettere una pezza pubblicando un articolo di precisazione dello stesso Scalfari, che avrebbe dovuto rassicurare ma non ha rassicurato nessuno, perché non conteneva affatto l’auspicata marcia indietro ma solo l’assicurazione che non avrebbe mai commesso peccato mortale (votare Berlusconi). E pensare che, quando eravamo entrambi a “La Stampa”, e io mi stupivo delle diversità di opinione dei suoi editoralisti, era stato proprio Mario Calabresi a spiegarmelo: “un giornale non è una caserma”.
Quanto a Carlo De Benedetti, non ha trovato di meglio che affermare che l’uscita di Scalfari ha “gravemente nuociuto al giornale”, come se Repubblica fosse un partito, e il pluralismo delle opinioni, anche le più paradossali, non fosse un bene prezioso.
Perché mi soffermo su questa vicenda?
Ci sono due ragioni, una privata e l’altra no. La ragione privata è che conosco Eugenio Scalfari fin da quando ero un ragazzo, sono legato a lui e alla sua famiglia (a partire dagli indimenticabili Giulio e Maria De Benedetti) da un profondo affetto, e sono rimasto colpito, quasi ferito, dalle offese che negli ultimi giorni gli sono piovute addosso da persone che, fino a un attimo prima, lo incensavano ed erano nella cerchia dei suoi più stretti amici e compagni. Se una cosa ho imparato nei miei anni giovanili, quando l’università era ancora un posto speciale, e a Torino potevi incontrare decine di veri maestri, è che la stima e l’ammirazione per una persona si riconoscono da questo semplice gesto: quando il tuo maestro dice qualcosa che ti sembra del tutto sbagliato, anziché chiederti se è impazzito lui, ti chiedi, prima, se non sei tu che stai sbagliando qualcosa.
Anche Paolo Mieli, qualche giorno, ha detto qualcosa di simile proprio a proposito di Scalfari. L’ex direttore del Corriere della Sera, intervistato da Lilli Gruber a “Otto e mezzo”, ha detto più o meno così: se una cosa del genere fosse successa al Corriere, come direttore non avrei chiesto a Scalfari un intervento di rettifica, ma piuttosto di spiegare, approfondire, sviluppare un pensiero. In altre parole: aiutare noi, che diciamo di rispettarlo, a capire se effettivamente dissentiamo da lui, o c’è qualcosa che noi stiamo trascurando, qualcosa che ci sfugge alla nostra mappa del modo reale.
Ecco perché difendo Eugenio Scalfari. Lo so, lui ha duramente criticato il mio libro più noto (Perché siamo antipatici, 2005), anzi ha vivamente disapprovato il fatto stesso che io avessi osato scriverlo. E io da anni lo trovo troppo filo-Pd, come peraltro lui stesso dichiara di essere. Ma tutto questo non c’entra e non deve c’entrare. Se anche dissentissi radicalmente da lui, e condividessi al 100% le contro-obiezioni dei suoi critici, resterei della medesima idea: le idee non si combattono lapidando chi ne esprime di diverse dalle nostre.
E qui vorrei venire alla seconda ragione, quella né privata né personale, per cui mi pare valga la pena tornare sull’idea espressa da Scalfari. L’affare Scalfari ci insegna più cose di quante si riconoscano a prima vista.
Intanto ci insegna una cosa, su cui forse Scalfari stesso dovrebbe riflettere. Ai miei occhi, il modo in cui il mondo di Repubblica sta trattando il fondatore la dice lunga su quel mondo stesso. Di cui non mi colpisce tanto la cattiveria e l’animosità (fortunatamente non di tutti), ma la faziosità, l’incapacità di mettersi nei panni dell’altro, l’ostinata convinzione che, su certe questioni, una sola sia la posizione giusta: la nostra posizione. Perché noi siamo la parte migliore del paese, quella che ha visto giusto fin dall’inizio, quella che è impegnata nelle più alte battaglie di civiltà, quella che sa perfettamente che cosa è il bene e che cosa è il male. Quella, soprattutto, che non ha dubbi su che cosa sia il male assoluto: archiviato il nazismo, archiviato il fascismo, resta lui, solo lui, il cattivo per antonomasia, Silvo Berlusconi. Una sorta di pensiero unico progressista impedisce alla sinistra benpensante, che pure predica il rispetto di tutte le differenze, di fare i conti con una piccola differenza, un piccolo scarto, una piccola deviazione all’interno del proprio mondo, quella di un pensiero non completamente convenzionale, e non esclusivamente moralistico, sul nemico Berlusconi. Il mio modesto parere è che, se la sinistra è così spiazzata dal populismo, è anche perché il pensiero unico di cui è (volutamente) prigioniera le impedisce ogni vero accesso al diverso da sé, di cui le istanze populiste sono la massima espressione.
Ma c’è anche un altro aspetto che l’affare Scalfari solleva. Lo ha visto molto lucidamente Marco Travaglio che, a differenza di altri, si è ben guardato dall’attribuire l’uscita di Scalfari alla vanità, all’età avanzata, o a qualche perdita delle capacità intellettuali.
“Porto rispetto a Scalfari e gli voglio bene (…). Dopo la morte di Montanelli, le cose più dure su Berlusconi le ho lette negli articoli di Scalfari” (…).
“Mi sono ben guardato dal dire che Scalfari è anziano. Secondo me, ci sta perfettamente con la testa e ha detto esattamente quello che pensano lui e una gran parte del nostro establishment”
Come si vede, il direttore del “Fatto Quotidiano”, pur essendo il più lontano fra tutti dalle posizioni di Scalfari, ne ha molto più rispetto di quanto ne abbia la sinistra indignata, quella di Micromega, di Libertà e Giustizia, di una parte del mondo di Repubblica. Per Travaglio, Eugenio Scalfari “ci sta perfettamente con la testa”, semplicemente esprime una posizione che pur essendo “incomprensibile” (per Travaglio stesso), è comprensibilissima per altri.
E allora vediamola, questa posizione. A me pare che il nocciolo del problema stia in ciò. C’è una parte del popolo di sinistra (probabilmente la maggioranza degli elettori Pd) che ritiene che le grandi battaglie per cambiare il Paese siano quelle sulla corruzione, il funzionamento della giustizia penale, il conflitto di interesse, i diritti delle minoranze, l’accoglienza dei migranti, le coppie di fatto, la bioetica, l’ambiente, eccetera. Tutte cose che riguardano soprattutto le regole, ma spostano poche risorse.
C’è un’altra parte del popolo di sinistra (probabilmente minoritaria) che, pur non disdegnando le grandi battaglie civili, crede che il futuro si giochi su temi meno sovrastrutturali, più legati all’economia e meno ai diritti: debito pubblico, occupazione, tasse, welfare, giustizia civile, competitività. Non entro qui nel sotto-problema strettamente politico delle ricette, che possono essere modernizzanti (sinistra riformista) o nostalgiche (Sinistra Purosangue). Perché il punto non è se ci piace il Jobs Act oppure no, il punto è che, se ci si colloca in questa seconda prospettiva, più attenta all’hardware del sistema sociale che al suo software, allora tutto cambia. Allora quel che ci si chiede non è che cosa pensa Di Maio del fine vita, o dei diritti dei gay, o delle politiche di accoglienza, ma che cosa succede allo spread dei nostri titoli di Stato se al governo va una forza politica che non ha mai governato, è anti-europea, e nel suo programma ha parecchie misure che potrebbero scassare i conti dello Stato. E anche a una persona come Scalfari, che sicuramente detesta Berlusconi ma ha una formazione culturale da economista, nonché una profonda conoscenza dei delicati meccanismi delle istituzioni economiche, può venire in mente una cosa che alcuni dicono da anni: e cioè che, se parliamo di governo dell’economia, non è facile dire se, in questi 20 anni, siano stati più dannosi (o meno inefficaci) i governi di destra o quelli di sinistra. Tanto più che, per una strana congiunzione astrale, la sinistra ha sempre avuto la fortuna di governare in anni di vacche (relativamente) grasse, e la destra in anni di vacche decisamente magre.
Ecco che, allora, alcune frasi di Scalfari si capiscono. Quando, ad esempio, riprendendo un tema che ricorre in tutti i classici del pensiero politico, da Platone a Machiavelli, osserva:
La politica è una cosa diversa dalla morale. La politica non è un fatto morale, è un fatto di governabilità, questa è la politica.
O, più provocatoriamente:
Per Platone quelli che facevano la politica di una città, di un paese erano i filosofi, che cosa poi i filosofi fossero moralmente era un problema che né Platone né Aristotele prendevano in considerazione. Aristotele fu insegnante della politica sapete di chi? Di Alessandro Magno. Il quale Alessandro Magno della morale se ne fotteva nel più totale dei modi.
Con questo non voglio dire che non la si possa pensare come Savonarola, o come Flores D’Arcais, o come Travaglio, o come Ingroia. Uno può essere convinto che il prius sia la rigenerazione morale di questo orrido popolo italiano, e che tutto il resto segua. O che si debba costruire l’uomo nuovo con una rivoluzione più o meno cruenta. Anzi, arrivo a dire che, a giudicare dall’insuccesso delle infinite riforme con cui ci balocchiamo da decenni, anche i sogni palingenetici, come quelli dei Cinque Stelle, hanno una loro logica.
E tuttavia il vero discrimine non è questo. Il discrimine è che, se invece la si pensa come la sinistra che si occupa soprattutto del funzionamento dell’economia, e in più si ritiene che, finché non si riforma, il nostro paese sia altamente vulnerabile agli shock esterni, allora un’affermazione come “Di Maio è più pericoloso di Berlusconi” diventa perfettamente comprensibile, e tutt’altro che eretica. Anzi, è una frase che, semmai, deriva da un eccesso di razionalità: è la frase di chi ha la forza di mettere a tacere i sentimenti, e il coraggio di far prevalere il cervello, la cruda analisi della “realtà effettuale”, come la chiamerebbe Niccolò Machiavelli. Non posso sapere se siano esattamente questi i timori che hanno spinto Scalfari a prendere così nettamente le distanze dal Movimento Cinque Stelle, ma lo ritengo verosimile.
Quel che stupisce non è che Scalfari abbia potuto esprimere questo genere di preoccupazioni, ma è il corto circuito mentale dei suoi critici, incapaci di uscire da uno schema logico-mentale di cui sono prigionieri: se dico che A (Di Maio) è peggio di B (Berlusconi), allora implicitamente sto legittimando B.
Non so se ve ne siete accorti, ma questo virus è ormai sempre più penetrato nella sinistra benpensante. E’ lo stesso virus che, per fare un solo esempio, a suo tempo ha condotto alla lapidazione mediatica di Debora Serracchiani, rea di aver detto che lo stupro è ancora più grave se commesso da uno straniero, che tradisce la fiducia del paese che lo accoglie: qualcuno ha avuto il fegato di interpretarlo come un’attenuante per gli stupri commessi da italiani.
Eppure è una questione di logica, o forse sarebbe meglio dire di uso non malato della lingua italiana: dire che una cosa è ancora peggiore di un’altra non significa rivalutare la cosa “meno peggiore”. Significa solo esercitare la capacità di giudizio.
C’è un’ultima ragione per cui l’affare Scalfari merita di non essere archiviato. Quella presa di posizione, che io giudico semplicemente segno di coraggio e di libertà intellettuale, sta portando alla luce un tema nascosto. Un tema di cui, soprattutto nell’establishment di sinistra, non si ha il coraggio di parlare, o meglio di parlare apertamente, con la dovuta spregiudcatezza.
Il tema è questo: sul dopo voto la sinistra è divisa, e lo è precisamente sul punto che Scalfari ha sollevato. C’è una parte della sinistra, quella che fa capo a Renzi e al Pd, che pensa che, in assenza di una maggioranza autosufficiente, si potrebbe varare un governo Pd-Forza Italia. Questa possibilità non dovrebbe suscitare alcuno scandalo, non solo perché Pd e Forza Italia sono i due partiti più europeisti (o meno anti-europeisti) del nostro sistema politico, ma perché su molti punti cruciali di politica economica sono sostanzialmente d’accordo: più flessibilità sui conti pubblici, meno pressione fiscale, nessun ritorno all’articolo 18.
Ma c’è un’altra parte della sinistra, molto forte nel mondo di Repubblica, ma anche (secondo i sondaggi) nell’elettorato progressista, che mal sopporta Renzi e simpatizza con i Cinque Stelle, visti come una sorta di sinistra più idealista e pura di quella, tutta modernizzazione e riforme, impersonata da Renzi e dai suoi. Ebbene, questo pezzo della sinistra non lo dice apertamente, ma vagheggia un qualche tipo di “sponda” fra la sinistra stessa e i Cinque Stelle, sul modello dell’operazione invano tentata da Bersani nel 2013. Questa prospettiva piace ovviamente alla sinistra Purosangue, che rappresenta una sorta di ponte ideale fra sinistra riformista e Cinque Stelle ma, per quel che capisco, non dispiace nemmeno a una parte del mondo di Repubblica, che dopo 23 anni di anti-berlusconismo “senza se e senza ma”, è ancora lì, fermo alla demonizzazione del Cavaliere visto come il male assoluto, che come tale non prevede che possa esistere, in natura, un male ancora più grande.
Ecco, temo che sia stato questo il vero peccato del fondatore di Repubblica. Se la reazione del suo mondo è stata così virulenta forse è anche perché, dicendo quel che ha detto, di fatto ha tolto legittimità al flirt che, sia pure obliquamente, una parte della sinistra stava (e sta) imbastendo con i Cinque Stelle (dalla legge sul fine vita alle dichiarazioni sull’articolo 18). Un flirt che, a quel che risulta dai sondaggi, seduce una parte non piccola dell’elettorato progressista, e fino a ieri trovava in Repubblica il luogo adatto per fare capolino.
Con la sua paradossale dichiarazione di preferenza per Berlusconi, Scalfari non ha fatto altro che scoprire il gioco: un contributo alla chiarezza, più che una perdita del senno.