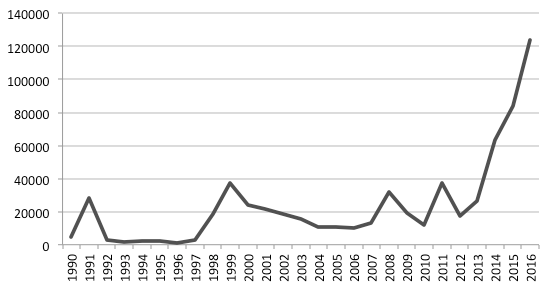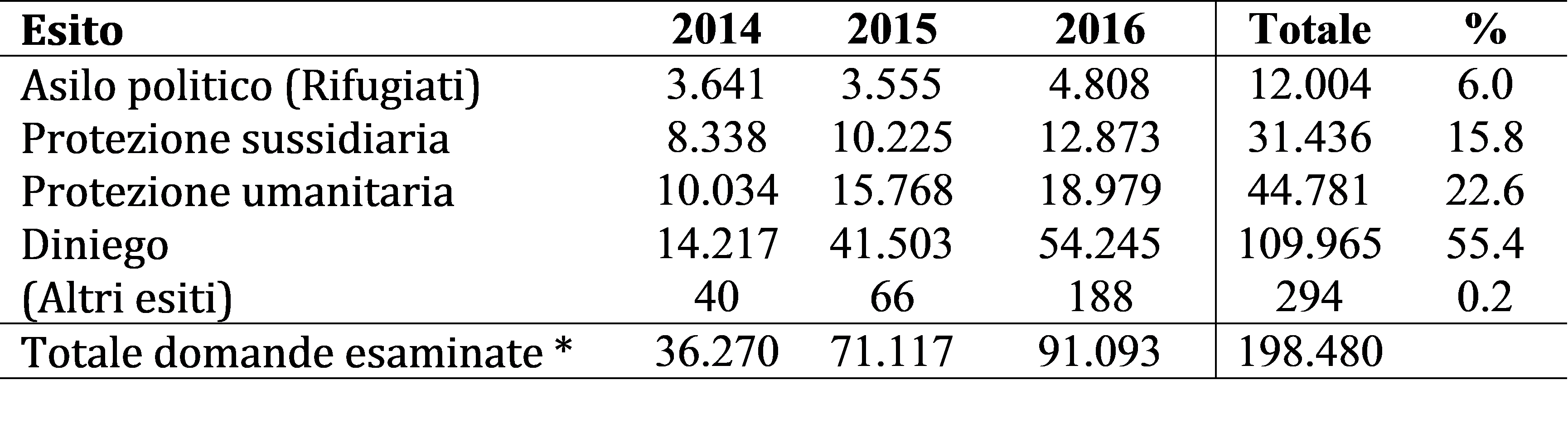Deportazioni o rimpatri?
Sono tante le ragioni per cui la grande stampa nazionale, e più in generale i grandi media, hanno perso autorevolezza. Certo, anche in passato ben pochi si fidavano ciecamente di “quel che scrivono i giornali”, o di “quel che dice la tv”. Però mai
come oggi il pubblico ha tanto diffidato dell’informazione che pretende di essere obiettiva, non faziosa, o super partes.
Fra le tante ragioni per cui ciò è accaduto, ve ne è una che forse meriterebbe maggiore attenzione, e forse maggiore vigilanza: l’informazione main stream è diventata subdola. Ossia non conduce le sue battaglie fondamentali in campo aperto,
dichiarando esplicitamente da che parte sta, ma manipolando il flusso delle notizie. Un’arte che, con il tempo, si è arricchita di strumenti via via più potenti (e pericolosi).
Un posto importante, in proposito, è occupato dalla sistematica censura delle notizie gravemente dissonanti, condannate a vivere solo su fogli minori, per ciò stesso considerati estremisti, inaffidabili, o semplicemente irrilevanti. Ma un posto forse ancora più importante è costituito dall’uso, cosciente e intenzionale, di termini inappropriati e fuorvianti per descrivere i fatti della realtà.
Il modo di chiamare le cose è importante, perché può suscitare sentimenti e giudizi, ma proprio per questo è essenziale che non sia distorsivo. Qui si annida un pericoloso equivoco: molti giornalisti, e più in generale comunicatori, pensano di essere responsabili dei sentimenti che i loro scritti possono suscitare, e proprio per questo praticano sistematicamente la censura, la deformazione, la manipolazione terminologica. Come se chiamare le cose con il loro nome fosse legittimo solo quando la verità che il nome rivela è innocua, o non rischia di suscitare i sentimenti sbagliati, o è adatta a suscitare i sentimenti giusti.
Di questo tendenzioso uso della lingua abbiamo avuto un esempio lampante negli ultimi giorni. Tutte le maggiori testate italiane hanno tradotto il termine inglese deportation, che negli Stati Uniti è usato per indicare espulsioni o rimpatri, con il termine italiano ‘deportazione’ che nella nostra lingua ha un significato ben diverso, oltreché un sinistro richiamo alle deportazioni degli ebrei nei campi di concentramento nazisti (vedi in proposito il Dizionario Treccani, che dà due significati principali di ‘deportazione’, nessuno dei quali corrisponde a espulsioni o rimpatri). È vero che se si deve tradurre il nostro ‘deportazione’ si deve usare deportation (non c’è altra parola in inglese), ma il punto è che – nell’uso che ne fanno gli americani – deportation significa espulsione o rimpatrio, e quindi così andrebbe tradotto.
I giornalisti italiani non sono in grado di cogliere la distinzione fra rimpatrio e deportazione? No, semplicemente hanno ritenuto proprio dovere stigmatizzare le politiche migratorie di Trump, e altrettanto loro dovere non stigmatizzare le medesime politiche quando erano attuate da presidenti democratici.
Con questo non voglio dire che chi è contro le espulsioni non abbia le sue ragioni, o non abbia il pieno diritto di esporle pubblicamente. Il punto è che tali ragioni (che in parte io stesso condivido) dovrebbero essere argomentate come tali, non sostenute surrettiziamente manipolando il linguaggio per deformare l’immagine dell’avversario politico. Usare termini inappropriati (e squalificanti) per descrivere quel che l’avversario fa è una variante peggiorativa della ben nota e screditata tecnica dello straw man, ovvero criticare l’avversario mettendogli in bocca cose che non ha detto. Qui, in altre parole, non gli si fa dire quel che non ha detto, ma – chiamando con altro nome quel che ha fatto – gli si fa fare quel che non ha fatto.
E non si venga a dire che le manipolazioni della lingua sono a fin di bene, ovvero per mostrare al mondo in che orribili mani si sono posti gli americani, e rischiamo di finire pure noi. Questa obiezione è sbagliata non solo perché il compito specifico dell’informazione è dire la verità, non cambiare il mondo nella direzione prescritta dalla “linea” della testata. È sbagliata anche perché, proprio se si crede (erroneamente) che il giornalista sia responsabile dei sentimenti che suscita, è arduo non vedere che parlare di deportazioni produce almeno due effetti opposti: non solo indignazione nei già sempre indignati, ma anche ulteriore entusiasmo e odio in quanti sarebbero ben felici di vedere vere deportazioni. È amaro constatarlo, ma si può istigare all’odio anche cercando di spegnerlo.
[articolo inviato uscito sulla Ragione il 28 gennaio]