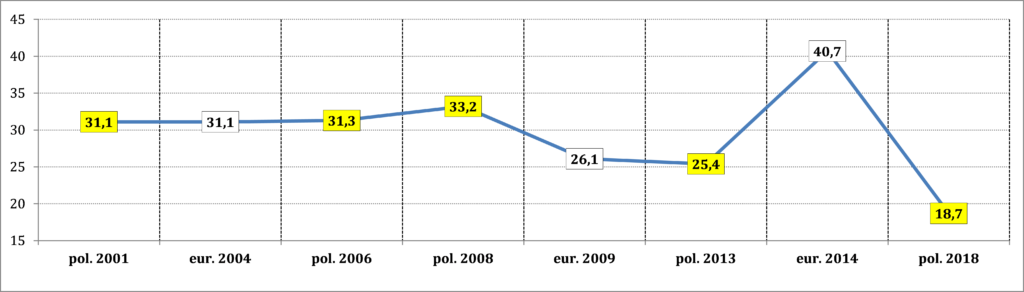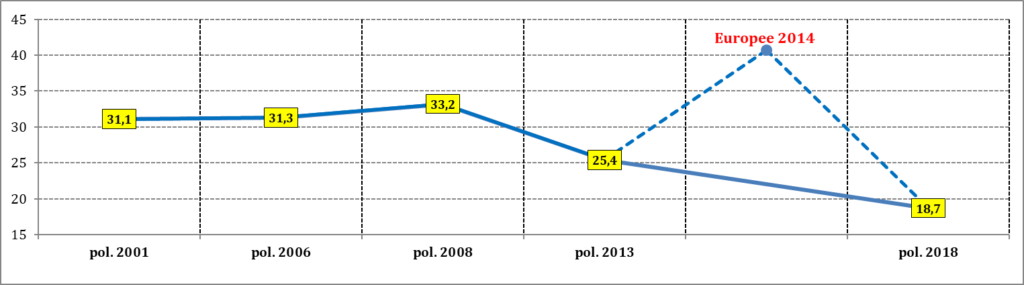Il partito che non c’è
Ma chi ha vinto il match fra Renzi e Salvini, andato in onda martedì notte a “Porta a Porta”?
Se badiamo solo all’efficacia comunicativa, credo sia solo una questione di gusto, tanto diverse sono state le due prestazioni. Alla dialettica puntigliosa e sferzante di Renzi, Salvini ha risposto nel solito modo un po’ grezzo, ma tutto sommato efficace, con cui suole cercare (e ottenere) il consenso dei ceti popolari.
Ma se andiamo alla sostanza, alla forza delle argomentazioni dei due contendenti, le cose cambiano notevolmente. Nello scontro fra “i due Mattei” non è andato in scena un match unico, più o meno dominato da uno dei due contendenti, ma sono andati in scena due match distinti, uno sull’immigrazione, l’altro sulla politica economica (e in particolare su “quota cento”).
Il match sull’immigrazione lo ha nettamente vinto Salvini, quello sulla politica economica l’ha vinto nettamente Renzi. Se pareggio c’è stato, non è perché gli argomenti dei due contendenti si sono equivalsi, ma perché ciascuno di essi ha stravinto sul proprio terreno, e perso rovinosamente sul terreno altrui.
Sull’immigrazione, e in particolare sul problema degli sbarchi, Renzi ha tentato invano di far credere che la differenza fra il numero di arrivi quando governava lui (170 mila all’anno) e il numero di arrivi quando al Ministero dell’interno c’era Salvini (meno di 9 mila l’anno) sia attribuibile al cambiamento della situazione in Libia, piuttosto che ai differenti segnali provenienti dai governi italiani in carica. Né gli è riuscito di nascondere che, sotto il nuovo governo giallo-rosso, gli sbarchi sono quasi triplicati, e che nell’ultima tragedia in mare Salvini non c’entra nulla. Così come non gli è stato possibile negare che, con i “cattivi” al governo, il numero assoluto di morti in mare è diminuito, e tanto meno nascondere che, con i “buoni” al governo, l’accoglienza sia stata un disastro. Insomma, sull’immigrazione Renzi ha mostrato di non avere idee concrete, ma solo posizioni morali e formule retoriche.
Sulla politica economica, tuttavia, le cose si sono capovolte. Specie su “quota 100” (la norma che permette di andare in pensione prima) Renzi è stato molto convincente. Le cifre che ha presentato sul costo di “quota 100” sono leggermente esagerate (20 miliardi in 3 anni), ma la sostanza del suo discorso è perfettamente corretta: quota 100 non è sbagliata in sé, ma costituisce una incredibile dissipazione di risorse pubbliche a favore di una piccola minoranza di anziani, e nemmeno dei più bisognosi. Con una cifra comparabile (9 miliardi l’anno), Renzi era riuscito a dare sollievo ai bilanci di milioni di famiglie. E, di nuovo con una cifra analoga, Renzi era riuscito – grazie alla decontribuzione – a dare un po’ di ossigeno alle imprese, e per questa via imprimere una spinta all’occupazione.
La posizione di Renzi, che considera sprecati 10 o 20 miliardi a favore di poche centinaia di migliaia di anziani, quando con la medesima cifra si potrebbero fare cose ben più utili, è tanto più giustificata se riflettiamo su una circostanza: tutti gli studi sulla diseguaglianza concordano sul fatto che l’unica vera, clamorosa e macroscopica diseguaglianza fatta esplodere dalla crisi è quella fra anziani (in particolare pensionati) e giovani (in particolare minori). I giovani hanno visto drammaticamente ridotti i redditi, le possibilità di occupazione, le prospettive future, minacciate dal declino generale del Paese, ma anche dall’aumento del debito pubblico, che oggi serve (anche) a finanziare “quota 100”, e domani dovrà essere ripagato innanzitutto dai figli e nipoti dei beneficiari degli attuali pensionamenti anticipati. Su questo Salvini non è stato in grado di replicare alcunché di convincente, esattamente come Renzi nulla di convincente era stato in grado di dire sul contenimento degli sbarchi. Dunque: su “quota 100” Renzi batte Salvini 3 a 0.
Se devo riassumere, direi: Salvini non ha in tasca la soluzione miracolosa per il problema dell’immigrazione clandestina ma, agli occhi di buona parte degli italiani (compresi molti ex elettori del Pd), ha il merito di non negare il problema, e di aver tentato una strada per risolverlo; Renzi non ha la soluzione in tasca per il problema della condizione giovanile, ma ha il merito di averne capito la centralità, e soprattutto l’assoluta priorità rispetto alle pur comprensibili aspirazioni degli anziani.
Un partito non negazionista sul problema dell’immigrazione irregolare, e capace di rompere con l’assistenzialismo pro-pensionati, sarebbe assai utile all’Italia. Perché le preoccupazioni popolari per l’insicurezza delle periferie, o per la concorrenza degli immigrati su salari e accesso al welfare, sono semplicemente sacrosante; e, d’altro canto, la sconfitta dell’assistenzialismo è una precondizione cruciale per non rendere irreversibile il declino economico e sociale del nostro paese.
E tuttavia, curiosamente, un tale partito non esiste, né a sinistra né a destra. Renzi e il Pd, dopo la marginalizzazione di Marco Minniti e la demonizzazione di Salvini, hanno dimostrato chiaramente che il problema dell’immigrazione non riescono a vederlo, e tanto meno ad affrontarlo. Lega e Cinque Stelle, d’altro canto, sono stati capaci di governare insieme solo spartendosi i rispettivi assistenzialismi: “quota cento” per soddisfare le voglie politiche di Salvini, reddito di cittadinanza per soddisfare quelle di Di Maio.
E’ come se, nello spazio politico, ci fosse posto per tutte le combinazioni, ma non per l’unica che servirebbe. C’è chi vede il problema dell’immigrazione, ma non riesce a rinunciare all’assistenzialismo (Lega e Cinque Stelle). C’è chi vede il pericolo dell’assistenzialismo, ma è cieco di fronte ai problemi dell’immigrazione (Italia viva e +Europa). E c’è, infine, chi non si nega nulla: il Pd e l’estrema sinistra non vedono né il problema dell’immigrazione, né i pericoli dell’assistenzialismo e della spesa in deficit.
A quanto pare, nonostante ci siano una decina di partiti, partitini e aspiranti-partito a sinistra, e quasi altrettanti a destra, l’unica cosa che il sistema politico italiano non sembra in grado di partorire è una forza politica che sia anti-assistenziale in politica economica, e non cieca sui problemi dell’immigrazione e della sicurezza. Una stranezza, e un vero peccato.