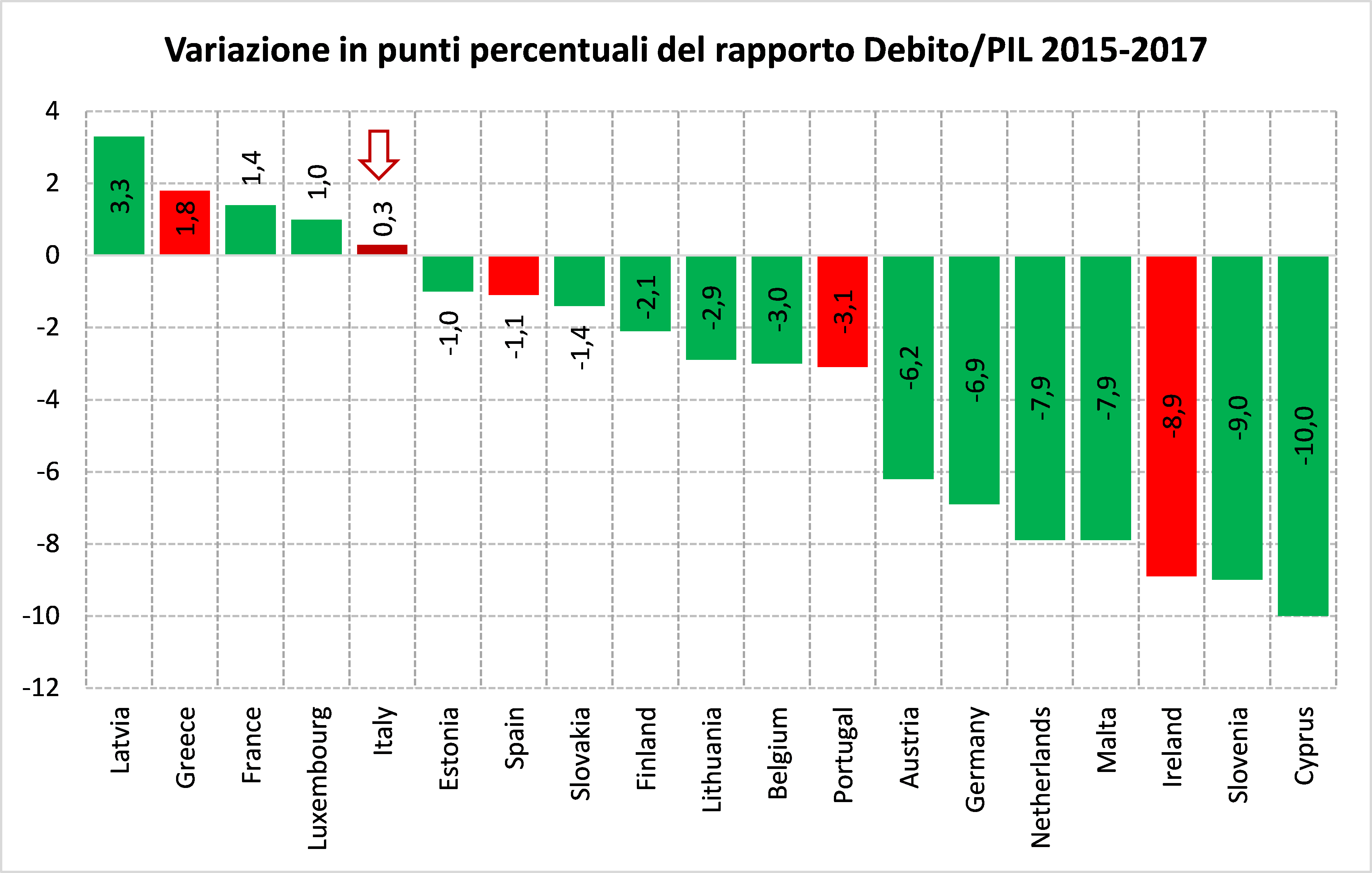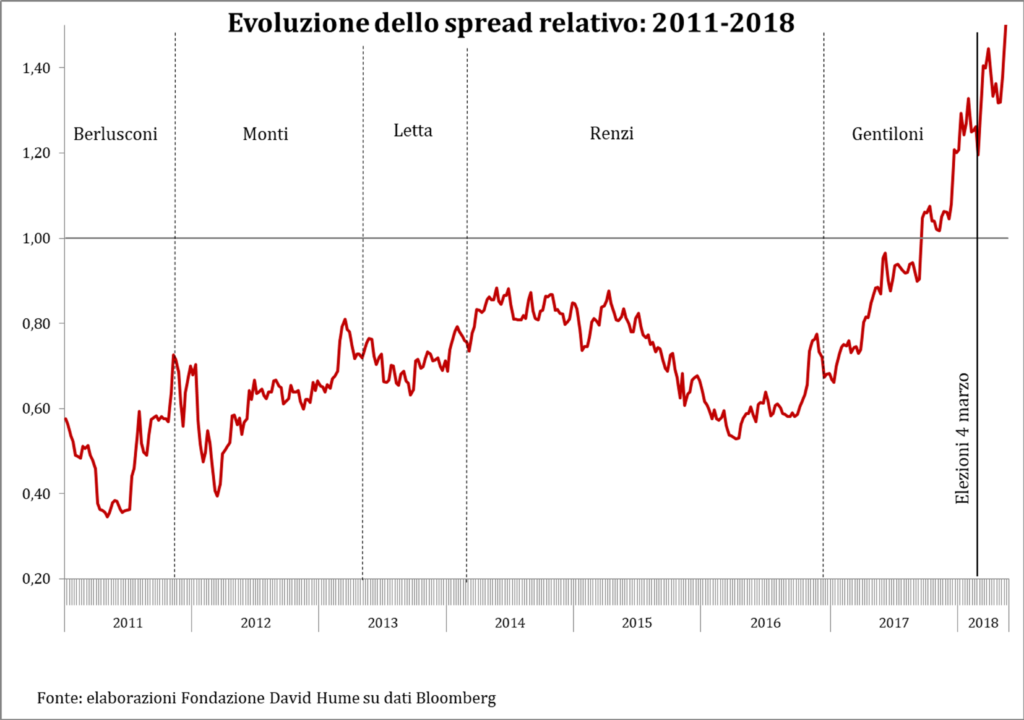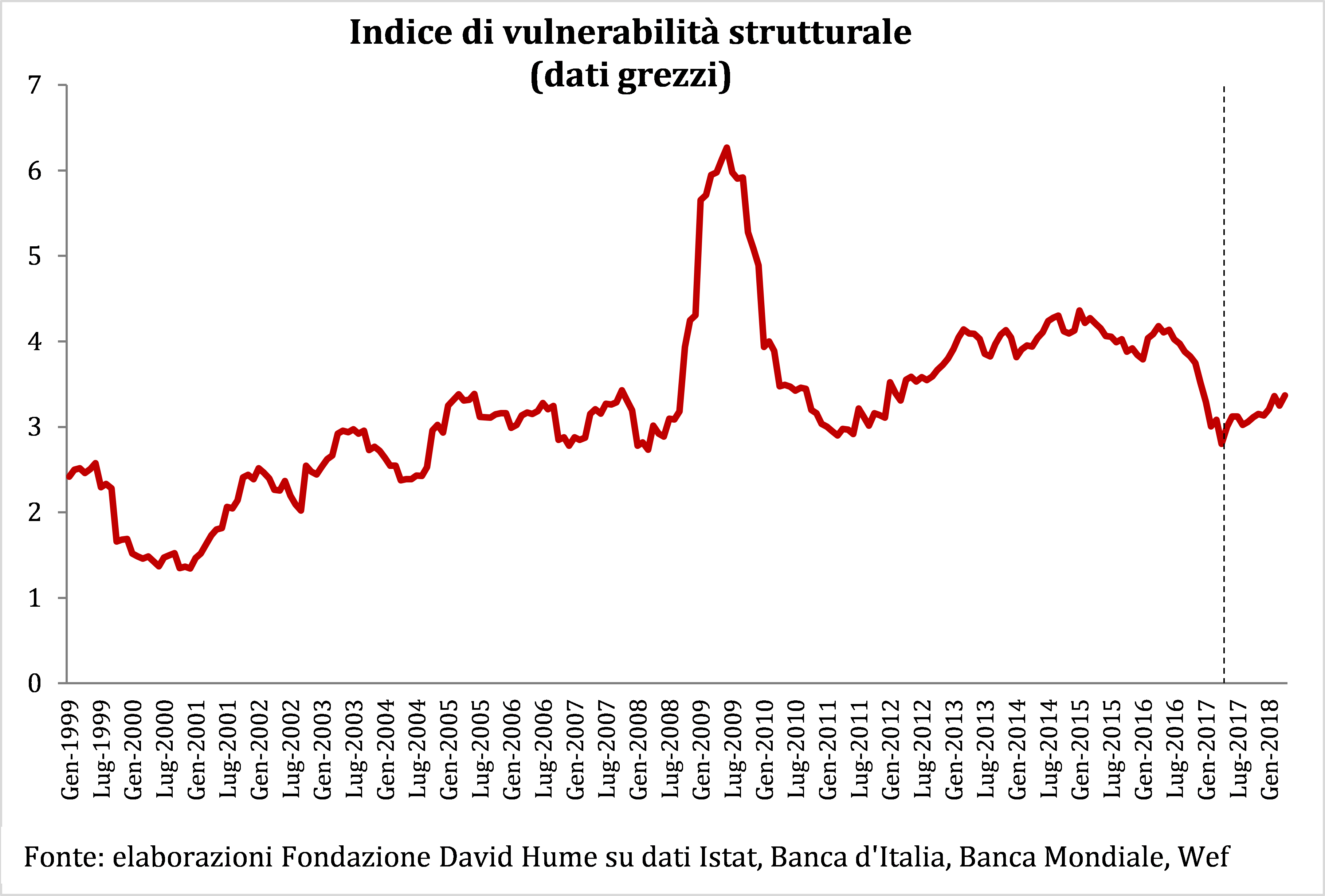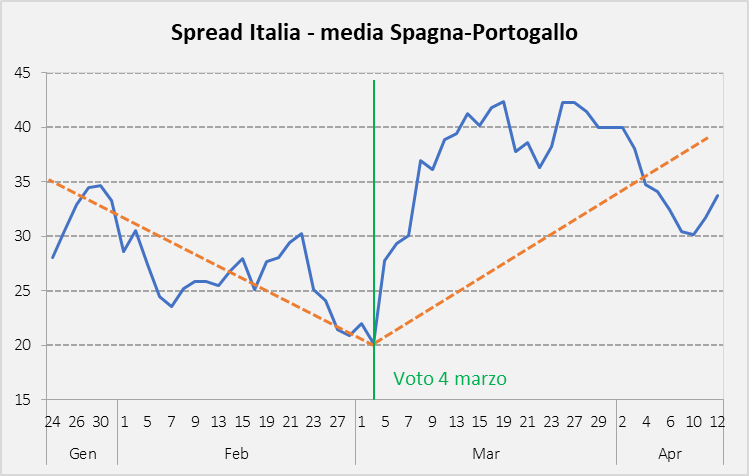Fra qualche mese si vota, ed è abbastanza chiaro fin d’ora che due saranno i temi cruciali della campagna elettorale: l’immigrazione e il (cosiddetto) reddito di cittadinanza.
Fino a qualche mese fa avrei scommesso che, fra i due, a prevalere sarebbe stato il tema dell’immigrazione. Oggi penso invece che, grazie alla determinazione del ministro Minniti (ma anche al mare grosso che immancabilmente imperversa a febbraio-marzo nel mediterraneo), gli sbarchi faranno molto meno notizia di oggi, e finiremo per parlare soprattutto di lavoro, disoccupazione, sussidi per chi il lavoro non ce l’ha. I Cinque Stelle proporranno l’introduzione del reddito minimo, ma si ostineranno a chiamarlo reddito di cittadinanza, che suona meglio. Il Pd rivendicherà il merito di aver già varato il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), che dovrebbe alleviare le sofferenze di una parte dei poveri. La destra criticherà entrambi, e punterà sull’imposta negativa, uno strumento di integrazione del reddito molto agile, e anche per questo congeniale alla cultura liberale.
Ma perché il tema del reddito minimo sta diventando così centrale?
La ragione di fondo è che il tempo conta. Nei primi anni della crisi (2007-2008) si poteva pensare che, come era successo in passato, a un certo punto la macchina dell’economia sarebbe ripartita e la disoccupazione sarebbe scesa a livelli tollerabili. Dopo lo shock del 2011-2012 mantenere questa fiducia era già diventato piuttosto difficile. Ma oggi, a dieci anni dallo scoppio della crisi, con 3 milioni di disoccupati e un tasso di occupazione ancora (sia pure di poco) al di sotto dei livelli precrisi, credere che prima o poi le cose si rimetteranno a posto diventa molto difficile. In molti pensano che di lavoro non ce ne sarà a sufficienza mai più, e che, allora, tanto valga prendere il toro per le corna: se non si può dare un posto a tutti i cittadini che desiderano mantenersi con il lavoro, almeno si garantisca loro un reddito. Il fascino discreto del reddito di cittadinanza sta tutto qui.
Questa visione delle cose non contagia solo i cittadini, ma anche gli studiosi, gli scrittori, i giornalisti. Non solo in Italia ma un po’ in tutte le società avanzate. Sono innumerevoli, in questi anni, i libri che hanno annunciato la fine della civiltà del lavoro, ora riconducendola all’inarrestabile avanzata della tecnologia, fatta di robot, intelligenza artificiale, reti neurali, internet, ora riconducendola alla finanziarizzazione dell’economia, alla globalizzazione e alle politiche di austerità (due per tutti: Martin Ford, Il futuro senza lavoro, Il Saggiatore, 2016; Guido Maria Brera, Edoardo Nesi, Tutto è in frantumi e danza, La nave di Teseo, 2017). Di qui un sottile quanto inestirpabile sentimento di rassegnazione: un’epoca è finita, gli anni della piena occupazione non torneranno mai più, i nostri figli sono destinati a vivere peggio di noi.
Eppure, a ben guardare, questo racconto delle cose è incompatibile con i dati. O meglio è compatibilissimo con i dati dell’Italia (e di alcuni altri paesi), ma non con quelli della maggior parte delle economie di tipo occidentale (i 35 paesi Ocse).
Se, come termometro dello stato di salute della civiltà del lavoro, prendiamo il tasso di occupazione, dobbiamo registrare che il suo livello, in Italia, è tuttora inferiore a quello precrisi, e questo nonostante già nel 2007 – esattamente come oggi – fosse fra i più bassi in Europa e fra i paesi Ocse. Se però guardiamo all’insieme delle economie avanzate, il quadro si capovolge nettamente. La maggior parte di esse ha non solo recuperato i livelli occupazionali del 2007, ma li ha ampiamente superati. E questo riguarda sia molti paesi europei, compresi Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Svezia, sia diversi paesi extraeuropei, come Giappone, Nuova Zelanda, Messico, Israele, Cile. Su 35 paesi attualmente aderenti all’Ocse, ben 21 hanno oggi livelli di occupazione più alti che nel 2007.
Insomma, non è vero per niente che il destino delle società avanzate sia segnato, e che l’unica strada percorribile sia dotare di un reddito anche chi non lavora. La credenza che automazione e intelligenza artificiale distruggano più posti di lavoro di quanti ne creino è, per l’appunto, una credenza, non una legge generale dell’economia. Dieci anni di instabilità economica e di spettacolari progressi tecnologici non hanno impedito a 21 paesi avanzati su 35 di aumentare i propri tassi di occupazione, spesso già molto elevati nel 2007.
Il problema è che in altri paesi, fra cui tutti i Piigs (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna), ma anche Stati Uniti, Canada, Francia, Norvegia, le cose sono andate diversamente. Alcuni, pur non avendo ancora recuperato i tassi di occupazione del 2007-2008, hanno comunque livelli di occupazione decisamente alti, sopra il 70% (nella fascia 15-64 anni). Altri, in particolare Grecia e Italia, non solo non hanno recuperato i tassi del 2007-2008, ma avevano ed hanno tassi di occupazione bassissimi, tra il 50 e il 60%. E, nel caso dell’Italia, anche un record negativo assoluto: nessun paese Ocse, nemmeno la Grecia, ha un tasso di occupazione giovanile basso come il nostro.
Forse, anziché autoconsolarsi accusando dei propri guai la globalizzazione, l’automazione e internet, i paesi nei quali il lavoro è sparito farebbero bene a riflettere sulle scelte (o le non scelte) che hanno compiuto in questi anni: perché il tramonto della civiltà del lavoro che essi sperimentano, e che pesa innanzitutto sulle nuove generazioni, è il risultato di quelle scelte.