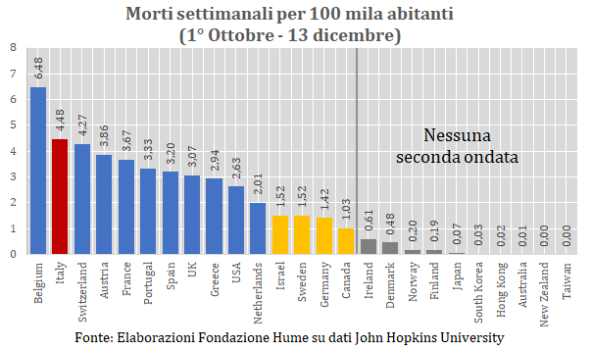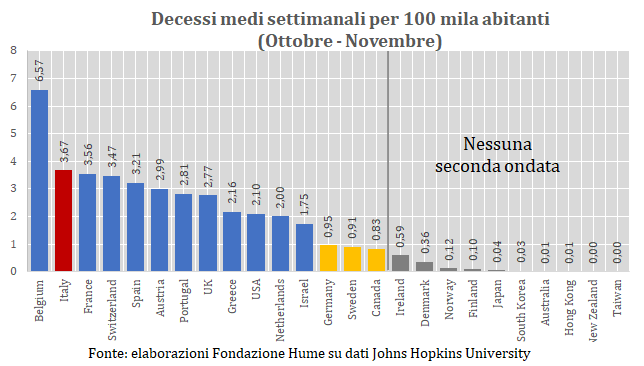Visto che il Governo – di fronte alla recrudescenza del virus – ha ritenuto, all’inizio di novembre, di procedere nuovamente con una serie di misure di contenimento dell’epidemia tali da limitare diversi diritti fondamentali dei cittadini, occorre verificare se l’Esecutivo – a questo “secondo giro” di restrizioni – ha evitato di incappare negli errori del primo, che – come detto in un precedente contributo sul tema per la fondazione Hume – sono consistiti nell’adottare, tra le altre, misure potenzialmente tali da comprimere la libertà personale (da tenere distinta rispetto alla semplice libertà di circolazione), ma senza il rispetto della riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 della Costituzione e senza che gli atti amministrativi (i DPCM) che eccezionalmente disponevano simili restrizioni senza l’intervento del Giudice fossero in qualche modo coperti da una autorizzazione contenuta in norme di legge di rango costituzionale. Per compiere questa verifica senza dilungarci in inutili ripetizioni è quindi il caso di limitarci in questa sede a riassumere i principi che – sotto il profilo costituzionale – devono guidare i poteri dello stato nel gestire le misure di reazione a situazioni di emergenza nazionale. Il lettore potrà infatti – se lo desidera – trovare nel nostro precedente contributo un dettaglio degli argomenti giuridici su cui possono essere fondati i principi in questione. Ma veniamo, appunto, all’elenco dei principi di cui si tratta.
Primo: quello che viene normalmente definito come “stato di eccezione” è figura di diritto pubblico e internazionale residuale e vicaria, che dunque non può essere invocata quando la costituzione nazionale disciplina già con apposite norme i corrispondenti casi di emergenza. Assume allora rilievo (per escludere appunto la possibilità di ricorrere allo “stato di eccezione” – eventualmente fatto risalire alla dichiarazione di pandemia dell’OMS – come fondamento delle norme che provocano limitazioni dei diritti fondamentali) la considerazione che la nostra carta fondamentale già prevede norme per disciplinare ogni possibile caso di emergenza nazionale.
Secondo: l’art. 78 Cost. tratta del caso più grave di stato di emergenza nazionale, la guerra, stabilendo la possibilità di una delega del potere normativo generale al potere esecutivo (i famigerati “pieni poteri”), ma ponendo condizioni: anzitutto è il parlamento che deve deliberare lo stato di guerra (dunque non può il Governo conferirsi da solo i pieni poteri); in secondo luogo è ancora il parlamento a decidere quali poteri conferire al Governo (dunque il Governo non può neppure decidere da sé quanto “pieni” dovranno essere, né quanto dureranno, i poteri che potrà esercitare durante il periodo bellico); infine va notato che il parlamento conferisce i poteri eccezionali al Governo nella sua collegialità (neppure in caso di guerra la Costituzione prevede dunque l’attribuzione di “pieni poteri” al Presidente del Consiglio) In sintesi: anche nella peggiore delle emergenze possibili, per i costituenti, resta ferma sia la centralità del parlamento nella decisione iniziale del conferimento dei pieni poteri al Governo (e dei relativi limiti di oggetto e durata) sia il principio che non deve esserci alcun uomo solo al comando (politico) del paese.
Terzo: per ogni stato di emergenza diverso dalla guerra dispone la seconda parte dell’art. 77 Cost., a norma del quale, qualora si dia un caso di emergenza che al Governo appare “straordinario” in termini di “necessità” e di “urgenza”, lo stesso Governo – mediante appositi atti, i “decreti legge” emanati dal Consiglio dei Ministri, controfirmati dal Presidente della Repubblica e pubblicati in Gazzetta Ufficiale – può esercitare una potestà legislativa eccezionale e provvisoria, che resta soggetta a una conferma a posteriori, entro il termine fissato dalla stessa Costituzione stessa, da parte dal Parlamento con maggioranza ordinaria (altrimenti i decreti già emessi diventano inefficaci con effetto retroattivo, salvo il potere del Parlamento – dunque non del Governo – di disciplinare le situazioni pendenti).
Quarto: la dichiarazione di stato di emergenza pronunciata dal Governo in data 31 gennaio 2020 – e poi prorogata in estate – in forza della legge sulla protezione civile [ossia del Dlgs. 2 gennaio 2018, n. 1, in particolare con riferimento all’articolo 7, comma 1, lettera c), e all’articolo 24, comma 1] non è in alcun modo idonea a spostare i termini della questione costituzionale della legittimità dei DPCM, considerando che la legge sulla protezione civile è una semplice legge ordinaria, dunque non di rango costituzionale, con la conseguenza che quella legge – e gli atti adottati in forza di quella legge – non potrebbero in alcun caso legittimamente conferire ad organi del poter esecutivo delle potestà legislative ulteriori rispetto a quelle previste espressamente dalla Costituzione.
Quinto: la stessa legge sulla protezione civile – considerando il contenuto oggettivo delle sue norme – non sembra affatto riconoscere al Governo (e tanto meno al Presidente del Consiglio o ai singoli ministri) il potere di emettere provvedimenti diversi da quelli che rientrano nella ordinaria competenza secondo la legge amministrativa e la Costituzione.
Sesto: nel valutare la legittimità costituzionale di alcune misure occorre sempre tenere distinti i provvedimenti che limitano la libertà di circolazione ai sensi art. 16 Cost. (che possono essere adottati in forza di norme con rango di legge) da quelli che limitano la libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. (che invece restano soggetti sia a riserva di legge sia a riserva di giurisdizione, dunque non possono essere adottati in forza di una norma di legge che non subordini la restrizione all’intervento – con un provvedimento ad hoc per ciascuna situazione concreta – della magistratura). A tale riguardo occorre in particolare ricordare che la Corte Costituzionale ha sostenuto a suo tempo (Sent. 68/1964) che le limitazioni alla libertà di circolazione sono certamente quelle che limitano l’accesso a determinati luoghi, ma non possono estendersi – quanto agli effetti – sino a tradursi in un obbligo di permanenza domiciliare, altrimenti trasformandosi in limiti alla libertà personale. Secondo la giurisprudenza costituzionale – in altre parole – i limiti della libertà di circolazione hanno per oggetto dei “luoghi” definiti e circoscritti il cui accesso può essere impedito ai cittadini per legge (o in base ad atto amministrativo legittimamente emanato in base ad una norma con forza e rango di legge) perché sono pericolosi, mentre se il divieto di spostamento colpisce direttamente delle categorie di persone, saremmo in presenza anche di limitazioni della libertà personale, dunque la legge (o un atto amministrativo emesso sulla base di una norma con rango di legge) non sarebbe sufficiente per adottare la limitazione in forma generale ed astratta, ma servirebbe prevedere anche un provvedimento di conferma del Magistrato che autorizzi la limitazione in concreto e in relazione al singolo caso. Sempre in applicazione di questo principio, peraltro, di limiti alla libertà personale, peraltro, si dovrebbe parlare – in forza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma quando si tratta di verificare i vulnus costituzionali – ogni volta in cui la limitazione di accesso ad una determinata zona (o di circolazione all’interno della zona) è sì strutturata in modo da riguardare formalmente dei luoghi, ma presenta estensione ed incisività tali da avere gli stessi effetti di un confinamento domiciliare delle persone che in quei luoghi si trovano a dimorare con continuità.
Settimo: secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale dei Ministri (quella formatasi in occasione dei famosi casi sui migranti che hanno coinvolto l’ex Ministro dell’Interno), la limitazione della libertà personale in forza di un atto amministrativo che viola norme di rango sovraordinato, anche quando si tratta atto formalmente legittimo perché adottato da un membro del Governo in forza di una norma di legge, può comunque dar luogo a sequestro di persona (aggravato da abuso di potere) e, più in generale, soggiacere al sindacato del giudice penale, che – previa autorizzazione parlamentare a procedere per reati ministeriali – può conoscere delle fattispecie criminose eventualmente integrate, di fatto “disapplicando” anche ai fini penali – in presenza di una norma sovraordinata in senso difforme – la norma che autorizza l’emissione dell’atto amministrativo (formalmente legittimo ma) che contravviene alla norma sovraordinata.
Ottavo: il DPCM è un atto amministrativo, dunque – a voler ritenere che, quanto meno per le procedure di impugnazione, prevalga la forma sulla sostanza – è atto che resta sottratto, per un verso, al controllo previo di costituzionalità prima facie attuato per mezzo della controfirma del Presidente della Repubblica e, per altro verso, al sindacato della Corte Costituzionale, essendo viceversa annullabile dal Giudice amministrativo e disapplicabile dal Giudice civile ordinario nei casi in cui limita diritti soggettivi (oltre che da quello penale, quanto meno secondo l’interpretazione di cui abbiamo detto nel punto sette qui sopra, anche).
Svolte queste necessarie premesse, vediamo ora di analizzare più in dettaglio la struttura degli atti e il contenuto delle norme con cui – all’inizio di novembre – sono state create le famose “zone” di rischio a colore differenziato del territorio nazionale. Partiamo col dire che l’impianto di queste nuove misure è in certa misura diverso da quello precedente (e che, per questa ragione, in parte risolve alcuni problemi costituzionali che affliggevano in particolare le misure restrittive valide per la prima fase dell’emergenza e contenute nei primissimi DPCM della primavera scorsa), mentre – sotto altri profili – i nuovi provvedimenti ricalcano il modello di quelli vecchi e dunque ne ripropongono le criticità.
Il nuovo DPCM – entrato in vigore il 4 novembre 2020 ha anzitutto un’efficacia limitata nel tempo, pari a un mese, di guisa che alla scadenza dovrà essere adottato un nuovo DPCM. Il DPCM dispone due gruppi di restrizioni: alcune riguardano tutto il territorio nazionale e sono entrate in vigore automaticamente per effetto del DPCM stesso, altre – pure definite dal suddetto DPCM – hanno invece valenza solo regionale ed entrano in vigore, sempre automaticamente, in ragione della classificazione della singola regione (a seconda del livello di rischio). La classificazione delle regioni è variabile nel tempo ed è demandata al Ministero della Salute, che provvede con decreto ministeriale, d’intesa con i presidenti delle regioni, sulla base di una complessa serie di indici (si tratta di 21 parametri che si basano su indici e dati medici e di altro genere che si trovano contenuti nel documento condiviso con la Conferenza delle Regioni e titolato “Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno-inverno” allegato al DPCM). I provvedimenti ministeriali di classificazione del rischio sono soggetti a una verifica dei dati su base settimanale, in vista di una loro modifica, ma durano in vigore almeno 15 giorni dall’adozione. Veniamo ora al contenuto delle misure.
Per l’intero territorio nazionale, il DPCM prevede diverse restrizioni: limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, salve ragioni di lavoro, necessità o salute (c.d. “coprifuoco”); chiusura di mostre e musei; didattica a distanza al 100% per scuola secondaria, salva attività di laboratorio; attività in presenza per asili, primarie e secondarie di primo grado (scuole medie), con utilizzo di mascherine, salvo per bambini al di sotto dei 6 anni; chiusura esercizi commerciali, nelle giornate festive e prefestive, dei centri commerciali salvo per le farmacie, negozi di generi alimentari, tabacchini ed edicole presenti nella struttura; 50% di occupazione massima della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale; chiusura bar e ristoranti dalle 18, con possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica; sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati (comprese le procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) salvo per i casi in cui la valutazione vada effettuata solo su basi curriculari ovvero in modalità telematica; chiusura giochi e scommesse presso bar e tabaccherie; consentiti eventi e competizioni (che siano riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto ma senza la presenza di pubblico; “raccomandazione” (ma non obbligo) di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
Al Ministro della Salute – come si diceva – è affidato il compito di regolare l’entrata in vigore di eventuali ulteriori misure restrittive nelle aree dove la diffusione del virus risulta più elevata e le strutture sanitarie più congestionate, classificando – con decreto ministeriale – le regioni in tre “zone di rischio” connotate ciascuna da un diverso colore, cui corrispondono diversi livelli – crescenti – di restrizioni.
Zona gialla: regioni a livello di rischio moderato, in cui si applicano solo le limitazioni a valenza nazionale indicate in precedenza.
Zona arancione: Regioni a criticità medio-alta, per cui sono previste le seguenti misure aggiuntive rispetto a quelle valide su scala nazionale: divieto di spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo per comprovate esigenze di lavoro, salute e casi di necessità e urgenza); quanto alla didattica, sono consentiti solo spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e nei limiti in cui la stessa risulta consentita; in ogni caso vi è la possibilità di rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza; vietato ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità e urgenza o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; sospese le attività dei servizi di ristorazione, salvo mense, catering e ristorazione con asporto e con consegna a domicilio.
Zona rossa: zona a criticità più elevata, per cui valgono le seguenti misure aggiuntive: divieto di ogni spostamento – non solo in entrata e in uscita dalla Regione e dei confini del comune di residenza, domicilio o abitazione – ma anche all’interno del territorio comunale stesso, salve comprovate esigenze lavorative, di salute ovvero necessità e urgenza; chiusura per i negozi di commercio al dettaglio, ad eccezione di generi alimentari, farmacie, edicole; chiusura dei mercati di generi diversi da quelli alimentari; divieto di attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, salva la ristorazione con consegna a domicilio e, ma solo fino alle ore 22.00, quella con asporto e – in questo caso – con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; consentita l’attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza personale di almeno un metro e con obbligo di mascherina; consentita l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; sospesi eventi e competizioni di enti di promozione sportiva; consentita l’attività scolastica in presenza solo per asili, scuola primaria e prima media; consentite le attività inerenti servizi alla persona; i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.
Questa essendo la sostanza delle nuove misure, vediamo di concentrarci su quelle che appaiono più “problematiche” in termini di diritti fondamentali, che sono il “coprifuoco” dalle 22 alle 5 su tutto il territorio nazionale, il divieto di spostamento tra diverse regioni e/o comuni nelle zone arancioni e, infine, il “confinamento domiciliare” all’interno delle zone rosse. In relazione a tutte queste ipotesi – per cui valgono sempre le eccezioni delle esigenze lavorative, di salute e di altre “necessità” e “urgenze” – si ripropone infatti il problema della riserva di giurisdizione (non garantita dai DPCM, ma) prevista dalla Costituzione per le limitazioni della libertà personale.
Si tratta di un problema che lo stesso Governo ha tentato a suo modo di risolvere quando – dopo un primissimo periodo in cui i suoi DPCM sono risultati “non coperti” da alcuna norma con forza di legge – ha emanato una serie di decreti legge che autorizzavano la successiva adozione, con atto amministrativo, di misure generali di contenimento dell’epidemia. Nelle norme contenute in questi decreti legge (si veda in particolare l’art. 1.2 del Decreto Legge n. 19 del 2020) si menziona infatti espressamente la possibilità di limitare la libertà di circolazione (dunque non la libertà personale), affermando però che queste limitazioni di libertà di circolazione potrebbero essere adottate anche “prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”. Questo significa – in sostanza – che il Governo, in veste di legislatore delegato, ha sostenuto nei suoi decreti legge che rappresenterebbe una “semplice” limitazione della libertà di circolazione (e non dunque anche della libertà personale) il fatto di porre limiti agli spostamenti dei cittadini di incisività tale da tradursi in un divieto di allontanamento “senza giusta causa” dal proprio domicilio o dalla propria dimora.
Tali decreti sono stati poi convertiti dal Parlamento, che dunque ha fatto propria la tesi del Governo. E’ tuttavia evidente che né il Governo (e tanto meno il legislatore in sede di conversione) hanno competenza a fornire una interpretazione autentica alle norme della Costituzione, e che neppure possono decidere da sé quali libertà una norma restrittiva comprime, essendo entrambi tenuti al pieno rispetto delle regole e dei principi costituzionali per come definiti e interpretati nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Va tuttavia aggiunto che il fatto che sia i decreti legge sia le leggi di conversione siano stati controfirmati dal Presidente della Repubblica senza sollevare rilievi significa che il punto di vista del Quirinale è che si tratti di misure – quanto meno secondo una valutazione prima facie – legittime, dunque che anche il Capo dello Stato ritiene non manifestamente infondata la tesi del Governo e del legislatore secondo cui quel tipo di restrizione – per quanto “forte” – potrebbe rappresentare una semplice limitazione della libertà di circolazione e non anche della libertà personale.
Nonostante l’autorevolezza dell’avallo del Quirinale, resta il fatto che – guardando tuttavia ai già citati principi elaborati in passato sul tema dalla giurisprudenza costituzionale – resta lecito sostenere una tesi diversa, ossia che la sola misura certamente legittima (a voler ritenere che il DPCM del 3-4 novembre possa avere forza e valore equiparato ad una legge, per effetto appunto della “copertura” fornita dai decreti legge convertiti dal parlamento) sia quella che limita lo spostamento tra diverse regioni (o tra diversi comuni della stessa regione) quando in almeno uno dei due territori esiste un rischio sanitario classificabile almeno nella categoria “arancione”. In queste ipotesi, in effetti, si limita la libertà di spostamento – dunque la libertà di circolazione – secondo criteri territoriali e sulla base del grado di pericolo rilevato nei relativi territori. Questo consente di sostenere che limitazione alla circolazione non dissimula un limite alla libertà personale e, dunque, incontra solo una riserva di legge, di guisa che con tutta probabilità – a voler ritenere, come pare di potersi fare, che l’ultimo DPCM sia atto “autorizzato” dai decreti legge precedenti – saremmo in presenza di una limitazione alle libertà personali disposta secondo procedure istituzionalmente corrette e con atti legittimi sotto il profilo costituzionale.
Più problematica appare la situazione con riferimento alle misure del cosiddetto “coprifuoco” (divieto di uscire di casa tra le 22 e le 5 su tutto il territorio nazionale) e del “confinamento domiciliare” (divieto di abbandonare senza giusta causa la dimora o il domicilio se si trova nelle regioni “rosse”). Anche in relazione a simili restrizioni, come si è visto, il Governo ha ritenuto di potersela cavare – con l’appoggio del legislatore e con l’avallo del Colle – sostenendo che si tratterebbe sì di limiti più incisivi, ma pur sempre alla sola libertà di circolazione. In realtà, come si diceva, si potrebbe sostenere anche che si tratta di restrizioni che – per quanto facciano salva la possibilità di spostarsi per ragioni di lavoro, salute o casi di necessità e urgenza – si sostanziano in vere e proprie limitazioni di libertà personale destinate a colpire categorie di soggetti (piuttosto che non determinati luoghi o territori) e che di conseguenza – rientrando nel disposto dell’art. 13 Cost. – dovrebbero restare soggette a riserva non solo di legge ma anche di giurisdizione. Il che le renderebbe illegittime anche a voler ritenere che al DPCM del 4 novembre sia attribuito valore e forza di legge per effetto della “delega” di adottare quelle misure concessa con i decreti legge precedenti. Si noti in particolare che l’esistenza delle tre “eccezioni” previste dai DPCM sia per il coprifuoco che per il confinamento domiciliare non pare poter mutare di molto la sostanza delle cose, essendo evidente che obbligare un cittadino a non poter uscire di casa se non per “lavorare”, “curarsi” o “far la spesa nelle vicinanze” e soddisfare altre “necessità urgenti”, significa limitare in misura assai significativa la sua libertà personale. Per capire che le cose stanno in questi termini basta infatti considerare che regimi di “libertà ridotta” di questo genere appaiono (oltre che compatibili con certe forme di schiavitù conosciute nella storia, anche) piuttosto simili al regime che connota alcune misure alternative all’esecuzione delle pene detentive. Tutto questo per dire che, in relazione al coprifuoco notturno nazionale e al confinamento domiciliare in zona rossa, resta assai concreto il rischio di una loro illegittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione della riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 Cost., anche a voler ritenere che si tratti di misure espressamente autorizzate dai precedenti decreti legge.
Ma veniamo ora proprio alla questione – più generale, ma molto importante – del valore, in termini di gerarchia della fonti, del DPCM del 4 novembre. La domanda fondamentale da porsi – come dovrebbe ormai essere chiaro – è infatti se questo DPCM può avere forza cogente pari a una legge, per l’effetto potendo legittimamente comprimere – quanto meno – le libertà fondamentali (di circolazione, di istruzione e di iniziativa economica) soggette a semplice riserva di legge. La risposta alla domanda dipende ovviamente dalla norma su cui quel DPCM si fonda.
Come abbiamo visto, la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della legge sulla protezione civile – sia perché le norme di quella legge non depongono in tal senso sia, e soprattutto, perché si tratta di legge ordinaria e non costituzionale, che dunque non può derogare alle disposizioni della carta fondamentale che tracciano la gerarchia delle fonti del diritto – non consente di attribuire ad alcun organo del potere esecutivo poteri legislativi differenti rispetto a quelli ordinariamente previsti dalla Costituzione. Dunque il DPCM, se fosse stato emesso dal Governo esclusivamente nell’esercizio di poteri fondati su quella dichiarazione o su quella legge, non potrebbe derogare ad alcun diritto costituzionale soggetto a riserva di legge.
A sua volta, come pure abbiamo visto, la Costituzione prevede, in ogni caso di necessità e urgenza diverso dalla guerra, che il potere emergenziale di legiferare attribuito all’Esecutivo sia esercitato sotto forma di decreto legge. Il che esclude ogni possibilità di sostenere che i DPCM possano risultare in qualche modo “coperti” – sotto il profilo della legittimità delle limitazioni ai diritti fondamentali – dallo stato di eccezione (eventualmente fondato a sua volta sulla dichiarazione di pandemia da parte dell’OMS).
Le considerazioni che precedono inducono dunque a ritenere che, per capire se le restrizioni contenute nell’ultimo DPCM siano legittime costituzionalmente, occorre in realtà verificare se le corrispondenti norme del DPCM siano o meno “coperte” da almeno uno dei decreti legge, tra i tanti che sono stati emessi nei mesi passati per la gestione dell’emergenza Covid. Si tratta di una verifica resa in certa misura più complicata del dovuto dal fatto che lo stesso DPCM, nel suo preambolo, menziona in pratica tutti i decreti emessi sino ad ora dal Governo e convertiti dalle Camere (tra i quali anche – in particolare – i Decreti Legge n. 6 e 19 del 2020, entrambi convertiti dal Parlamento), aggiungendovi – giusto per non farsi mancare nulla – la già citata legge sulla protezione civile (con relativa dichiarazione di stato di emergenza e rinnovo) così come due atti di indirizzo politico parlamentare e, infine, la dichiarazione di pandemia dell’OMS.
Quel che si può a mio avviso ragionevolmente sostenere è che le misure restrittive contenute nel DPCM del 4 novembre si fondano sulla “delega” – e dunque sull’autorizzazione – a limitare le libertà dei cittadini che si trova contenuta nel Decreto Legge n. 19/2020, poi convertito dalle Camere. Il che induce a ritenere che – in questo caso – quel DPCM sia sì un atto legittimo nella parte in cui dispone le misure restrittive, ma solo nella misura in cui tali misure limitano diritti soggetti a semplice riserva di legge e non anche quelli che incontrano una riserva di giurisdizione. Questo significa – in ultima analisi – che anche in relazione al nuovo DPCM del 4 novembre, così come si era visto per gli atti emessi nella primavera scorsa, il vero punctum dolens è rappresentato da misure restrittive (il coprifuoco notturno e il divieto di allontanamento da dimora o domicilio, salvo specifiche esigenze, all’interno delle zone rosse) in relazione alle quali esiste – come si è visto – un serio dubbio che si tratti di limitazioni di libertà personale e non della sola libertà di circolazione.
Ritenere che simili misure implichino anche limitazioni alla libertà personale (e non solo alla libertà di circolazione) implicherebbe importanti conseguenze sul piano giuridico. La prima è che le norme dei decreti legge convertiti che – sul presupposto che simili misure rappresentino solo ipotesi di limitazione della libertà di circolazione (ad esempio il già citato art. 1.2 del DL n. 19/2020 così come la corrispondente parte della legge di conversione) – hanno autorizzato l’Esecutivo a disporre con atto amministrativo generale e astratto il coprifuoco e/o i divieti di allontanamento dalla dimora o dal domicilio potrebbero essere impugnate – mediante rimessione di questione incidentale da parte di un qualunque Giudice chiamato ad applicare gli atti sanzionatori nel frattempo irrogati per la loro violazione – dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 13 Cost., nella misura in cui, appunto, si potrebbe trattare di norme che hanno attribuito all’Esecutivo un potere (quello di limitare la libertà personale con atto amministrativo) che invece, secondo la norma costituzionale da ultimo citata, avrebbe dovuto essere concesso solo richiedendo un intervento autorizzativo della magistratura. Va da sé peraltro che l’eventuale declaratoria di parziale incostituzionalità dei Decreti Legge e delle leggi di conversione avrebbe – a sua volta – importanti ripercussioni a diversi livelli dell’ordinamento.
L’incostituzionalità del conferimento del potere di adottare certi provvedimenti si rifletterebbe infatti anzitutto in una annullabilità da parte del giudice amministrativo, nella parte de qua, degli atti amministrativi conseguenti a quel conferimento: non solo dunque le norme dei DPCM che prevedono quelle misure, ma anche gli atti derivati con cui sia stata irrogata una sanzione per la loro violazione. Inoltre, considerando che l’eventuale esercizio illegittimo dei poteri pubblici in questi casi inciderebbe certamente su diritti soggettivi, gli atti amministrativi in questione (anche qui: tanto il DPCM quanto gli atti che hanno irrogato sanzioni) saranno disapplicabili dal giudice ordinario, ad esempio ai fini dell’annullamento delle sanzioni amministrative. Questo significa però anche, sotto diverso profilo, che qualunque conseguenza dannosa – in termini patrimoniali, morali, biologici o psicologici – eventualmente causata ai cittadini per effetto della corrispondente parte del DPCM o degli atti sanzionatori successivi, rappresenterà ipotesi di danno ingiusto risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del codice civile, dunque autorizzando una condanna per danni nei confronti degli enti pubblici coinvolti. Restano invece ancora tutte da chiarire – specie in caso di azioni civili per danni da parte dei cittadini contro lo stato o contro singoli esponenti dell’Esecutivo – le possibili conseguenze in termini di danno erariale dell’eventuale annullamento e/o illegittimità dei provvedimenti di cui si è detto.
Conseguenza ultima (e per certi versi estrema) dell’eventuale illegittimità costituzionale della parte del DPCM del 4 novembre che ha disposto il coprifuoco e il divieto di allontanamento ingiustificato dalla dimora in zona rossa sarebbe peraltro anche l’illegittimità della limitazione della libertà personale provocata dall’attuazione di questi provvedimenti, con possibilità di procedere – anche con iniziativa d’Ufficio – all’apertura di indagini penali (ad esempio per sequestro di persona con abuso di autorità, almeno a voler seguire la più recente giurisprudenza del Tribunale di Ministri in relazione ai noti casi relativi ai migranti). Naturalmente si tratterebbe di reati ministeriali, dunque vi sarebbe in ogni caso, per gli inquirenti eventualmente intenzionati a procedere contro membri del Governo, la necessità di richiedere una previa autorizzazione delle Camere. Proprio in questo senso a mio avviso va letto il fatto che il Presidente del Consiglio, nel preambolo del DPCM del 4 Novembre, abbia menzionato gli atti di indirizzo parlamentare votati nel frattempo dal parlamento: in caso di eventuale richiesta della magistratura di una autorizzazione da parte del parlamento a procedere penalmente contro membri dell’Esecutivo, il Governo potrebbe infatti usare quegli atti di indirizzo politico che sostenere di aver agito nell’ambito di un mandato politico, dunque sottraendosi al sindacato della giustizia penale. Va però precisato che il Parlamento – quando decidere di una autorizzazione a procedere – agisce con discrezionalità politica, di guisa che una “garanzia” per il Governo che il parlamento decida su eventuali future autorizzazioni a procedere in modo coerente ai suoi atti di indirizzo politico precedenti è in realtà una garanzia che vale solo sino a quando la maggioranza parlamentare è la stessa che ha adottato l’atto di indirizzo politico.
Infine – trattandosi di Decreti Legge e Leggi di conversione che sono state controfirmate senza rilievi dal Presidente della Repubblica – nel caso in cui la Corte Costituzionale dovesse mai giungere alla conclusione che le norme in questione rappresentavano una violazione dell’art. 13 Cost. – si aprirebbero inevitabilmente accesi dibattiti circa il fatto che vulnus alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. fosse anche “chiaramente evidente” già al momento dell’adizione dei decreti e della loro conversione, di guisa che il Capo dello Stato ben avrebbe potuto (ma anche – a quel punto – dovuto) esercitare le proprie prerogative per rimandare la legge alle Camere in seconda lettura. In una simile evenienza andrebbe tenuto peraltro in adeguato conto, da un lato, che l’esistenza di una situazione di grave emergenza nazionale – e dunque l’opportunità di lasciare che il Governo reagisse celermente – potrebbe giustificare una minore propensione del Presidente della Repubblica ad esercitare i propri poteri di controllo (rispetto a casi in cui in passato alcuni provvedimenti – oggettivamente ben più “blandi” sotto il profilo del potenziale vulnus costituzionale – sono stati invece rinviati alle camere in seconda lettura). Per altro verso è innegabile che, già al momento della loro adozione, era piuttosto evidente che misure restrittive tanto incisive ed estese, non solo avrebbero limitato pesantemente le libertà fondamentali di milioni di cittadini, ma avrebbero avuto ricadute – in termini economici, di flessione della domanda interna e soprattutto di occupazione – tali da mettere in serio pericolo l’equilibrio dei conti pubblici e la tenuta dell’economia nazionale. Tutto questo per dire che, con ogni probabilità, il vero fulcro del problema – anche in relazione alla questione del potere di controllo del Presidente della Repubblica sulle misure emergenziali – resta quello di capire se le misure più estreme contenute nel DPCM del 4 novembre rappresentano – secondo una valutazione sommaria e dunque prima facie – una “semplice” limitazione della libertà di circolazione e non anche una vera e propria restrizione della libertà personale.
Personalmente ritengo che sollecitare una serena ma rigorosa verifica nelle sedi competenti – dinanzi alle differenti articolazioni della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e costituzionale – circa il fatto che le istituzioni dello Stato, dinanzi a una situazione emergenziale, abbiano saputo sempre tenere distinte le limitazioni alla libertà di circolazione (e delle altre libertà soggette a semplice riserva di legge) da quelle che incidono anche sulla libertà personale dei cittadini (e che invece – così come per l’inviolabilità del domicilio – richiedono sempre l’intervento di un giudice “terzo” anche in presenza di gravi emergenze nazionali diverse dagli eventi bellici) non sarebbe esercizio di sterile. Si tratta anzi di un passaggio essenziale – in uno stato che voglia definirsi liberale – per mantenere saldi i principi dello stato di diritto anche in situazioni di emergenza, ossia in casi in cui – come la storia insegna (e anche i nostri padri costituenti ben sapevano) – è più probabile che i poteri dello stato incappino (più o meno consapevolmente e più o meno in nome una “buona causa”) in derive autoritarie.
Principi come la libertà personale e l’inviolabilità del domicilio – ma non diversamente dovrebbe dirsi anche del divieto di imporre trattamenti sanitari senza il consenso di chi li subisce – non sono infatti un “lusso” che lo stato concede ai cittadini solo in situazione ordinaria (cosa che invece così tanti commentatori – e purtroppo anche qualche giurista – mostrano di ritenere): sono il fondamento ultimo del nostro concetto di rapporti tra società e poteri dello stato. Qualunque stato che voglia infatti chiamarsi davvero “stato di diritto” – tema di cui in sede EU si parla spesso – dovrebbe infatti saper mantenere fermo il principio secondo cui, di fronte a certe libertà individuali, il potere pubblico non può provvedere con atti d’imperio, neppure se adottati o autorizzati dal legislatore. Nessuna maggioranza politica parlamentare ordinaria può arrogarsi il potere di limitare o eliminare certi diritti, neppure per legge, senza l’intervento caso per caso del Giudice, ossia senza l’intermediazione di un potere terzo e imparziale rispetto alle decisioni politiche. Proprio a questo serve del resto la Costituzione: a difendere certi diritti di ciascun singolo cittadini contro l’arbitrio del potere sovrano, anche quando un simile potere viene esercitato da un Parlamento. Lo stato di diritto viene prima della stessa democrazia, in quanto consente che quest’ultima non si trasformi in una tirannia della maggioranza politicamente rappresentata. E questo – si badi – vale certamente anche in situazione di emergenza. Anzi: vale soprattutto in situazione di emergenza.
Una questione di simile portata – ossia la possibile violazione della libertà personale di milioni di cittadini posta in essere dai poteri pubblici al di fuori delle dovute garanzie costituzionali – non si può dunque certo liquidare prendendo come oro colato l’espediente usato dal legislatore di affermare che limitino solo la libertà di circolazione delle misure che – consistendo in una sorta di arresti domiciliari attenutati – ben potrebbero aver anche intaccato e limitato la libertà individuale. La “parola” del Governo (così come della maggioranza che lo sostiene in Parlamento) non basta infatti per tutelare il cittadino quando l’abuso di potere potrebbe essere stato perpetrato proprio da quello stesso governo e legislatore. E anche il controllo del Presidente della Repubblica non pare sufficiente – trattandosi comunque di un controllo sommario e che viene operato da un organo nominato pur sempre da una maggioranza parlamentare – quando i diritti in gioco sono quelli davvero fondamentali per conservare lo stato di diritto. C’è poco da fare, insomma: solo la terzietà di un vero giudice – in simili casi – offre sufficienti garanzie di indipendenza.
Sollecitare una verifica da parte della magistratura sull’operato delle istituzioni di fronte all’emergenza avrebbe dunque il benefico effetto di richiamare l’attenzione di chi governa (ma anche di chi sostiene in Parlamento l’azione di questo Governo) sulla necessità di evitare che anche da noi ci si avvii sulla china che parrebbe essere stata imboccata ad esempio in Germania, paese in cui la maggioranza parlamentare sta mettendo ai voti una proposta di legge che – in caso di emergenza sanitaria – in nome della “protezione del popolo” attribuisce al potere esecutivo, per di più senza specificare limiti di durata, pieni poteri tanto intensi da consentire limitazioni – tra le altre – anche della libertà personale dei cittadini e dell’inviolabilità del loro domicilio. Per non parlare delle voci che – all’estero ma anche qui da noi – si levano sempre più di frequente per invocare un obbligo di vaccino generalizzato imposto per legge. Simili misure – che davvero rappresentano un potenziale vulnus al concetto di “stato di diritto – non appartengono alla nostra cultura giuridica. Ci si chiede peraltro perché mai l’UE, così solerte nel lamentarsi con Ungheria e Polonia per pretese violazioni della rule of law perché le rispettive legislazioni attenterebbero alla divisione dei poteri, nulla abbia da eccepire quando le derive illiberali sono poste in essere da altri stati.
In particolare proprio la proposta di legge attualmente in discussione in Germania – che viene presentata da quel governo come strumento per la “protezione del popolo” – dovrebbe far ricordare che il concetto stesso di costituzione (o quanto meno quello di costituzione rigida) si fonda sull’assunto per cui esistono diritti – quali appunto la libertà personale e l’inviolabilità del domicilio – la cui tutela contro lo stato, anzi: soprattutto contro lo stato, consente di conservare quello che noi chiamiamo “stato di diritto”. Vivere in uno stato di diritto significa vivere in un ordinamento in cui la costituzione difende alcune libertà del cittadino contro il potere dello stato, obbligando lo stato stesso – se vuole limitarle – a confrontarsi col cittadini davanti a un giudice terzo e indipendente, non potendo i pubblici poteri agire unilateralmente né con atti governativi né sulla base di leggi approvate da maggioranze parlamentare ordinaria).
Questa è del resto anche la semplicissima e chiara ragione –ormai ignorata dai più – per cui ad alcuni diritti fondamentali della persona (la libertà personale e inviolabilità del domicilio) non sarebbe comunque legittimo attribuire rango costituzionale inferiore al diritto alla salute e all’incolumità personale. E tutto questo senza ricordare che così tanti hanno sacrificato la propria vita nei decenni passati per dare a noi oggi la garanzia costituzionale della libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio che appare davvero difficile capire per quale ragioni così tanti oggi – anche tra i giuristi e politici che si dichiarano a gran voce democratici e liberali – possano sostenere a cuor leggero che la vita e la salute sono “certamente” più importanti, nella scala costituzionale, della libertà personale.
Chi teme per la salute e la vita di alcune categorie a rischio oggi vorrebbe infatti comprimere “senza se e senza ma” la libertà personale di tutti quanti, senza capire che – seguitando su questa strada – potrebbe trovarsi un giorno senza alcuna difesa legale di fronte a uno stato che – a quel punto – potrà disporre come meglio crede anche della salute (e dunque della vita) di chiunque. Suonano insomma tremendamente attuali – per quanto siano stato pronunciate ormai già più di due secoli fa – le parole di Thomas Jefferson, secondo cui “chi rinuncia alla sua libertà per la sicurezza, non ottiene nessuna delle due”. Stiamo dunque attenti, perché – dopo decenni in cui la politica ci ha abituati a gridare al fascismo o allo stalinismo di fronte a qualunque quisquilia – rischiamo alla fine di non far più caso ai “veri” segnali del fatto che – in Italia e in Europa – i principi fondamentali dello stato di diritto iniziano davvero a essere messi in discussione dalle stesse istituzioni che invece dovrebbero garantirli.