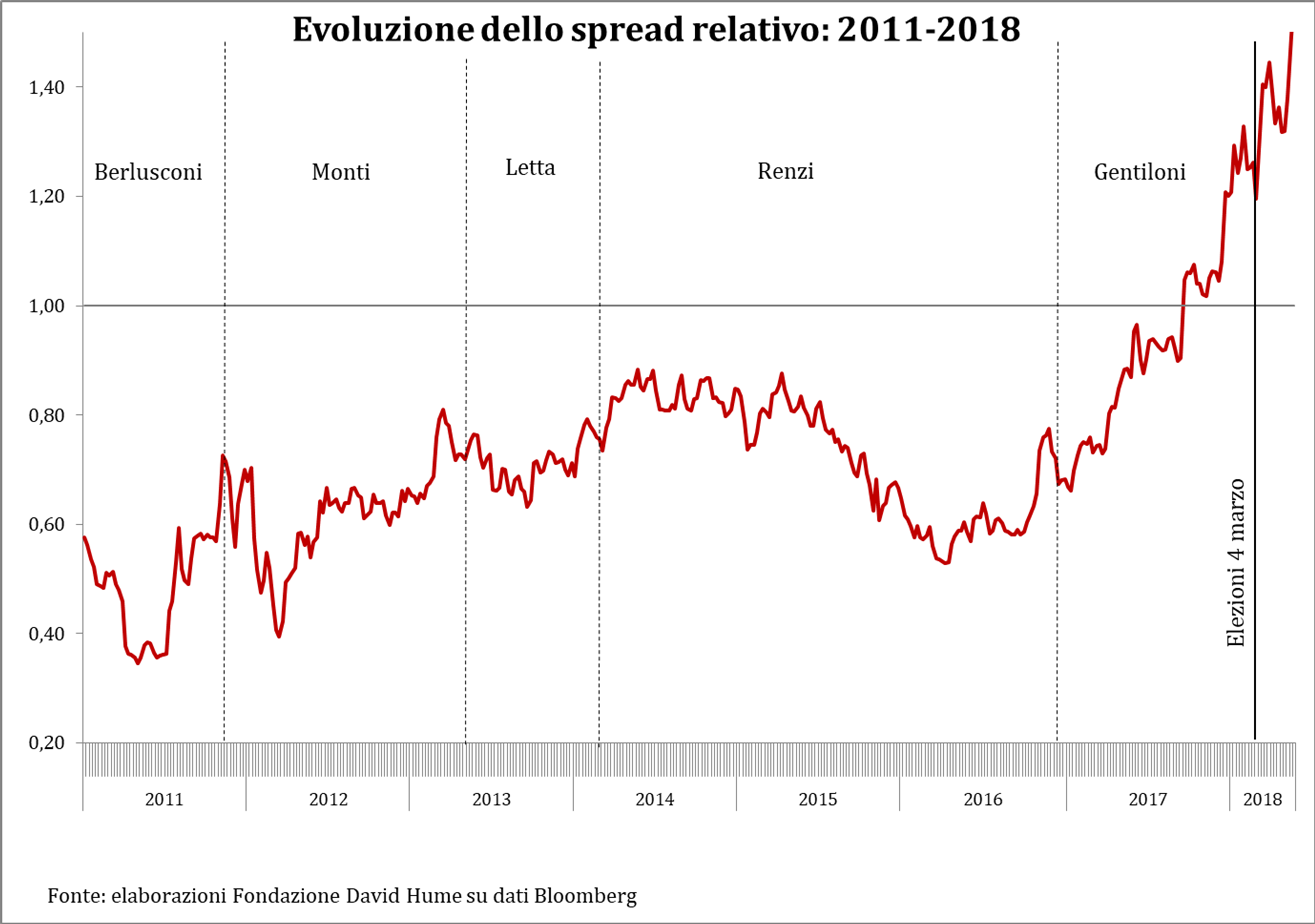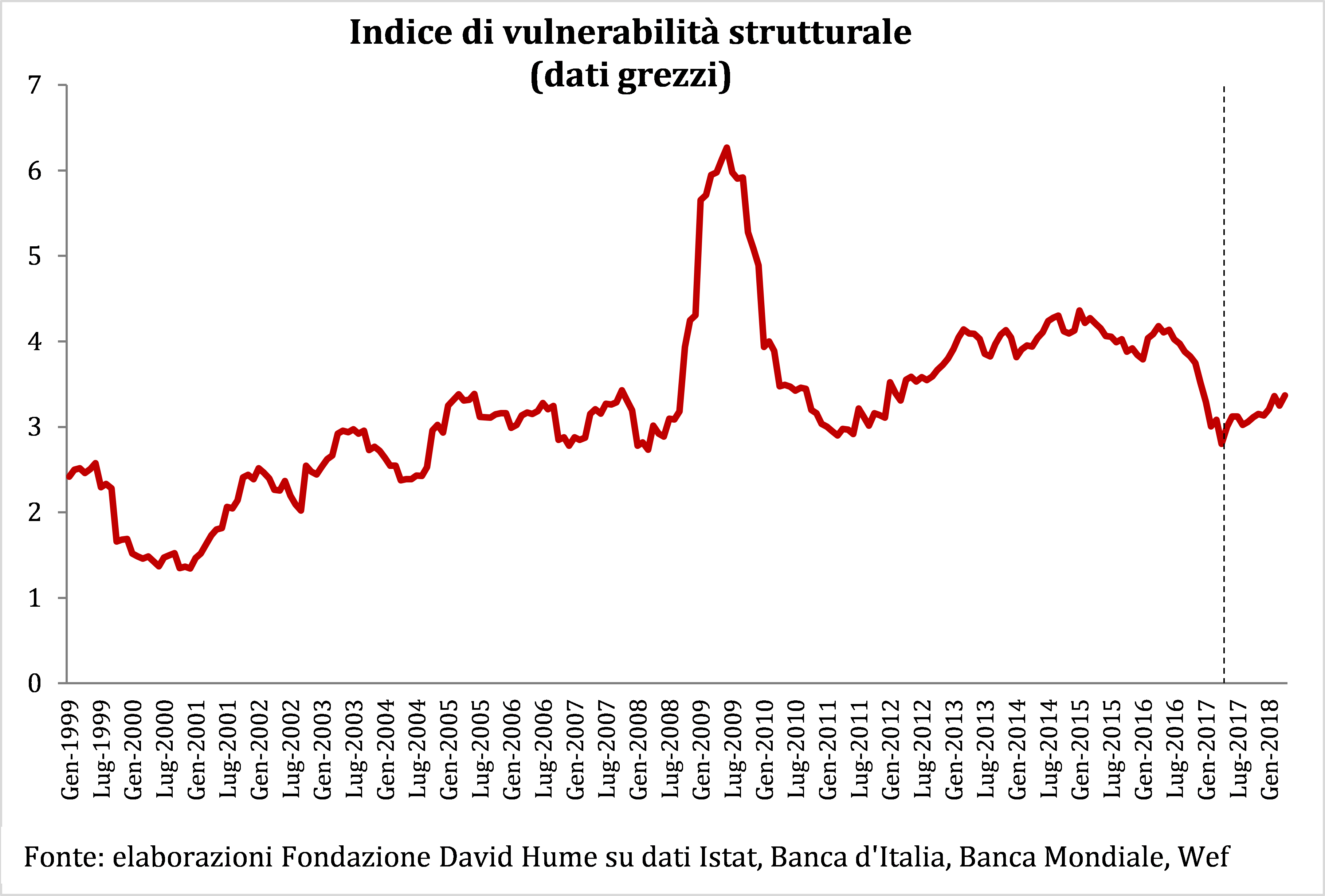Fine del sogno europeo?
I rappresentanti di una decina di paesi, fra cui (forse) anche l’Italia, si incontreranno a Bruxelles per preparare il Consiglio europeo del 28 giugno. Immersi fino al collo nelle miserie della politica nostrana, rischiamo di non renderci conto che, da come andranno questi due incontri, dipenderà il futuro dei cittadini europei, e non solo di essi. Quanto disperata sia la situazione europea lo ha invece visto lucidamente Niall Ferguson, editorialista e professore di storia, in un articolo pubblicato pochi giorni fa su “The Sunday Times”. Scettico fino a qualche tempo fa sulle ragioni della Brexit, ora si sta convincendo che non avevano tutti i torti i fautori dell’uscita dall’Unione Europea quando osservavano che uscire altro non era che scendere da una barca che affonda.
Ora quella barca potrebbe cominciare ad affondare davvero, non per l’austerità, non per le regole sul deficit e sul debito, non per i problemi della povertà e della diseguaglianza, non per disaccordi sull’unione bancaria, o sul bilancio comune, o sul costituendo Fondo Monetario Europeo. No, l’Europa rischia di affondare, più o meno lentamente, su un unico problema: la gestione dei migranti. Un problema che Ferguson descrive con un aggettivo, “intrattabile” (intractable), che i matematici riservano ai problemi per i quali non esistono strumenti, non dico per risolverli, ma nemmeno per provare ad attaccarli.
Da dove viene tanto pessimismo?
Per Ferguson l’intrattabilità del problema migratorio ha due radici. La prima è la difficoltà di far coesistere i valori culturali dell’Occidente con quelli dell’Islam. La seconda è che milioni di africani intendono raggiungere l’Europa, ma “la frontiera meridionale dell’Europa è quasi impossibile da difendere da flottiglie di migranti, a meno che i leader europei siano preparati a lasciarli annegare”. La differenza fra Europa e Stati Uniti sarebbe che all’America per evitare la guerra civile basta chiudere la frontiera con il Messico (è impensabile un’invasione dal mare), mentre questa strada è quasi impossibile da percorrere in Europa, perché il Mediterraneo è una frontiera indifendibile: uno dei tanti casi in cui è la geografia che fa la storia.
È convincente una simile diagnosi?
Per certi versi no. Se il problema è evitare la guerra civile, si potrebbe osservare che forme di guerra civile possono prender piede non solo perché si lasciano aperte le frontiere, ma anche perché le si chiude. Non so se, dopo la guerra civile per l’abolizione della schiavitù (1861-1865), vi sia mai stato nella storia americana un periodo in cui i cittadini statunitensi siano stati divisi come lo sono oggi, grazie a un presidente divisivo come Trump.
Per l’Europa, però, forse la diagnosi di Ferguson è solo incompleta, più che sbagliata. Quel che manca, a mio parere, è la risposta alla domanda: perché la classe dirigente europea è arrivata a questo punto? Perché ha dovuto attendere che in Italia andassero al potere i cosiddetti populisti per scoprire il problema migratorio? Che cosa ha fatto sì che quasi tutti i governi occidentali più illuminati (o presunti tali) abbiano sonnecchiato in questi anni?
Temo che, in ultima analisi, la risposta sia quella che, se fosse vivo, oggi darebbe Max Weber: hanno sostituito l’etica della responsabilità con l’etica dei principi (o etica della convinzione).
La classe dirigente europea si è mossa come se i valori della cultura occidentale, a partire dalla filosofia dei diritti umani, avessero validità universale, e come se il sogno cosmopolita di un’unica comunità mondiale, con le relative istituzioni e la relativa polizia internazionale, fosse già realizzato. I politici che ora faticosamente cercano di non far deflagrare l’Europa, per decenni si sono dimenticati che gli Stati esistono ancora, e che è ai cittadini degli Stati che devono rispondere, se non altro perché è dagli elettori che dipende la loro permanenza al potere. Da questa dimenticanza è scaturita la retorica con cui, in tutti questi anni, si è parlato dei migranti, trattando l’accoglienza come un dovere inderogabile, e assimilando di fatto ogni legittima aspirazione a cambiare paese come un diritto inalienabile della persona umana, valido verso qualsiasi paese e in qualsiasi circostanza.
La cosa ha funzionato finché i migranti erano veri rifugiati (come nei primi decenni del dopoguerra), o erano poco numerosi, o erano tanti ma utili alle nostre imprese e alle nostre famiglie. Ma non ha funzionato più quando l’imperativo di salvare i naufraghi si è scontrato con l’indisponibilità di vasti settori dell’opinione pubblica europea ad accogliere i migranti nel modo massiccio, disordinato e irregolare degli ultimi anni. Quel che gli elettori europei hanno cominciato a fare, in altre parole, è di richiamare i propri governanti all’etica della responsabilità: che non significa semplicemente valutare le conseguenze delle proprie azioni (in questo caso le conseguenze dell’accoglienza “senza se e senza ma”), ma valutarle innanzitutto in relazione ai cittadini da cui traggono la loro legittimazione, che non sono i cittadini del mondo ma i cittadini di uno specifico territorio, con le sue tradizioni, i suoi valori, i suoi bisogni e interessi.
È questo che, a mio parere, ha spiazzato molti governanti europei. È come se, a un certo punto, l’opinione pubblica europea avesse voluto ricordare ad ogni Capo di Stato di essere, per l’appunto, “solo” un capo di stato, non il Papa di Roma. Il quale Papa può permettersi di invitare all’accoglienza universale, ignorando le conseguenze delle sue parole sui cittadini europei, per un ottimo motivo: come ogni autorità spirituale, ogni predicatore, ogni rivoluzionario, ogni convinto sostenitore di una causa, il Papa agisce secondo l’etica dei principi, non secondo l’etica della responsabilità. La sua constituency, il suo “bacino elettorale”, è l’umanità intera, non certo quella minuscola porzione che è l’Italia o l’Europa.
La paralisi dell’Europa è anche la conseguenza di questo lungo sonno della rappresentanza. Orgogliosa di indicare la via al mondo intero, la classe dirigente occidentale (non solo europea) si è mossa come se essa fosse la guida morale del mondo, e al tempo stesso la paladina dei diritti di tutti. Ma era un film, un film girato essenzialmente per sé medesima. Gli stessi che si autoproclamavano paladini dei diritti di tutti, non esitavano a calpestare quei medesimi diritti quando interessi economici, strategici, geopolitici suggerivano l’intervento (a quante guerre umanitarie o di liberazione abbiamo dovuto assistere?) o, ancora più tragicamente, consigliavano l’astensione (ricordate i massacri del Ruanda?).
L’origine dell’ondata populista forse è anche qui. Di fronte a una classe dirigente che si autopercepisce come un’autorità spirituale, ma agisce come il più temporale dei poteri, i cittadini europei hanno cominciato a presentare il conto. La “lebbra” populista che sale in Europa, contrariamente a quanto pensa Macron, non è un morbo di origini misteriose. Quel morbo (ammesso che sia tale) è stato accuratamente coltivato nelle cancellerie europee, là dove, lentamente e quasi inavvertitamente, l’etica della responsabilità, che dovrebbe essere il faro di una vera classe dirigente, ha ceduto il passo all’etica della convinzione, che si addice ai profeti, non a chi vuole governare un continente.