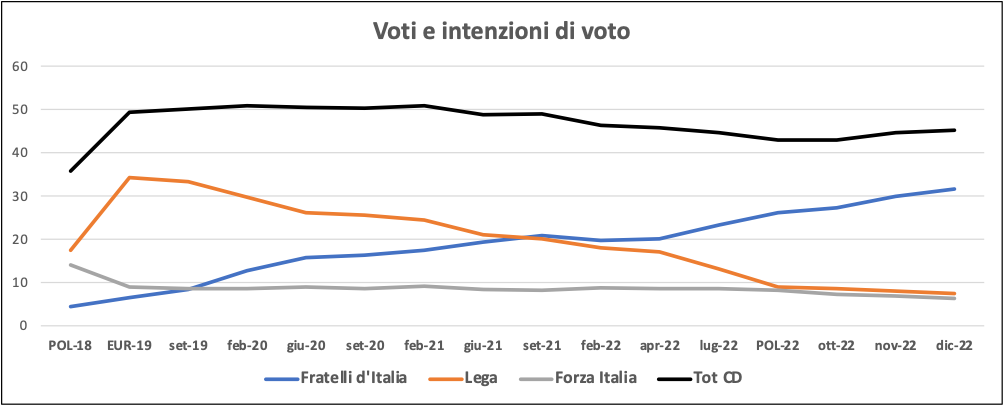Elezioni in Francia e Regno Unito – Starmer e la sinistra blu
Una settimana fa il primo turno delle elezioni legislative in Francia. Pochi giorni fa elezioni nazionali nel Regno Unito. Oggi secondo turno delle elezioni in Francia. Non ricordo vi sia stata, in Europa, una settimana più densa di appuntamenti elettorali
importanti.
Se le previsioni degli istituti di sondaggio francesi si riveleranno azzeccate, domani diremo che il Fronte Repubblicano ha fermato Marine Le Pen, così come oggi diciamo che Keir Starmer – leader dei laburisti – ha posto fine al lungo primato dei Conservatori nel Regno Unito, un primato durato ben 14 anni. L’aritmetica dei seggi dice che i laburisti hanno una maggioranza schiacciante in
Parlamento, mentre – grazie alla desistenza – il Rassemblement National potrebbe non avere abbastanza seggi per governare. Sul piano politico è tutto, perché i seggi sono l’essenziale.
Ma se quel che ci chiediamo non è chi governerà, bensì dove vadano le opinioni pubbliche dei due paesi, il quadro si fa molto meno nitido. Con i sistemi maggioritari, è normale che la distribuzione dei seggi in Parlamento e le sue variazioni nel tempo
non riflettano i movimenti profondi dell’elettorato. E talora li contraddicano. I recenti casi della Francia e del Regno Unito non fanno eccezione.
In Francia il dato di opinione cruciale è che il consenso a Marine Le Pen è al massimo storico: ai ballottaggi per le presidenziali era al 33.9% nel 2017, salito al 41.5% nel 2022. E fra il 1° turno delle Legislative 2022 e il 1° turno delle Legislative 2024 il suo consenso in termini di voti è ulteriormente salito (quasi un raddoppio in due anni). In breve: quale che sia il risultato dei ballottaggi odierni nei collegi uninominali, è verosimile che il consenso a Marine Le Pen si aggiri intorno al 50%.
Ancora più intricata la situazione nel Regno Unito. Qui il “trionfo” di Keir Starmer in termini di seggi coesiste con una modestissima avanzata in termini di voti. Nel 2019 Corbyn, il leder laburista di allora, aveva perso le elezioni con il 32.1%, oggi il suo successore le ha stravinte con il 33.7%, nemmeno 2 punti percentuali in più. In sostanza: i laburisti, con 1/3 dei voti, governeranno con 2/3 dei seggi. A ulteriore riprova del fatto che, con un sistema elettorale maggioritario, può accadere che voti e
seggi raccontino due storie profondamente diverse. Si potrebbe osservare che, quantomeno, il voto inglese segnala un netto spostamento a sinistra dell’opinione pubblica, visto che i Conservatori quasi dimezzano i loro consensi (dal 43.6% del 2019 al 23.7% attuale). Ma anche questa conclusione andrebbe ponderata e qualificata. Intanto perché il deflusso di voti dal partito Conservatore ha premiato innanzitutto il partito anti-europeo di Farage (Reform UK), che è ancora più a destra. E poi per una
ragione più fondamentale: quello che ha vinto le elezioni nel Regno Unito è un partito laburista molto particolare, diverso da quello estremista di Corbyn, ma anche (almeno in parte) da quello di Tony Blair, stella polare dei riformisti e dei teorici
della Terza via.
Il partito che Keir Starmer ha pazientemente forgiato nel corso degli ultimi anni si riallaccia, semmai, al cosiddetto Blue Labour, una componente del Labour Party nata una quindicina di anni fa con il proposito di recuperare il consenso dei “colletti blu”, e di farlo anche con idee spesso considerate conservatrici, come famiglia, fede, vita di comunità e, soprattutto, limiti all’immigrazione irregolare. E infatti, nel programma di Starmer, il controllo dell’immigrazione illegale occupa un posto tutt’altro che marginale. Il rifiuto della soluzione-Sunak (deportare i migranti illegali in Ruanda) non si accompagna a benevole proposte di apertura dei confini o di rafforzamento dell’accoglienza, ma punta semmai all’introduzione di misure radicali di contrasto degli arrivi illegali, come il conferimento alle forze dell’ordine di super-poteri, analoghi a quelli previsti nella lotta al terrorismo. Detto più esplicitamente: la critica alle politiche dei Conservatori in materia migratoria non è di principio, quanto di efficacia: siete stati 14 anni al governo, e il problema dell’immigrazione siete solo riusciti ad aggravarlo. Ecco perché la lettura dei dati britannici non è semplice.
Hanno qualche ragione i riformisti a compiacersi dell’abbandono del massimalismo di Corbyn, e del parziale ritorno alle idee di Tony Blair. Ma questa è solo una faccia della medaglia. L’altra faccia è che i laburisti hanno raccolto solo 1/3 dei consensi, e lo hanno fatto anche grazie a idee che siamo abituati a considerare ben poco progressiste.
[articolo uscito sul “Messaggero” il 7 luglio 2024]