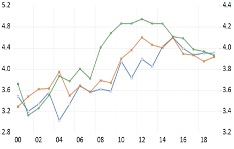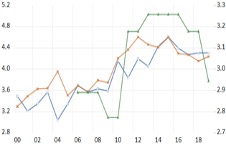La frattura tra ragione e realtà 8 / Il fallimento degli esperti di guerra – Parte seconda: Palestina
Dalla pessima gestione del Covid i governanti occidentali e gli esperti che dovrebbero consigliarli sembrano non avere imparato nulla, tant’è vero che stanno ripetendo gli stessi errori anche nella gestione di altre emergenze cruciali, come le guerre in Ucraina e Palestina, dove, continuando così, rischiamo di far vincere i nostri nemici, con conseguenze disastrose. Alla base di tutto c’è sempre la drammatica frattura tra ragione e realtà che caratterizza il nostro strano tempo e da cui non sembrano essere immuni nemmeno gli esperti di geopolitica e gli stessi vertici militari. Nel precedente articolo ho parlato dell’Ucraina, mentre in questo mi occuperò in Palestina.
Gaza: né terrorismo né genocidio, ma guerra
Le stesse dinamiche perverse che rischiano di far precipitare la situazione in Ucraina si stanno verificando anche nella guerra in Palestina, ma in forme ancor più estreme, perché sostenendo l’Ucraina almeno stiamo dalla parte del più debole, mentre là il più forte è Israele. E, a causa del riflesso condizionato, di origine comunista, ma ormai entrato così in profondità nella nostra
mentalità da condizionare anche gran parte dei non comunisti e perfino degli anticomunisti (vedi la-frattura-tra-ragione-e-realta-3-marx-e-vivo-e-lotta-dentro-a-noi-dodici-idee-comuniste-a-cui-credono-anche-gli-anticomunisti), da molto tempo ormai
noi tendiamo istintivamente a identificare i “buoni” con i più deboli, come i palestinesi, anche se sono guidati da un regime criminale come Hamas, e i “cattivi” con i più forti, come Israele, anche se si tratta dell’unico Stato democratico del Medio Oriente.
La prima distorsione dei fatti è avvenuta addirittura prima di qualsiasi reazione israeliana, quando tutti erano ancora indignati e sconvolti per l’attacco di Hamas. Infatti, date le dimensioni e le modalità di quest’ultimo, chiamarlo “attacco terroristico” è stato assolutamente improprio. Non di semplice terrorismo si è trattato, ma di un vero e proprio atto di guerra. E agli atti di guerra si
risponde con atti di guerra.
Non aver chiarito questo fin dall’inizio ha creato un profondo equivoco e bisogna riconoscere che il primo ad alimentarlo è stato Netanyahu, che ha sempre e solo parlato di terrorismo, probabilmente perché convinto che in tal modo avrebbe avuto maggiore appoggio a livello internazionale e inoltre per non rischiare di “legittimare” indirettamente Hamas, trattandolo come un governo, come di fatto è. Ma, se è così, si è trattato di un calcolo completamente sbagliato, perché a livello psicologico il concetto di azione terroristica evoca l’idea di un gruppo clandestino composto da un numero limitato di persone che si nasconde tra la popolazione civile, la quale non può essere ritenuta responsabile delle sue azioni criminali, per quanto orribili siano state (il cui ricordo, peraltro, è già sbiadito nella stanca e corta memoria dei popoli occidentali e non fa lo stesso effetto dei palestinesi morti che vediamo in diretta).
Tuttavia, la realtà dei fatti è un’altra. Da ben 18 anni Hamas non è più un’organizzazione terroristica che si nasconde in un paese governato da altri, ma è esso stesso il governo (eletto in modo tutto sommato regolare) di quello Stato di fatto che è la Striscia di Gaza, a cui manca solo il riconoscimento internazionale per esserlo anche in linea di diritto e di cui i suoi miliziani rappresentano l’esercito.
Quindi, ciò che è accaduto il 7 ottobre è stato come se la Svizzera o la Francia avessero mandato un contingente delle loro forze speciali, affiancato spontaneamente ed entusiasticamente da molti semplici cittadini, a massacrare 1400 persone e a rapirne altre 300 a Como o a Ventimiglia. È evidente che di fronte a una cosa del genere il governo italiano (qualsiasi governo, non importa da
chi guidato) potrebbe fare una sola cosa: dichiarare guerra al paese responsabile. E questo è esattamente ciò che ha fatto e sta tuttora facendo Israele a Gaza: la guerra.
Ma, a causa di questa originaria distorsione dei fatti, ciò viene percepito come una reazione eccessiva e illegittima ad un “semplice” atto terroristico, con conseguenze davvero paradossali. Tutti, infatti, continuano a dire che “Israele ha tutto il diritto di difendersi, ma…”:
1) non deve bombardare;
2) non deve mandare truppe di terra;
3) non deve tagliare le comunicazioni, la luce e l’acqua;
4) non deve fare nulla che metta in pericolo gli ostaggi (anche se sono già in pericolo);
5) non deve colpire gli ospedali (anche se le basi di Hamas sono nascoste lì sotto);
6) non deve colpire le abitazioni (anche se i miliziani di Hamas sono nascosti lì dentro);
7) non deve mandar via i civili dagli ospedali e dalle abitazioni per evitare di colpirli;
8) non deve allagare i tunnel;
9) non deve puntare a distruggere Hamas;
10) non deve… (qualsiasi altra cosa vi venga in mente che implichi l’uso della forza);
È veramente difficile credere che una simile serie di condizioni possa essere stata concepita da esseri dotati di ragione. Perlopiù questi “divieti” vengono travestiti da previsioni, secondo la tecnica che ho descritto nell’articolo precedente, sostenendo che ciascuna di queste azioni “non serve” o “è destinata al fallimento” o “peggiorerà solo le cose” (in genere senza spiegare il perché, tanto la gente non è più abituata a chiederselo), ma la sostanza non cambia.
Ancor più assurda è l’affermazione, quasi universalmente condivisa, che a Gaza sarebbe in atto un genocidio. Infatti, come ha giustamente notato Ricolfi (gaza-fake-numbers), quando si parla dei morti a Gaza giornalisti ed esperti fanno riferimento
sempre e solo ai dati forniti dal Ministero della Sanità di Gaza, “dimenticando” di precisare che quest’ultimo è sotto il totale controllo di Hamas. Anche quando ciò viene detto, quasi mai si aggiunge che, considerata la fonte, tali dati non possono essere ritenuti affidabili. E anche nei rari casi in cui ciò viene detto, viene subito dimenticato e la discussione si svolge regolarmente come se invece fossero oro colato.
Ma, perfino se lo fossero, l’accusa di genocidio non starebbe in piedi. Secondo Hamas, infatti, sarebbero morti fin qui circa 40.000 palestinesi. Considerando che secondo gli israeliani (i cui dati non sono neanch’essi completamente affidabili, ma certo lo sono molto più dei loro) a fine aprile erano stati uccisi almeno 13.000 miliziani di Hamas, il che significa che oggi dovrebbero essere almeno 15 o 16 mila, i morti civili sono certamente non più di 25.000 in 9 mesi e probabilmente molti di meno. Comunque la si voglia mettere, queste non sono le cifre di un genocidio, ma –appunto – quelle di una guerra. Che è una cosa orribile, ma è un’altra cosa.
Quando una guerra è giusta?
Ricolfi ha giustamente definito «disumana» la “competizione vittimaria” in atto in Palestina, per cui, avendo sia gli israeliani che i palestinesi «ragioni solide, e perfettamente visibili, per autopercepirsi come vittime di oppressione, violenze, gravissimi soprusi […] utilizzano questa loro condizione per negare l’analoga condizione vissuta dalla parte avversa». E ha ancora ragione a dire
che «il dramma di entrambi i popoli che si contendono la terra di Palestina è così vasto e profondo che diventa immorale difendere le ragioni dell’uno senza vedere quelle dell’altro» (come-nel-68-riflessioni-sulla-competizione-vittimaria).
È però impossibile fare questo finché i palestinesi di Gaza saranno rappresentati da Hamas, il cui Statuto (statuto_hamas.htm), che tutti dovrebbero leggersi prima di parlare, si apre con una eloquente citazione di Hassan al-Banna, fondatore dei Fratelli Musulmani, di cui Hamas rappresenta la filiale palestinese: «Israele sarà stabilito, e rimarrà in esistenza finché l’islam non lo ponga nel nulla, così come ha posto nel nulla altri che furono prima di lui». Il suo motto è: «Dio come scopo, il Profeta come capo, il Corano come costituzione, il jihad come metodo, e la morte per la gloria di Dio come più caro desiderio» (art 8). Quanto alla questione palestinese, questo è il suo pensiero: «Le iniziative di pace, le cosiddette soluzioni pacifiche, le conferenze internazionali per risolvere il problema palestinese contraddicono tutte le credenze del Movimento di Resistenza Islamico [cioè Hamas]. In verità, cedere qualunque parte della Palestina equivale a cedere una parte della religione. […] Non c’è soluzione per il problema palestinese se non il jihad» (art. 13).
Così stando le cose, sembrerebbe di dover concludere che l’unica soluzione al problema di Hamas è il contro-jihad, cioè fargli la guerra fino alla sua totale eliminazione, come appunto sta cercando di fare Israele. È vero che tra gli israeliani c’è anche chi vorrebbe cacciare da Gaza tutti i palestinesi e non solo Hamas, ma questi non sono la maggioranza e difficilmente prevarranno, dato che a guerra finita Netanyahu verrà certamente destituito, per le sue responsabilità nella mancata prevenzione dell’attacco del 7 ottobre, e probabilmente anche processato, per i numerosi episodi di corruzione di cui è accusato.
Ma allora perché da noi tutti continuano a (stra)parlare di risposta esagerata da parte di Israele e spesso anche di genocidio? Il motivo è che ormai in Occidente siamo disposti a considerare giusto solo un tipo di guerra: quella in cui non si uccide nessuno.
O, più esattamente, quella in cui noi non uccidiamo nessuno. Perché gli altri, cioè i vari dittatori che, con la complicità dei fanatici della ideologia woke e della cancel (in)culture, vorrebbero, appunto, cancellarci dalla faccia della Terra, siccome per definizione rappresentano i poveri sono, sempre per definizione, “buoni”. Di conseguenza, se ogni tanto (o anche ogni poco) ammazzano un
po’ di gente… beh, bisogna capirli e perdonarli, a maggior ragione se quelli che hanno ammazzato erano occidentali o loro alleati, ricchi e quindi per definizione “cattivi” (cfr. ancora la-frattura-tra-ragione-e-realta-3-marx-e-vivo-e-lotta-dentro-a-noi-dodici-idee-comuniste-a-cui-credono-anche-gli-anticomunisti).
Basti pensare alla Siria, dove per molti anni sono successe atrocità indescrivibili, molto ma molto peggiori che a Gaza (si stima che in 13 anni ci siano stati oltre mezzo milione di morti e quasi 17 milioni di profughi), che continuano tuttora, anche se con intensità minore. Eppure, in Occidente tutti se ne sono sempre fregati, perché i colpevoli non eravamo noi, ma Assad, Erdogan e Putin, gli eroici Che Guevara del terzo millennio (il vero Che Guevara all’idea si starà rivoltando nella tomba, ma questo ai nostri intellettuali ovviamente non importa).
Eppure, per sconfiggere il nazismo abbiamo quasi raso al suolo la Germania e contro i fanatici giapponesi seguaci dell’Imperatore-Dio siamo arrivati a usare l’atomica, che ha causato da 103.000 a 210.000 morti (cfr. Paolo Musso, la-frattura-tra-ragione-e-realta-4-il-grande-spauracchio-parte-prima-il-nucleare-bellico; si veda anche l’articolo di Luciana Piddu, hamas-e-dintorni-il-velo-della-cecita). Anche per restare alle sole armi convenzionali, in una sola notte di bombardamenti, dal 3 al 4 febbraio 1945, a Tokyo morirono oltre 70.000 persone e quasi il doppio furono uccise la settimana seguente a Dresda.
Certo, si tratta di azioni di cui nessuno può andare fiero e alcune forse si sarebbero potute evitare, ma non per questo qualcuno si è mai sognato di accusare gli Alleati di genocidio (almeno per ora: con l’aria che tira, non mi stupirei se prima o poi succedesse). Perché cosa avrebbero dovuto fare, lasciare che vincessero Hitler e i kamikaze? In realtà se c’è qualcuno in Palestina che ha intenzioni genocide, questo è proprio Hamas, che non è migliore della Germania e del Giappone di allora, anche se per fortuna è molto meno potente.
Questi esempi ci mostrano con chiarezza che per giudicare se una guerra è giusta o sbagliata non possiamo basarci sul numero di morti o sulla grandezza delle sofferenze, perché allora ne seguirebbe che nessuna guerra è giusta, il che in un certo senso è vero, ma non ci aiuta.
Quale potrebbe essere, allora, un buon criterio? Il primo e il più ovvio mi pare sia che una guerra è giusta se è l’unico modo possibile di rispondere a un’aggressione. E ciò vale a maggior ragione se l’aggressione è portata da una dittatura contro una democrazia.
Altri criteri, come per esempio quelli che starebbero alla base della “guerra preventiva” o della “esportazione della democrazia”, sono assai più discutibili e di difficile applicazione, ma non ne abbiamo bisogno, dato che per quanto riguarda la guerra di Israele contro Hamas i primi due ricorrono sicuramente.
Cosa dovrebbe fare Israele?
Se poi passiamo da ciò che Israele “non deve” fare a cosa invece dovrebbe fare, le idee finora suggerite vanno dall’impraticabile al delirante, passando per tutte le sfumature intermedie. Poiché qui non è possibile elencarle tutte, mi limiterò a fare alcuni esempi particolarmente significativi.
L’Oscar per la proposta più stralunata va senz’altro, con ampio distacco, a Lucio Caracciolo, che una volta, rispondendo (mi pare) a Bruno Vespa, ha detto che Israele non dovrebbe colpire Hamas, che è stato solo l’esecutore materiale della strage, bensì l’Iran, che ne è il mandante. Ora, anzitutto questo è tutt’altro che certo, perché l’Iran è certamente un regime criminale e certamente sostiene Hamas, ma non ha su di esso un vero controllo come su Hezbollah, dato che si tratta di un movimento sunnita (il vero protettore di Hamas è il Qatar). Ma, soprattutto, vorrei sapere su quale pianeta crede di vivere Caracciolo: di certo non sulla Terra, comunque, dato che in nessun ordinamento giuridico conosciuto, passato o presente, è mai stato previsto che di un delitto si debba punire solo il mandante e non anche l’autore materiale.
L’idea più insidiosa è invece quella per cui Israele dovrebbe accettare la “tregua a tempo indeterminato” a più riprese proposta da Hamas, che di fatto significa la fine della guerra. Certamente è lecito (anche se a mio avviso sbagliato) che uno la pensi così, ma allora bisogna avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome e dire che Israele deve semplicemente fermarsi, accettando la situazione attuale, con Hamas ancora in grado di colpire e gli ostaggi che resterebbero prigionieri per chissà quanti anni, come è sempre successo in passato.
Quanto all’equivoco più diffuso, è certamente quello per cui basterebbe liberarsi di Netanyahu, perché ciò che sta accadendo è tutta colpa sua. Certamente, anche a me sarebbe piaciuto che gli israeliani l’avessero cacciato subito, sull’onda dell’indignazione per il disastroso fallimento dell’intelligence nel prevenire l’attacco di Hamas, perché si tratta di un personaggio losco e
pericoloso e il fatto che in questo momento Israele sia guidato da lui non aiuta. Ma ciò non avrebbe affatto risolto il problema, perché qualsiasi premier israeliano (e, in effetti, qualsiasi premier di qualsiasi paese, come ho cercato di spiegare prima) di fronte a ciò che è accaduto il 7 ottobre avrebbe fatto la guerra.
È vero che da quando Netanyahu nel 2009 è salito al potere, governando ininterrottamente fino ad oggi, c’è stata una decisa svolta autoritaria, che ha chiuso ad ogni ipotesi di trattativa con i palestinesi e ha moltiplicato gli insediamenti illegali in Cisgiordania, con annesse ripetute violenze da parte dei coloni e di ciò va tenuto conto per una valutazione globale della situazione (si veda l’ottimo articolo di Ricolfi il-non-detto-sulla-soluzione-dei-due-stati). Però è altrettanto vero che Netanyahu non è sorto dal nulla, bensì da oltre 60 anni di ostinati rifiuti di qualsiasi proposta di pace da parte dei palestinesi. E questa rimane tuttora la chiave del problema.
Hamas rappresenta o no i palestinesi?
Benché infatti gli israeliani, anche nei periodi di maggior dialogo, abbiano sempre portato avanti la colonizzazione della Palestina, accanto a questo ci sono state anche elezioni che hanno visto la vittoria di premier moderati che hanno fatto diverse proposte di pace. L’ultima di esse, offerta nel 2008 da Ehud Olmert, era così buona che il suo rifiuto (senza spiegazioni) da parte del “moderato” Abu Mazen lasciò incredulo perfino il suo più stretto collaboratore, il capo dei negoziatori Saeb Erekat.
Come egli stesso ha affermato alla televisione palestinese il 1° dicembre 2018 (il video si trova al seguente link: olmert-offri-ad-abu-mazen-piu-terra-di-quella-che-chiedeva-ma-abu-mazen-disse-no), in quella occasione Olmert offrì un territorio addirittura leggermente più grande dei territori del 1967 rivendicati dai palestinesi, più il controllo di parte di Gerusalemme, compresa la spianata del Monte del Tempio (luogo sacro per gli ebrei) e il rientro di 150.000 profughi palestinesi. Appena vide la mappa, Erekat gli disse immediatamente di accettare, ma Abu Mazen rifiutò, senza mai spiegare il perché.
Figura 1. La proposta di pace di Olmert, rifiutata nel 2008 da Abu Mazen, ricostruita in base ai racconti dei testimoni
(olmert-offri-ad-abu-mazen-piu-terra-di-quella-che-chiedeva-ma-abu-mazen-disse-no).
Da parte palestinese, invece, ci sono stati sempre e solo porte chiuse, odio e terrorismo. E chi ha mai visto una sola manifestazione di palestinesi contro Hamas e a favore della pace? Per quanto ne so, non ce n’è mai stata neanche una, non solo a Gaza, dove oggettivamente è pericoloso (ma anche manifestare contro gli Ayatollah è pericoloso, eppure gli iraniani lo fanno), ma neanche in Europa. Contro Netanyahu, invece, in Israele c’è sempre stata una forte opposizione, non solo in Parlamento, ma anche nelle piazze.
Inoltre, non dimentichiamo che molti popoli si ritengono oppressi, a torto o a ragione, ma non tutti hanno scelto il terrorismo come metodo di lotta e anche quelli che lo hanno fatto lo hanno sempre usato esclusivamente contro lo Stato oppressore. Solo i palestinesi (fin dall’inizio, con l’OLP di Arafat) hanno ritenuto che la loro causa fosse così giusta da dar loro il diritto di compiere attentati in tutto il mondo, certo perlopiù contro ebrei (che comunque, vivendo all’estero, non erano responsabili delle politiche dello Stato di Israele), ma coinvolgendo spesso anche cittadini di altri paesi. È come se ci fosse un oscuro cuore di tenebra che avvelena la storia del popolo palestinese: che cosa sia e da dove venga è difficile dirlo, ma mi sembra altrettanto difficile negare che esista.
Altrettanto innegabile è che la situazione attuale delle colonie israeliane renda ormai molto difficile attuare la classica soluzione “due popoli, due Stati” (cfr. ancora l’articolo di Ricolfi il-non-detto-sulla-soluzione-dei-due-stati). Ma difficile non vuol dire impossibile. Anche a Gaza c’erano molti coloni israeliani, ma quando nel 2005 Ariel Sharon decise di restituire la Striscia ai palestinesi li fece sgomberare con le buone o con le cattive e quelli che si rifiutarono di andarsene con le proprie gambe vennero portati via di peso dall’esercito israeliano.
Il problema è che la risposta degli abitanti di Gaza a questo gesto di buona volontà fu votare in massa per Hamas. E il peggio è che probabilmente sarebbero pronti a rifarlo.
È molto istruttivo al proposito leggere questa inchiesta (i-musulmani-italiani-e-la-guerra-a-gaza) della Fondazione Oasis, creata dal cardinal Angelo Scola quando era vescovo di Venezia, che non può certo essere accusata di islamofobia (semmai il contrario). Nel mese di gennaio Oasis ha intervistato a proposito degli attacchi del 7 ottobre e della guerra a Gaza i leader di 7 organizzazioni islamiche italiane, di cui fanno parte anche quasi tutti i palestinesi che vivono in Italia.
Di essi, soltanto uno, lo sceicco Yahya Pallavicini della COREIS, ha esplicitamente condannato Hamas. Un altro, Mader Akkad, imam della moschea di Roma, ha rimandato a un’intervista concessa al Corriere della Sera in cui si esprimeva a favore della pace, rifacendosi alla Dichiarazione di Abu Dhabi, che condanna la violenza perpetrata in nome di Dio, ma comunque senza mai nominare esplicitamente Hamas e il terrorismo palestinese. Uno, Massimo Abdallah Cozzolino della CII, ha preferito non rispondere.
Gli altri quattro (Brahim Baya di PSM; Yassine Lafram della UCOII; Davide Piccardo, direttore del quotidiano online La Luce; Izzedin Elzir, imam di Firenze), che insieme rappresentano la grande maggioranza dei musulmani italiani, anche se con sfumature diverse hanno sempre premesso che non si devono uccidere persone innocenti, ma… c’era sempre un “ma” per cui alla fine hanno giustificato Hamas o almeno non l’hanno condannato e anzi lo hanno tutti considerato un movimento di resistenza legittimo, nonché legittimo rappresentante di una parte cospicua del popolo palestinese. Tutti e quattro hanno parlato di “genocidio” da parte di Israele e hanno sostenuto che la soluzione dei due Stati è stata accettata dai palestinesi, ma non dagli israeliani. Piccardo ha addirittura avuto la faccia tosta di affermare che la soluzione è creare un unico Stato laico (!) in cui ebrei e palestinesi possano vivere insieme in pace.
Per quanto delirante, la posizione di quest’ultimo (figlio di Hamza Roberto Piccardo, co-fondatore della UCOII) è particolarmente interessante perché in base ai suoi sondaggi sarebbe condivisa dalla maggior parte dei musulmani italiani, che vuol dire anche dei palestinesi italiani. Certo, questi numeri vanno presi con cautela e sono probabilmente “gonfiati”, ma è difficile che siano completamente inventati.
D’altronde, il fatto stesso che la maggior parte dei musulmani italiani appartenga a queste organizzazioni significa che essi sono sostanzialmente d’accordo con le posizioni espresse dai rispettivi leader. Se fossero davvero contrari ad Hamas, infatti, confluirebbero tutti nella COREIS, l’unica associazione che l’ha esplicitamente condannato, che invece è così piccola da essere
presente in appena 8 Regioni italiane (cfr.chi-siamo), mentre l’UCOII, per esempio, riunisce ben 153 divere organizzazioni islamiche e gestisce 80 moschee e oltre 300 luoghi di culto non ufficiali in tutta Italia (/).
Sembra quindi davvero difficile sostenere che “Hamas non rappresenta i palestinesi”, come tutti continuano a ripetere, a cominciare, di nuovo, da Netanyahu, che ha così commesso un altro grave errore di comunicazione. La verità, purtroppo, è che Hamas rappresenta eccome gran parte del popolo palestinese, anche se (ovviamente) non tutto. E non solo per quanto riguarda l’atteggiamento aggressivo verso Israele, ma anche lo stile di vita, che è caratterizzato da un integralismo islamico molto chiuso e intollerante, soprattutto verso le donne.
Da questo punto di vista è davvero paradossale che tra i più ferventi sostenitori di Hamas ci siano i movimenti per i cosiddetti “diritti civili” e, in particolare, proprio quelli per i diritti delle donne, fino al punto che una ragazza (di sinistra) che durante le manifestazioni dello scorso 8 marzo è scesa in piazza con un cartello che denunciava gli “stupri etnici” di Hamas è stata cacciata dal corteo, nella totale indifferenza del mondo progressista. Paradossale, ma non sorprendente, perché la cosa ha una sua logica ben precisa, benché perversa.
Come ha spiegato ancora Ricolfi, infatti, «il nucleo del femminismo attuale», profondamente influenzato dalla ideologia woke, sembra essere «una forma di neo-razzismo, di cui l’antisemitismo è solo un aspetto, anche se forse il più detestabile. Il razzismo classico era basato sulla distinzione fra i bianchi e gli altri, il neo-razzismo è molto più ambizioso: pretende di stabilire una precisa
gerarchia fra le molteplici condizioni delle donne, e di farlo in base a caratteri ascritti o non modificabili. E nemmeno di fronte a una tragedia come quella del 7 ottobre trova una parola di pietà, se non di solidarietà e di condivisione, per le donne israeliane uccise, né per quelle ancora prigioniere dei loro carnefici» (dal-femminismo-al-neo-razzismo; su ciò si veda anche il mio articolo, già citato, la-frattura-tra-ragione-e-realta-3-marx-e-vivo-e-lotta-dentro-a-noi-dodici-idee-comuniste-a-cui-credono-anche-gli-anticomunisti).
I timori sull’allargamento del conflitto
Un altro aspetto paradossale è l’insistenza quasi ossessiva con cui si è discusso (e in parte si continua ancora a discutere) del possibile allargamento del conflitto. È comprensibile che questa prospettiva faccia paura, ma il compito degli esperti è precisamente quello di dirci se le nostre paure sono o no fondate. Naturalmente nessuno pretende che i loro ragionamenti siano infallibili in una situazione così caotica, ma non sembra una richiesta eccessiva pretendere che almeno non ignorino i più elementari dati di fatto. Eppure, questo accade con allarmante frequenza.
Prendiamo per esempio il caso più dibattuto: quello del possibile coinvolgimento dell’Iran. Ebbene, spesso viene da chiedersi se qualcuno degli esperti in questione si è mai preso il disturbo, prima di esporci le sue profonde riflessioni in merito, di dare un’occhiata alla carta geografica, esposta in bella vista in ogni talk show. È vero che ignorare ciò che si ha sotto il naso sembra ormai diventato uno sport di massa, ma come si fa a non rendersi conto che l’Iran non potrebbe attaccare Israele neanche se lo volesse, perché per farlo, qualunque strada scelga, dovrebbe far passare il suo esercito attraverso almeno due Stati sovrani
L’unico modo in cui potrebbe darsi uno scontro diretto tra Iran e Israele è attraverso lanci di missili e droni, come infatti è accaduto ad aprile, il che però ha un’efficacia limitata, anche a causa dell’ottimo sistema antimissilistico israeliano. Una guerra vera e propria, con battaglie di terra che coinvolgano i rispettivi eserciti, sembra invece difficilmente immaginabile.
A parte questo aspetto pratico, va poi anche considerato che per un qualsiasi Stato mediorientale attaccare direttamente Israele sarebbe un suicidio, perché l’esercito israeliano è tuttora molto più forte e inoltre in tal caso gli Stati Uniti non potrebbero fare a meno di intervenire. Inoltre, non va dimenticato (anche se, stranamente, lo facciamo sempre) che Israele, pur non avendolo mai
dichiarato ufficialmente, possiede almeno un centinaio di testate nucleari e il giorno in cui fosse seriamente minacciato non si farebbe scrupolo ad usarle, perché, diversamente da qualsiasi altro paese, nel suo caso non sarebbe in gioco soltanto la sua sopravvivenza politica come Stato, ma anche quella fisica dei suoi abitanti. Tanto più, poi, dopo l’attacco di Hamas, che ha tolto ogni dubbio, se mai ancora ce n’erano, su cosa accadrebbe il giorno in cui l’esercito di un paese islamico riuscisse a invadere Israele.
Per essere chiari: prima che ciò possa accadere, quel paese verrebbe cancellato dalla carta geografica. E, diversamente da noi, i leader mediorientali ne sono perfettamente consapevoli. Per questo, al di là della retorica, da decenni non hanno più mosso un dito per aiutare i “fratelli palestinesi”. Eppure, ci sono voluti oltre un mese e il fallimento della prima conferenza di pace
perché i nostri esperti di geopolitica cominciassero a capire che non avrebbero fatto nulla neanche stavolta.
Ma c’è anche un altro motivo, molto più meschino, ma non meno importante, per cui i leader islamisti in realtà non hanno alcun interesse a far finire il conflitto in Palestina, né favorendo la pace né cercando di distruggere Israele: ed è che Israele è la perfetta “arma di distrazione di massa” su cui far sfogare le frustrazioni e i malumori dei loro sudditi, così distraendoli (appunto) dalle pessime condizioni in cui i loro pessimi regimi li costringono a vivere. Insomma, la “questione palestinese” è per loro l’equivalente dei “due minuti d’odio” che in 1984 di George Orwell il Grande Fratello usa per lo stesso scopo. E, guarda caso, anche lì il capro espiatorio scelto dal regime, Goldstein, presunto leader dei ribelli, è ebreo…
Per le stesse ragioni anche un coinvolgimento indiretto dell’Iran attraverso Hezbollah è estremamente improbabile. Eppure, di nuovo, fino al discorso del 3 novembre 2023 con cui il loro leader Nasrallah ha praticamente “scaricato” Hamas, ripetendo per ben cinque volte in due ore che l’attacco del 7 ottobre «è al 100% il risultato di una decisione palestinese», praticamente tutti si
aspettavano che avrebbe annunciato una intensificazione dello scontro con Israele, restando un dubbio solo sul livello di intensità, da un semplice aumento degli attacchi missilistici fino alla guerra aperta. E ciò ha spiazzato a tal punto i commentatori, che molti sul momento non l’hanno neanche capito (o hanno finto di non averlo capito, per salvare la faccia…).
Il fatto è che Nasrallah sa perfettamente che il suo, anche se può contare su decine di migliaia di uomini, non è realmente un esercito, come i nostri esperti continuano invece a ripetere: gli Hezbollah non hanno aviazione né carri armati, hanno pochi cannoni e pochi veicoli blindati, per cui in uno scontro in campo aperto verrebbero sterminati. Per questo, così come Hamas, hanno scelto la tattica della guerriglia, che permette loro di nascondersi fra le montagne o, meglio ancora, fra le case, in luoghi che conoscono come le loro tasche e dove possono contare sulla complicità di buona parte della popolazione e usare come ostaggio la parte restante, lanciando in territorio nemico soltanto rapidi attacchi “mordi e fuggi” e un sacco di missili, il che permette loro di valorizzare al massimo le sole cose di cui abbondano: veicoli leggeri, kalashnikov e, appunto, missili.
Naturalmente, questo tipo di guerra è molto difficile da vincere non solo per chi la subisce, ma anche per chi la fa. Non dimentichiamo però che, quando durante i colloqui di pace alla fine della guerra del Vietnam gli americani fecero notare ai nordvietnamiti che non li avevano mai veramente sconfitti, il generale Giáp, che condusse la celebre offensiva del Têt, rispose: «Non ne avevamo bisogno», intendendo che a loro bastava resistere e lasciare che l’opinione pubblica americana, sempre più ostile alla guerra col passare del tempo, facesse il resto. E questo è ancor più vero oggi, con un’opinione pubblica ormai composta in gran parte da persone viziate (la “società signorile di massa” di Ricolfi) e abituate ad avere “tutto e subito” senza dover mai fare nessun vero sacrificio.
Tuttavia, per quanto preoccupante, anche questa situazione punta nella direzione opposta a quella di un allargamento del conflitto. Un attacco di eserciti regolari di Stati islamici contro Israele renderebbe infatti impossibile continuare il gioco di “Davide contro Golia” che funziona così bene con le opinioni pubbliche occidentali e sarebbe praticamente l’unica cosa che potrebbe far risorgere un forte sostegno a Israele anche in casa nostra. Quindi non ci sarà. Eppure, i nostri esperti sembrano non averlo ancora capito…
La guerra delle dittature contro le democrazie
Il loro errore in assoluto più grave è però un altro: quello di credere e farci credere che la guerra più importante e più pericolosa sia quella che si combatte a Gaza, il che ha fatto sì che negli ultimi mesi la guerra in Ucraina sia stata quasi dimenticata.
Ma è vero esattamente il contrario. La guerra a Gaza è certamente una tragedia ed è giusto che ce ne occupiamo, anche se la probabilità di riuscire a influire in modo soddisfacente sul corso degli eventi sembra molto piccola. Ma non è a Gaza, bensì in Ucraina che si decide il nostro futuro (e anche quello di Gaza). E per capirlo bene bisogna avere chiaro il quadro generale.
A tal fine mi rifarò di nuovo a quanto scritto da Garri Kasparov, l’ex campione mondiale di scacchi da sempre nemico giurato di Putin, in un esemplare articolo che ho già citato la volta scorsa (dallucraina_al_medio_oriente_i_passi_falsi_di_biden_in_politica_estera-13838505). Ecco le sue parole:
«Il motivo per cui Burns [direttore della CIA] e Sullivan [consigliere di Biden per la sicurezza nazionale] sono in torto così spesso è che ancora adesso non riescono a rendersi conto che siamo in guerra, un’unica guerra contro dittature e terroristi. Proprio quando le forze armate russe stavano iniziando a perdere terreno in Ucraina, Hamas ha attaccato Israele e il venezuelano Nicolas Maduro ha indetto un referendum per reclamare i territori di buona parte della vicina Guyana. […] In una manifestazione a Istanbul del 28 ottobre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito “combattenti per la libertà” gli uomini di Hamas e ha chiamato Israele “criminale di guerra”. […] Mosca accoglie le delegazioni di Hamas e si vanta del fatto che i russi presi in ostaggio stanno ricevendo un trattamento di favore. Il motore di ricerca cinese Baidu ha rimosso il nome di Israele dalle sue mappe online, inquietante eco delle minacce islamiste di spazzare via Israele dalle carte geografiche. […] Putin combatte ancora la sua guerra e i suoi sodali combattono l’ordine globale dal Niger al Nilo e dalla Bielorussia al Venezuela. Il ministro degli esteri iraniano viene a New York e minaccia le vite dei cittadini americani. La Cina si prepara a invadere Taiwan, in attesa del momento giusto per colpire. […] Io credo nelle coincidenze, ma credo anche nel KGB. Fino a quando non sconfiggeremo Vladimir Putin, continueremo ad aprire nuovi fronti in questa sua guerra contro l’America e l’ordine mondiale globale di cui essa è alla guida, distogliendo attenzione e risorse dall’Ucraina».
Questo si chiama avere le idee chiare! E si noti che Kasparov ha scritto proprio “KGB”, dimostrando così di avere le idee molto chiare anche sulla sostanziale continuità che c’è tra il regime sovietico e quello di Putin, che prima di diventare presidente era appunto un alto ufficiale del KGB: altroché l’immaginario Putin “fascista” di cui straparla la sinistra nostrana (cfr. il mio precedente articolo la-frattura-tra-ragione-e-realta-1-su-mosca-sventola-bandiera-rossa).
Quello che sta accadendo oggi nel mondo è infatti parte di un processo secolare, iniziato con la Seconda Guerra Mondiale, che vede le democrazie occidentali opporsi a dittature che si basano in gran parte su ideologie nate anch’esse in Occidente (per la serie “facciamoci del male”: l’autodemolizione dell’Occidente non è nata oggi, ma ha alle spalle una storia molto lunga…).
Nella Seconda Guerra Mondiale ci hanno attaccato le dittature di destra, figlie dell’idealismo tedesco, in particolare quello di Fichte e di Hegel (cfr. il mio libro La scienza e l’idea di ragione, Mimesis 2019, e il mio articolo la-frattura-tra-ragione-e-realta),
che abbiamo sconfitto, benché a prezzo di sofferenze terribili, in gran parte dovute all’esserci mossi troppo tardi.
Ora la storia si ripete con le dittature di sinistra, nate anch’esse dalla stessa radice (il marxismo è figlio legittimo dell’hegelismo). E fin dal tempo di Khomeini, che per preparare la sua rivoluzione si era esplicitamente ispirato al marxismo imparato alla Sorbona di Parigi, al club si sono iscritte anche le dittature islamiste, che per legittimarsi usano la scusa di lottare per i poveri, vittime delle ingiustizie del capitalismo globale.
E non è che queste ingiustizie non ci siano. Ma non saranno certo Putin, Xi Jinping, Erdogan, gli Ayatollah, i Talebani o Hamas a porvi rimedio, dato che dei poveri non gliene frega niente e li stanno soltanto strumentalizzando, con la colpevole complicità dei nostri intellettuali.
Almeno per una volta vogliamo chiamare le cose col loro nome, senza ipocriti eufemismi?
Le nostre democrazie, soprattutto in questo frangente storico, hanno difetti orribili e hanno mostrato più volte preoccupanti tendenze autoritarie (vedi di nuovola-frattura-tra-ragione-e-realta). Ma sono pur sempre meglio – infinitamente meglio – di questi criminali, che ci incolpano di tutti i mali del mondo, che in gran parte sono causati proprio da loro e per l’altra parte, quella davvero causata da noi, soltanto da noi possono essere curati. Non è detto che ci riusciremo, ma almeno possiamo provarci. Loro, invece, no.
Abbattere Putin per ammonire gli altri: perché tutto si gioca in Ucraina
Oggi tutti citano la frase di Papa Francesco sulla “Terza Guerra Mondiale a pezzi” e l’altra, più recente, sui “pezzi che si stanno saldando”. Questa è indubbiamente la verità, ma non è tutta la verità: occorre infatti aggiungere che si tratta di una Terza Guerra Mondiale a pezzi delle dittature contro le democrazie. E “i pezzi che si stanno saldando” sono appunto le diverse dittature che
stanno iniziando a cooperare tra loro. Con la Russia a fare da regista.
Oltre che dagli esempi citati da Kasparov, ciò si vede chiaramente anche dalla collaborazione, nonostante la loro storica rivalità, tra Russia e Turchia, non solo rispetto all’Ucraina (dove Erdogan, nonostante le balle che racconta sul suo ruolo di “mediatore”, sta sostanzialmente con Putin), ma anche in altre precedenti occasioni, come in Libia e in Siria, benché al tempo stesso cerchino anche di fregarsi a vicenda, come sempre succede nelle alleanze tra criminali.
E non si tratta solo di una saldatura in termini di alleanze: se Putin vincesse in Ucraina, quest’ultima rischierebbe di trasformarsi anche in una saldatura territoriale. L’Ucraina, infatti, confina con la piccola Moldavia, che Putin si annetterebbe subito senza troppe difficoltà (al suo interno si trova già un forte contingente russo) e con l’Ungheria, che a sua volta confina con la Serbia, paesi che già adesso sono entrambi filo-russi e che in una simile situazione potrebbero diventarlo ancor di più, trasformandosi in suoi alleati a tutti gli effetti. Si creerebbe così un gigantesco “fronte del male” che, dal Baltico al Golfo Persico, vedrebbe schierate nell’ordine Russia, Bielorussia, Ucraina (sotto occupazione russa), Ungheria, Serbia, Turchia e Iran. E una volta di più viene da chiedersi se i nostri esperti di geopolitica guardino mai una cartina geografica, visto che finora nessuno sembra essersene reso conto.
A interromperlo, per poco più di 400 chilometri, resterebbe solo la debole Bulgaria, con appena 6 milioni di abitanti e 36.000 soldati, perlopiù armati con ferrivecchi sovietici, che potrebbe decidere di sottomettersi volontariamente, non considerando una garanzia sufficiente la sua appartenenza alla NATO, se quest’ultima non avesse saputo aiutare adeguatamente l’Ucraina. E lo stesso potrebbe fare la Romania, che a quel punto si troverebbe completamente circondata.
Dobbiamo perciò assolutamente spezzare questo perverso meccanismo prima che sia troppo tardi: cioè, in sostanza, prima che anche la Cina entri nel gioco. Per fortuna la sua tradizionale prudenza ci lascia ancora un po’ di margine, ma non possiamo più permetterci di perdere altro tempo, dato che negli ultimi tempi i cinesi hanno iniziato a vendere armi ai russi sottobanco e stanno solo aspettando di vedere come reagiremo (o non reagiremo) prima di cominciare a farlo anche alla luce del sole. Ma soprattutto dobbiamo avere ben chiaro in mente che quelli con cui abbiamo a che fare non sono persone civili, magari un po’ stronze, ma con cui si può comunque ragionare. Sono criminali psicopatici con tendenze genocide, che capiscono un solo linguaggio: quello della forza.
Non si tratta soltanto del fatto che tradiscono regolarmente gli accordi che stringono. Ben più radicalmente, la forza è l’unica cosa che rispettano o almeno temono, mentre per la loro logica essere disposti a trattare non è segno di nobiltà d’animo, bensì di debolezza.
Non è certo un caso che tutto questo sia iniziato dopo la nostra vergognosa fuga dall’Afghanistan, decisa da Biden in base all’accordo stretto da Trump con i fantomatici “talebani moderati”, che, come si è poi visto, semplicemente non esistono. Ciò. infatti, ha convinto tutti i dittatori del mondo che potevano fare impunemente tutto quel che volevano, perché tanto il “vile Occidente” non avrebbe reagito. Se fossimo fuggiti anche davanti a Putin, come era già pronto a fare Biden, sarebbe
stata la fine: tutti ci sarebbero saltati alla gola.
Il coraggio e la determinazione di Zelensky e degli ucraini ci hanno salvati (per ora) dal baratro, ma non basta. Dobbiamo colpire in modo durissimo (ma veramente durissimo) almeno uno di questi regimi criminali, in modo che gli altri capiscano che potremo anche essere lenti a reagire, ma quando lo facciamo siamo ancora noi i più forti.
Dopo si potrà e si dovrà cercare di correggere le ingiustizie e gli squilibri che il nostro assurdo stile di vita ha causato nel mondo e che portano acqua al mulino di questi delinquenti. Ma dopo. Perché non è possibile cercare di attuare profonde riforme globali mentre siamo continuamente sotto attacco. “Colpirne uno per educarne cento”, come si diceva una volta: solo così si fermeranno.
E,per quanto possa sembrare paradossale, il bersaglio più facile è proprio quello più grosso: la Russia.
Putin, infatti, si è andato a cacciare nella trappola perfetta, se solo avremo il coraggio di farla scattare. Schierato nella immense pianure dell’Ucraina, prive di difese naturali, scenario perfetto perché le nostre armi ipertecnologiche possano dispiegare al meglio tutto il loro devastante potenziale e con un intero popolo che non vede l’ora di usarle, l’esercito russo è il bersaglio ideale. Purché ci decidiamo a dare al più presto agli ucraini tutto quello di cui hanno bisogno: non per fermarlo, ma per distruggerlo, fino all’ultimo bullone dell’ultimo carro armato.
Se lo faremo, ciò segnerà inevitabilmente la caduta (e, di conseguenza, la morte) di Putin: un evento clamoroso e oggi quasi inimmaginabile, che renderebbe tutti gli altri dittatori molto più prudenti, facendo perciò scendere la tensione un po’ dovunque, Medio Oriente compreso, almeno per qualche anno. Distruggere Hamas, invece, è molto più difficile e non avrebbe lo stesso impatto. Non che non si debba fare anche questo, se possibile, ma è la testa della piovra che va tagliata, non uno dei suoi tentacoli.
Certamente la cosa non è esente da rischi, perché di fronte alla rovina incombente Putin potrebbe reagire in modo incontrollato, benché l’ipotesi più preoccupante, quella di un attacco atomico, sia molto improbabile (cfr. il mio articolo e-se-sulla-no-fly-zone-avesse-ragione-zelensky, nonché il già citato la-frattura-tra-ragione-e-realta-4-il-grande-spauracchio-parte-prima-il-nucleare-bellico). Ma ci sono altre opzioni che purtroppo non si possono del tutto escludere, come per esempio una serie di attacchi con droni e missili convenzionali contro le città europee, che non sono adeguatamente attrezzate per proteggersi.
Tuttavia, non ci sono alternative, perché Putin non si fermerà finché qualcuno non lo costringerà a farlo. E per ottenere questo risultato ci sono solo due modi: il primo è che lo facciano gli ucraini adesso; il secondo è che lo facciamo noi tra qualche anno (il che, a scanso di equivoci, non significa fra venti o trent’anni anni, ma fra due o tre al massimo). Quale dei due vi sembra preferibile?
Forse penserete che questa sia un’esagerazione, perché la Russia non sarebbe comunque in grado di attaccare altri paesi dopo una guerra così sanguinosa. Ed è vero. Non subito. Ma Putin ha approfittato della guerra per trasformare la sua “democratura” in una dittatura vera e propria, dove potrà fare quello che vuole finché non verrà abbattuto. E quello che vuole ce lo ha dimostrato
chiaramente: rafforzare il suo potere militare a qualunque costo, anche quello di ridurre il suo popolo alla fame, come già sta facendo. Continuerà a farlo, finché non si sentirà di nuovo forte, se gliene daremo il tempo.
Inoltre, se Putin dovesse vincere in Ucraina potrebbe non presentarsi da solo alle nostre frontiere.
Che a loro volta, come abbiamo visto, potrebbero non essere più le stesse.
Per chi non lo sapesse, dal punto più occidentale dell’Ungheria al punto più orientale della frontiera italiana, che è in Friuli, vicino a Tarvisio, ci sono circa 200 chilometri: più o meno quanto c’è tra Milano e Bologna. Che effetto vi fa l’idea di un esercito di uno o due milioni di russi, ceceni, turchi, iraniani, ungheresi e serbi, con armamenti cinesi, nordcoreani e magari pure indiani, schierato ad appena due ore di auto dai nostri confini?
Lo so che istintivamente uno scenario del genere ci sembra fantascienza. Ma quanti scenari da fantascienza abbiamo già visto realizzarsi negli ultimi anni, dalle Torri Gemelle alla pandemia al riscaldamento globale? La verità è che l’anomalia siamo noi, la prima generazione della storia a non avere conosciuto la guerra. Ma non c’è nessuna garanzia che questo durerà per sempre.
E comunque, anche senza arrivare alla guerra vera e propria, la formazione di un blocco del genere, guidato dalla Russia, sarebbe già di per sé sufficiente a stravolgere tutti gli equilibri geopolitici, ricreando una situazione simile a quella che esisteva ai tempi dell’Unione Sovietica. Cioè, guarda caso, esattamente il sogno di Putin. Con in più la non piccola differenza che allora le democrazie europee erano forti, mentre adesso sono deboli.
Putin, pertanto, potrebbe cercare di attirarle nella sua orbita un poco alla volta, senza colpo ferire, usando ora il bastone della minaccia militare, ora la carota dell’immenso mercato che una simile alleanza rappresenterebbe. Mentre noi a quel punto non potremmo più colpirlo senza scatenare davvero una guerra mondiale.
Quanto tempo credete che resisterebbe la stanca e scettica Europa in una situazione simile?
Pensateci, la prossima volta che sentirete i nostri “esperti” straparlare della guerra-che-non-si-può-vincere.
E cominciate invece a riflettere sulla guerra che si deve vincere.