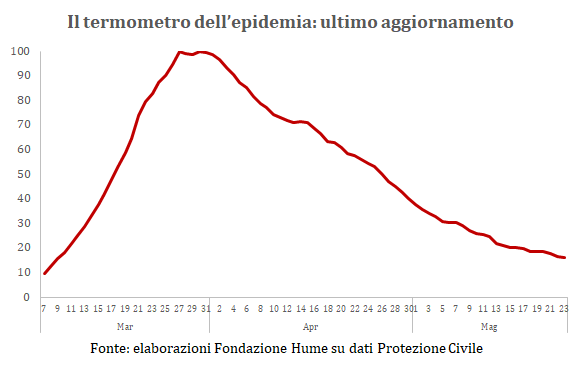Nei giorni scorsi si è molto discusso di tre regioni – Lombardia, Molise, Umbria – che, secondo i parametri monitorati dalle autorità sanitarie, presentavano un rischio di ripresa dell’epidemia più alto di quello delle restanti regioni. In Umbria, in particolare, il famigerato indice Rt avrebbe sfondato la barriera di 1, portandosi a 1.23, un valore sufficiente (ove confermato in futuro) a far ripartire l’epidemia. Di qui la preoccupazione dei cittadini, e la ferma protesta della governatrice Donatella Tesei. Dopo un po’ di giorni di polemiche, ha provveduto l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a gettare acqua sul fuoco con varie precisazioni e distinguo. In sostanza: tranquilli, Rt è ballerino quando i casi sono pochi, e comunque non è una pagella.
Ieri il caso dell’Umbria si è improvvisamente sgonfiato: il nuovo valore di Rt comunicato da Iss e Ministero della Salute è solo 0.53, migliore di quello di altre 10 regioni (la maglia nera, in compenso, è passata alla Valle d’Aosta, che secondo l’ultimo report ha un valore di 1.06, un pelo al di sopra della soglia critica).
Il fatto che fino a ieri si discutesse della rischiosità della situazione umbra, però, è paradossale, e getta una luce inquietante sull’intero sistema di monitoraggio dell’epidemia. Provo a spiegare perché.
Primo. La discussione sull’Umbria si è prolungata fino al 21 maggio, ma i dati su cui si basava erano relativi alla prima settimana di riapertura (dal 4 al 10 maggio), e a loro volta riflettevano – nella migliore delle ipotesi – i contagi avvenuti nell’ultima settimana di aprile. Dunque quello di cui si stava discutendo ieri, 21 maggio, era se l’Umbria potesse riaprire stante la presunta dinamica dei contagi un mese prima, ossia a fine aprile, in pieno lockdown. Leggermente surreale.
Secondo. I dati di base su cui si basa il monitoraggio delle autorità sanitarie sono gestiti come un segreto di stato. Se un analista indipendente o un’università vogliono controllare i calcoli, anche solo per perfezionarli, non possono farlo, perché mentre esiste un database pubblico dei dati della Protezione Civile non esiste un database dei micro-dati dell’Istituto Superiore di Sanità. La differenza fra le due fonti è cruciale: i dati della Protezione Civile sono spesso incoerenti e poco disaggregati, mentre quelli dell’Istituto Superiore di Sanità sono di qualità largamente superiore, se non altro perché per lo più corredati di informazioni temporali (data del decesso, ad esempio) e spaziali (comune di residenza del soggetto). In breve: nonostante il nostro paese continui a credersi una democrazia, l’accessibilità ai dati dell’epidemia ricorda quella dei regimi dispotici.
Terzo. La classificazione di una regione come più o meno a rischio si basa su 21 parametri (in qualche caso descritto in modo confuso, generico o farraginoso), ma l’algoritmo che trasforma i 21 parametri in un giudizio di rischiosità non è specificato in modo rigoroso ed esplicito. Questo impedisce ai cittadini, ma soprattutto ai governatori di Regioni e Province autonome, di valutare la razionalità ed equanimità del giudizio finale. Detto altrimenti: l’eccesso di indicatori, e l’assenza di un algoritmo esplicito, rendono incontrollabile (e quindi insindacabile) il giudizio delle autorità centrali. Una Regione che si senta ingiustamente penalizzata non ha alcuno strumento per difendersi. Non vorrei essere un governatore.
Quarto. Non so quanta importanza le autorità sanitarie attribuiscano a Rt, né se lo usino per capire la situazione o per legittimare le proprie scelte. Però quello che so, in quanto studioso di analisi dei dati, è che è difficile, nell’oceano della letteratura matematico-statistica, trovare un dispositivo di misurazione così dibattuto, controverso, ricco di varianti, nonché fortemente dipendente dalle ipotesi e dalle scelte dell’analista. In questa situazione sarebbe auspicabile che, quando si dice che una regione, in un certo momento o periodo, ha un determinato valore di Rt, fosse possibile riprodurre il procedimento che ha condotto a calcolarlo. Il che significa fornire: matrice dati utilizzata, procedimento di stima adottato, ipotesi e stime cui si è dovuto ricorrere. Così procede la scienza, così dovrebbero procedere istituzioni e comitati scientifici.
Quinto. E’ inquietante che, a causa dei ritardi nell’avviare l’indagine campionaria sulla diffusione del virus (altri paesi l’hanno già condotta, nonostante abbiano avuto meno tempo di noi), ancora nulla di preciso si sappia sul grado di diffusione dell’epidemia nei vari territori. Ed è ancora più inquietante che, a causa di questo vuoto di conoscenza, si sia costretti ad affidarsi – nella valutazione del rischio epidemico di ogni territorio – al più ambiguo e potenzialmente fuorviante degli indicatori – ovvero al numero di casi diagnosticati. Quanti siano i nuovi casi accertati ogni giorno in un determinato territorio, infatti, dipende non solo da quanti siano i nuovi casi effettivi (notoriamente molti di più), ma dalle politiche che le autorità sanitarie locali prediligono: dare o non dare la caccia agli asintomatici, fare o non fare il tampone ai malati non ospedalizzati, favorire o ostacolare la collaborazione delle università e dei privati.
Ed eccoci al punto cruciale. Una Regione attiva nella ricerca dei contagiati (ad esempio il Veneto) potrebbe essere giudicata a rischio solo perché aumentano i casi diagnosticati, mentre una regione pigra, o che ha scelto consapevolmente di fare pochi tamponi, potrebbe risultare a basso rischio solo perché non si dà molto da fare per scovare i contagiati. Di qui il paradosso: se il governo continuerà a monitorare l’epidemia conteggiando il numero di nuovi casi, le Regioni che non vogliono tornare in lockdown dovranno limitare il numero di tamponi; e le Regioni che, per salvare vite, hanno scelto di fare tanti tamponi, rischieranno di essere giudicate a rischio.
Credo che la situazione non lasci molte alternative. O il governo sgancia la valutazione del rischio regionale dalla conta dei nuovi casi (ma in che modo, se le indagini sierologiche sono in alto mare?), oppure le Regioni avranno un forte incentivo a fare pochi tamponi. Con la conseguenza, tragica, di aumentare ancora il bilancio dei morti.
Pubblicato su Il Messaggero del 23 maggio 2020