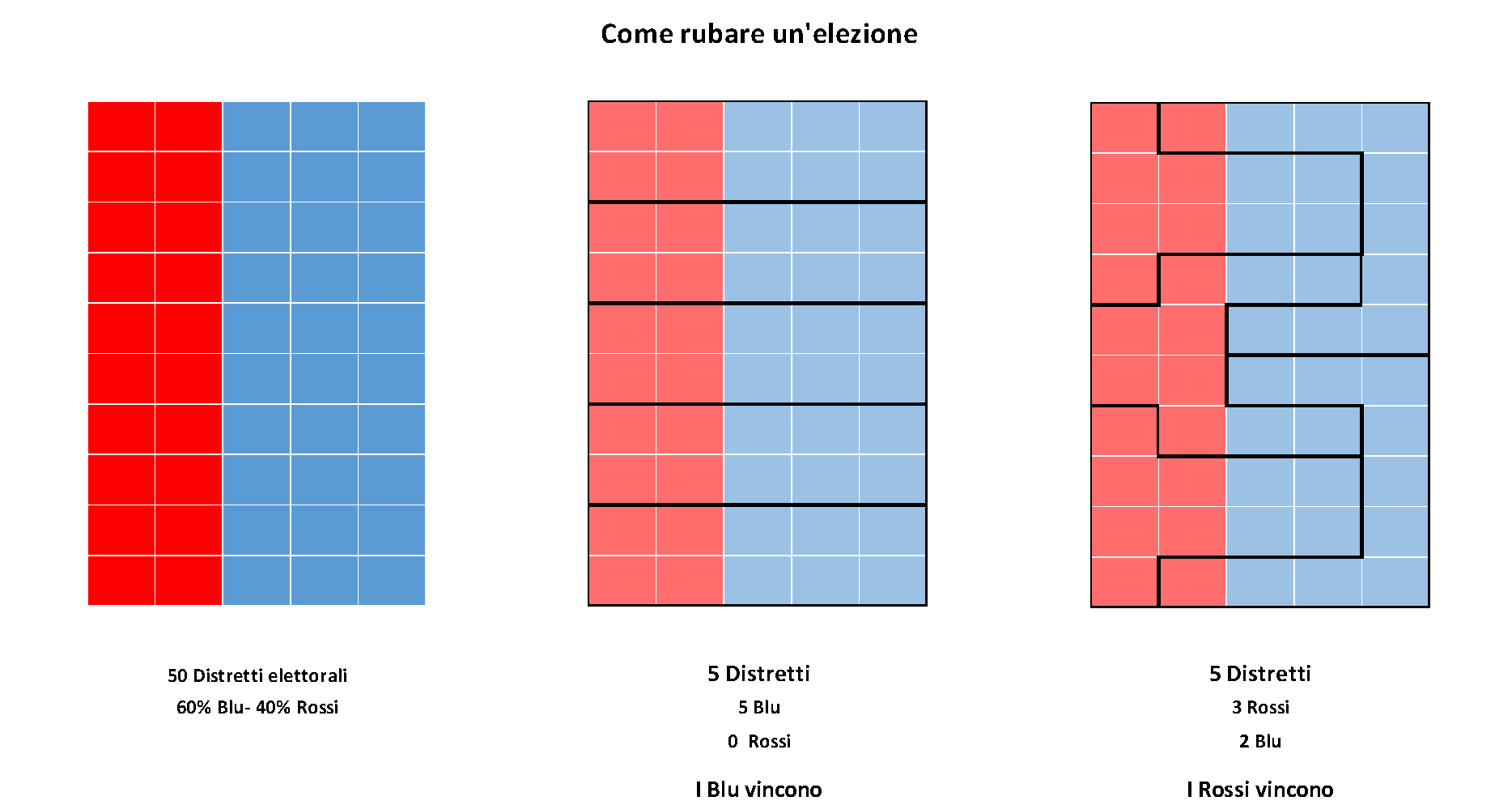«Come donna devi avere il senso del limite.» Forse la risposta al quesito «perché la sinistra non ha leader donne?» è tutta qui, nelle parole che nel 2001 si sentì dire il ministro Roberta Pinotti, all’epoca segretario provinciale Ds a Genova, quando il partito le propose la candidatura in Parlamento e, negli stessi giorni, lei scoprì di aspettare un figlio. A pronunciarle non fu il suo partner o un avversario politico maschio, o un compagno retrogrado tipo quelli immortalati da Guareschi in Don Camillo, che andavano a piangere dal prete perché la moglie era così impegnata in politica da trascurare i fornelli. A Pinotti lo disse un’altra donna del suo partito, l’ex Pci, l’attuale Pd. Probabilmente, una progressista pronta a combattere in buona fede per le pari opportunità, finché non si tratta di rompere il famoso soffitto di cristallo. Non è nella natura delle donne, e men che mai delle future madri, rompere i cristalli. Al massimo possono prendere straccio e Vetril, tirarli a lucido e godersi la splendida visuale delle suole dei compagni che, geneticamente sprovvisti del senso del limite, hanno fatto carriera e ora camminano sulle loro teste. Pinotti invece il cristallo l’ha rotto. Da tre anni è ministra della Difesa, prima donna in Italia. E oggi dice che per lei, donna ed ex comunista, è stato più facile farsi accettare dalle arcigne Forze Armate che dai politici, compresi quelli di sinistra. Una storia che ricorda alla lontana quella di Angela Merkel: cresciuta nella Gioventù comunista della Germania Est, ma poi trapiantata con successo in un’aiuola ideologicamente lontanissima, quella cristiano-democratica.
Chissà se a Frau Angela, la tri-cancelliera in cui molti vedono il solo vero uomo politico europeo, qualcuno ha mai consigliato di mantenere il senso del limite. O per rimanere in Germania, a Tatjana Festerling, la pasionaria di Pegida, destra radicale, o a Frauke Petry, ex leader dei nazionalisti di Alternative fur Deutschland, o ad Alice Weidel, attuale vice presidente del partito, o alle sue aristocratiche capi-corrente Doris von Sayn-Wittgenstein e Beatrix von Storch, imparentate con tutte le teste coronate d’Europa. Sembra che il senso del limite, rimanere un passo indietro rispetto ai maschi, senza mai alzare la voce o pestare i piedi, sia una virtù richiesta soprattutto alle politiche di sinistra. La destra europea pullula di donne «no-limits». In Francia, paese politicamente sessista almeno quanto l’Italia, ci sono le due Le Pen, Marine e Marion; in Inghilterra Theresa May, Diane James dell’Ukip, Leanne Woods dei nazionalisti gallesi e la bombastica Jayda Frensen, pasionaria dell’ultradestra di British First i cui tweet islamofobi sono stati improvvidamente retwittati da Donald Trump. Il giro d’Europa delle lady di ferro tocca la Norvegia, dove il centrodestra e la destra populista sono presidiate da due signore, Erna Solberg e Siv Jensen; la Lituania della Thatcher baltica, Dalia Grybauskaite, la Polonia, governata dalla leader degli ultra-conservatori Beata Szydlo, sconfina in Ucraina, forse la culla dell’euro-nazionalismo al femminile, inaugurato dall’iconica Yulia Timoshenko (la controversa eroina della Rivoluzione Arancione che ha annunciato di voler correre alle elezioni del 2019) e si conclude in Croazia, presieduta dal 2015 dalla conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic, la persona più giovane mai chiamata a ricoprire la massima carica dello Stato, e la prima a rimuovere dal palazzo presidenziale il busto del maresciallo Tito.
Pare che in Europa la leadership della destra, in tutte le sue cinquanta sfumature di nero, si declini preferibilmente al femminile. E visto che perfino da noi l’unica donna capo di partito è Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, da poco raggiunta dalla «pitonessa» Daniela Santanché, possiamo dire che il problema con l’altra metà del cielo, una volta tanto, non ce l’ha solo l’Italia. Ce l’ha proprio la sinistra. (Negli Stati Uniti il problema ce l’hanno sia la sinistra che la destra, una che si mangia ancora le mani per aver puntato su Hillary, l’altra abbrutita da Trump e dal machismo dell’Alt-right, che vede una stridula femminista in ogni donna che lavora.)
Strano, vero? La parte politica che più si è battuta per l’emancipazione, i diritti e le pari opportunità sembra non fidarsi delle donne al comando. Mentre la destra, specie quella populista, trova in giovani, toste e spesso piacenti signore le portavoci ideali. I maschi bianchi impauriti dalla globalizzazione, destabilizzati dall’immigrazione, e magari tignosamente attaccati agli stereotipi di genere, pendono dalle loro labbra senza complessi. Sorprendente ma non troppo: in fondo il nazionalismo si è sempre appoggiato a una simbologia muliebre: da Marianna a Boudicca, le allegorie della Patria sono matrone più o meno discinte, spesso in pericolo, incatenate o concupite da stranieri libidinosi, che incitano il popolo protendendo le braccia tornite. «Nazione come incarnazione di una declinazione patriottica dell’amore romantico», secondo la definizione dello storico Alberto Maria Banti: anziché soffrirne, le donne della destra europea si avvantaggiano, più o meno consapevolmente, dei residui, deboli ma persistenti, di un immaginario sette-ottocentesco maschilista soffuso di sottintesi sadomaso. Una narrativa in cui cent’anni fa il «villain» era, a seconda dei casi, il barbaro tedesco, l’infido ebreo o il russo belluino, e oggi è l’immigrato nero e/o musulmano, supposto violatore di tutto ciò che è violabile: donne e proprietà, chiese e quiete pubblica.
L’appeal di Szydlo e colleghe ha sì un piede nel passato, ma l’altro è ben calato nel presente. Proprio perché donne, appaiono come un’alternativa più netta a un ordine mondiale creato da maschi ricchi e benpensanti in giacca e cravatta, e allo stesso tempo rassicurano un elettorato che si sente sperduto, indifeso, non considerato da poteri patrigni, lontani e cattivi. In un certo senso le leader populiste sono l’apoteosi politica delle mamme cazzute che vanno a litigare con gli insegnanti dei figli perché dànno troppi compiti e fanno favoritismi. L’ «uomo forte» all’antica evocherebbe fantasmi militareschi troppo impegnativi per l’europeo moderno, nato, cresciuto e invecchiato nel più lungo periodo di pace mai vissuto dal Vecchio continente. Nell’era della pop-politica e dell’intimità quasi fisica fra il leader e il suo popolo, l’eccesso di testosterone non fa più sognare l’elettorato conservatore, tant’è che il tipo vincente fra i leader maschi populisti non è il caporione baffuto e mascelluto, ma l’elegante metrosexual con visetto cesellato, chioma ben curata e fisico da attore di soap-opera, vedi Geert Wilders, Sebastian Kurz e, in versione mediterranea, Luigi Di Maio. Perfino Matteo Salvini ha messo da parte le rudi canottiere bossiane e si è ingentilito: fra una ruspa e un post anti-migranti infila una copertina «desnuda» per Oggi e un’intervista in cui parla dei suoi figli e della (poca) cura della barba, e arriva a incassare e perdonare la scappatella ibizenca della fidanzata, accreditandosi presso le sue molte fan come maschio aperto ed evoluto. Ha imparato dal migliore, il maestro inarrivabile della trasformazione del privato in affare pubblico: Silvio Berlusconi, che a ottant’anni, truccato e tirato come Joan Collins, riesce a fare di acciacchi, cateteri e dentiere un’arma di seduzione elettorale.
Per le donne vale l’opposto: esporre il proprio privato non le rende più simpatiche, solo più vulnerabili e meno autorevoli. Devono essere sia Cesare che la moglie di Cesare: assertive e di polso, ma anche inappuntabili dal punto di vista morale. La seconda parte è più difficile della prima, perché nella pop-politica, mediatica e socialmediatica, la morale è anche estetica, e alla donna si rinfaccia tanto la mancanza di avvenenza, giovinezza e civetteria – vedi l’accanimento contro Rosy Bindi – quanto il suo contrario – vedi le campagne grilline «cosa faresti in auto con Laura Boldrini?» e i lazzi volgari, anche da sinistra, contro Maria Elena Boschi ben prima dello scandalo Banca Etruria. Lo stesso trattamento riservato, ai tempi del governo Berlusconi, a Mara Carfagna. Credete che all’estero siano più evoluti? Pochi mesi fa, dopo che Alice Weidel aveva condannato la «political correctness», il Crozza tedesco, Christian Ehring, l’ha presa in parola definendola nel suo show «troia nazista». Denunciato da Weidel, il comico è stato assolto in tribunale in nome della libertà di espressione: le figure pubbliche devono incassare gli sfottò, anche pesanti. Del resto, hanno aggiunto i giudici, «nazista» si riferiva alle posizioni oggettivamente estremiste dell’Afd, e «troia» ha sì una connotazione sessuale, ma «è stato usato solo perché si tratta di una donna e agli spettatore era chiaro che il termine non corrispondeva alla verità». Nella Germania di Angela Merkel, in un contesto di satira televisiva, è lecito dare della troia a una donna, a meno che non lo sia davvero.
Nessun paese è immune dal sessismo. E nessuno schieramento politico. Ma quello plateale e smaccato degli insulti degli oppositori forse fa meno danni del sessismo ipocrita, untuoso e sabotatore che le donne di sinistra incontrano nei loro stessi partiti. Il Pd è «ipnotizzato», come scrive Lea Melandri, «dalla schermaglia più o meno astiosa dei concorrenti alla leadership del partito, da cui le donne sembrano essersi ritratte, forzatamente ricondotte a spettatrici». Alle quali si chiede impegno, generosità e, soprattutto, obbedienza quando il partito chiede di farsi da parte. Esemplare il caso di Laura Puppato: nel 2010, dopo essersi fatta onore come sindaca di Belluno, era la concorrente più accreditata alla presidenza della regione Veneto, sostenuta da comitati locali e da Vip. Eppure il partito alla fine decise di candidare un uomo, Giuseppe Bortolussi, e perse le regionali; Puppato, che correva solo come consigliere regionale, fu eletta con numeri da record. Dopo la sua sconfitta alle primarie Pd del 2012 nessuna si è più azzardata a contendere agli uomini il timone del Nazareno. E malgrado il renzismo ci abbia offerto gran copia di ministre e portavoce, nessuna donna è stata candidata alla poltrona di sindaco di una grande città. L’atteggiamento del Pd rispetto alle donne rispecchia un po’ quello della coppia italiana rispetto alle automobili: in famiglia la donna guida sempre l’auto di cilindrata più piccola. Quella grande e potente è appannaggio dell’uomo, al massimo lei fa da copilota, anche se ha più punti sulla patente.
Più si va a sinistra, peggio è. L’imbarazzante foto di gruppo dell’esordio del tanto atteso nuovo soggetto, Liberi e Uguali, sembra scattata alla pizzata della squadra di calcetto: tutti maschi. Dopo che sul palco dell’Atlantico Live erano passate l’operaia della Melegatti, la ricercatrice del Cnr, le presidenti di Arci e Legambiente: virtuose figurine, perfette per scaldare la platea con funzione di décor politico-emozionale. Ma lo stato maggiore di Liberi e Uguali è for men only, in un momento in cui il tema della violenza di genere è all’ordine del giorno in mezzo mondo. Roba che al confronto il M5s, con Raggi, Appendino, Taverna e Rocchi, pare un collettivo femminista. All’ombra di un padre-padrone di nome Beppe Grillo, certo; sta di fatto che all’ombra di D’Alema, padre nobile di Liberi e Uguali, per ora donne non se ne vedono. «Proprio quando la destra sceglie di rappresentarsi con le donne,» si dispera Silvia Garambois su Strisciarossa, il sito degli ex dell’Unità. Già, ma è anche vero che solo a sinistra le donne si vergognano di voler comandare. Che sia una velenosa eredità del pensiero della differenza, la corrente filosofica femminista made in Italy che ha influenzato tutta una generazione di donne di sinistra? A forza di insistere sullo «specifico femminile», fondato sulla relazione e connotato dal lavoro di cura e di accoglienza, ha finito per colpevolizzare nelle donne l’aspirazione al potere, alla leadership, vista come un concetto naturaliter maschile. Quelle come Boschi, Madia e Pinotti, che non cercano la maternità o non se ne lasciano condizionare, non sono viste come un modello di empowerment e di emancipazione per le giovani donne, ma vengono giudicate divisive: vogliono fare le prime della classe, e chi non ce la fa o non se la sente fa la figura della «meno brava».
A destra certe paturnie non hanno mai attecchito: sotto sotto è rimasta «il mondo soldatesco e affamato, in cui la presenza femminile appariva a stento e scompariva presto, a meno che non sviluppasse qualità amazzoniche, militari, maschili» di cui ha scritto Alessandro Giuli sul Foglio. Secondo cui Giorgia Meloni riassume tutto l’album genealogico delle donne della destra italiana: un po’ donna Rachele, un po’ valchiria, un po’ ausiliaria della Rsi, il tutto condito da una voce roca e romanesca da Evita della Garbatella che fa un po’ simpatia e un po’ paura. Meloni deve misurarsi «solo» con il sessismo dei maschi. Non deve anche rendere conto delle sue scelte personali a una platea femminile criticona e competitiva come quella che giudica le colleghe di sinistra. Pure lei si è sentita dire «faccia la mamma», quando pensava di candidarsi a sindaca di Roma durante la sua gravidanza. Ma glielo disse Guido Bertolaso di Forza Italia, non una compagna di partito.
Pubblicato il 12 dicembre 2017