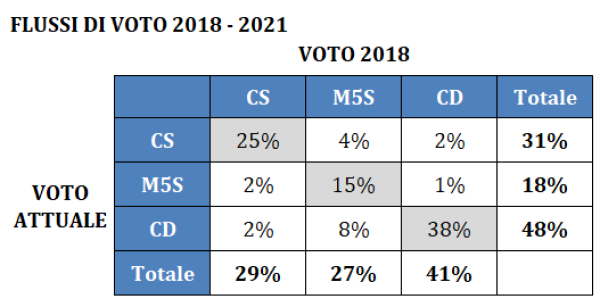C’era una volta in Italia la sinistra. Era per lo più comunista e stava all’opposizione. Un’opposizione numericamente importante e molto influente a livello sociale. Al governo invece, dalla fine della guerra sino a tangentopoli, stava la democrazia cristiana, un partito un po’ cattolico, un po’ di destra ma anche un po’ di sinistra. Con Craxi il partito socialista, che era stato di sinistra, passava dall’opposizione al governo, diventando anch’esso di centro. Questo equilibrio tra sinistra di piazza e centro di governo ha funzionato per decenni, dando luogo a politiche economiche e sociali – di tipo keynesiano – capaci di creare un benessere diffuso ed esteso a diversi strati della popolazione. Eppure il miracolo italiano si fondava su un equivoco ideologico.
Soltanto la DC è stato infatti il movimento che ha davvero perseguito in Italia politiche keynesiane, mentre il PCI (insieme ai socialisti del dopoguerra) era un movimento politico profondamente legato al marxismo sovietico, che – di conseguenza – non ha mai condiviso ideologicamente quelle ricette. I comunisti accettavano le politiche democristiane, certo, ma esclusivamente per pragmatismo ed esigenza tattica, perché – rispetto alle ricette proposte dai liberali – il keynesianesimo democristiano conduceva a risultati più favorevoli per proletari e impiego pubblico (tradizionali bacini elettorali del PCI). Ma i comunisti, quelle ricette, non perdevano occasione per criticarle con forza “da sinistra”. Keynes – in altre parole – non è mai stato “abbastanza socialista” per un partito che considerava ancora Mosca il suo modello ideale di società. Dunque occorre dirlo chiaro: i nostri socialisti (quelli ortodossi) non sono mai stati keynesiani e mai hanno considerato Keynes “uno dei loro”. Del resto, non poteva che essere altrimenti, essendo noto che lo stesso J.M. Keynes aveva criticato il marxismo, giungendo a dichiarare apertamente di non riuscire a capirlo e di non trovarvi nulla di interessante.
A riprova di questo atteggiamento del socialismo storico nazionale verso l’economista britannico citiamo qui sotto – dal sito dell’Avanti – ampi stralci di un articolo di Gianfranco Sabattini del 26 novembre 2019 in cui si riassumono con chiarezza le ragioni per cui i socialisti ortodossi affermavano (ed affermano anche ora) che Keynes non poteva essere considerato socialista. “Poiché (Keynes, n.d.r.) non aveva previsto la necessità di allargare l’intervento pubblico, sino a realizzare un socialismo di Stato che abbracciasse la maggior parte della vita economica della collettività, Keynes, per i suoi critici marxisti, non è possibile ritenerlo un socialista; anche perché, essendosi egli limitato ad affermare che, per assicurare il pieno impiego dei fattori produttivi, non è tanto necessario che lo Stato assuma la piena proprietà dei mezzi di produzione, quanto che agisca con la sua diretta iniziativa per promuovere un volume complessivo di produzione corrispondente alla piena occupazione, la teoria neo-classica che lui criticava ha avuto modo di riproporre la validità dei suoi algoritmi. Il non-socialismo di Keynes, quindi, non sarebbe tanto motivato sulla base del rifiuto del socialismo di Stato, quanto sul fatto che le sue prescrizioni varrebbero a riproporre la validità della teoria neo-classica, sia pure in presenza dell’azione diretta dello Stato, per stabilire un volume complessivo di produzione tale da richiedere la piena occupazione”. Per proseguire così: “Keynes, quindi, non può essere considerato un socialista, perché la sua analisi non coglie le contraddizioni intrinseche all’ordinamento del capitalismo, e perché la sua critica al pensiero economico tradizionale è limitata al rifiuto della validità solo di due dei massimi principi del liberalismo: il primo, che ogni singolo soggetto sociale, perseguendo egoisticamente la propria felicità, concorra a realizzare quella di tutti; il secondo, che il mercato sia il sistema in grado di contribuire, meglio di ogni altro, alla ricchezza generale e all’equa distribuzione del prodotto sociale. Con ciò Keynes avrebbe concorso a salvare il capitalismo, limitandosi ad indicare quanto di esso può essere salvaguardato per assicurare l’uso efficiente delle risorse”. E chiudere con un perentorio “ciononostante, il mito di un Keynes socialista si è stato preservato e il suo pensiero ha continuato ad essere proposto come alternativa all’economia di mercato e all’ideologia propria del liberalismo. In realtà, la sua critica alla teoria neo-classica non ha nulla a che vedere con la critica marxista del modo di produzione capitalista; ciò perché la critica keynesiana non è stata volta al superamento della logica del profitto, ma è stata orientata a porre rimedio alle sue contraddizioni, solo attraverso una “macro-gestione tecnica” dell’economia. Troppo poco perché Keynes possa essere considerato un socialista; secondo i critici marxisti, la sua denuncia dei presunti malfunzionamenti del capitalismo “liberale” non gli ha consentito di proporre una strategia politica, economica e sociale con cui “salvare” la civiltà nel lungo periodo”.
La cartina al tornasole di come stessero davvero le cose tra socialisti e keynesiani è del resto rappresentata dal rapporto della sinistra storica con la classe media italiana. La DC ha infatti costruito il proprio successo politico proprio sulla creazione del benessere in una ampia classe media che potremmo definire come “trasversale” (usando le categorie marxiste), in quanto composta tanto da dipendenti privati e pubblici (dunque da proletari) quanto da piccoli imprenditori, artigiani e professionisti (dunque da soggetti che erano detentori di mezzi di produzione). I socialisti ortodossi e i comunisti invece – ragionando in termini marxisti e leninisti – dividevano la classe media in due categorie: i lavoratori dipendenti, che erano dei proletari da tutelare, e tutti gli altri che invece erano kulaki ai quali espropriare (a colpi di tasse) il capitale e i mezzi di produzione. La sinistra storica italiana ha dunque – per decenni – sostenuto e alimentato la divisione sociale tra la classe media “buona” da tutelare e quella “cattiva” da colpire, laddove la DC ha cercato sempre una sintesi nel benessere diffuso, mirando a trasformare gli ex proletari in piccoli borghesi.
Tangentopoli, come è noto, spazzava via DC e pentapartito. Il vuoto politico veniva però rapidamente occupato da Berlusconi che, essendo un uomo d’impresa, non comprendeva immediatamente che il successo dello scudo crociato non era fondato sull’anticomunismo in quanto tale, bensì su una abile disattivazione per via keynesiana delle derive marxiste della porzione “proletaria” del ceto medio. Berlusconi voleva diventare un Craxi o un Andreotti senza averne compreso fino in fondo la politica. Questo spiega perché lo stesso Berlusconi – cavalcando l’onda della caduta del muro di Berlino – si impelagava in una retorica liberale (del tutto estranea al sentire dell’ex democristiano di classe media) e anticomunista (sentimento invece ben radicato nei “kulaki” nazionali). Il tutto col risultato di aggravare la polarizzazione e la divisione nella classe media del paese, dunque – in sostanza – facendo, a differenza della DC, esattamente il gioco della sinistra ex comunista, che ovviamente non chiedeva di meglio per proseguire coi vecchi slogan, dunque accusando Berlusconi di essere un fascista e l’amico degli evasori-kulaki e – di conseguenza – il nemico giurato di chi aveva il cuore a sinistra.
Guardando tuttavia ai programmi del centrodestra del post-tangentopoli, si nota come – passando il tempo – Berlusconi, dopo un inizio dai toni assai “liberali”, si sia via via spostato verso politiche di stampo più democristiano. Col tempo, probabilmente, Berlusconi aveva intuito cosa la DC voleva essere e perché ha avuto successo. Il punto che mancava a Berlusconi – o che forse ha realizzato solo quando era tardi – era che la DC era stata in grado di “disattivare” i marxisti con le politiche keynesiane, perché lo stato, in passato, era libero di far due cose: svalutare la moneta e far emettere alla banca d’Italia moneta per acquistare i titoli del debito pubblico emessi dal tesoro. Il miracolo italiano indotto dal keynesianesimo non socialista della DC era stato infatti finanziato con debito pubblico monetizzato e sostenuto da svalutazioni competitive della lira al fine di rafforzare l’esportazione senza dover ricorrere alla compressione salariale per recuperare competitività. Dunque Berlusconi non si è accorto che – a partire dal divorzio tra Banca d’Italia e tesoro ma, soprattutto, con l’adesione dell’Italia all’Euro e al trattato di Maastricht – riproporre la politica keynesiana con cui la DC aveva reso benestanti così tanti italiani, creando una classe media “allargata e trasversale” che aveva lasciato in panchina per diversi decenni i comunisti, era diventato impossibile.
In quegli stessi anni, la sinistra che era stata comunista – pur accogliendo nel partito esponenti della DC (in particolare i dossettiani facenti capo a Prodi) – anche dopo la caduta del muro di Berlino era invece restata leninista, seguitando tetragona a perseguire l’ideale dell’ugualitarismo “al ribasso”. Laddove la DC aveva cercato di usare la spesa pubblica – finanziata col debito pubblico – per creare una sempre più ampia classe media (dunque con una spinta a migliorare il tenore di vita dei lavoratori dipendenti), la sinistra, anche dopo tangentopoli, continuava invece a concepire l’intervento pubblico essenzialmente come strumento – fondato sul prelievo fiscale – per “redistribuire” la ricchezza, dunque per rendere tutti uguali, ma al ribasso. In breve: mentre la DC voleva (ed era riuscita per decenni a) usare il debito pubblico per rendere borghese il proletario, la sinistra italiana ha sempre voluto (e vuole ancora oggi) usare le tasse per ridurre il borghese alla condizione di proletario.
La maniera in cui gli ex comunisti intendono l’uguaglianza è tuttavia, paradossalmente, quella che risultava più gradita ai nuovi padroni della globalizzazione: assai più del vecchio keynesianesimo democristiano. Questo spiega perché a “spingere” tangentopoli (ma soprattutto le riforme che sono seguite alla mattanza del pentapartito) ci siano stati interessi finanziari e imprenditoriali (anche stranieri) di vario tipo e genere. Anzi, spiega bene perché quegli stessi interessi avessero iniziato a “lavorare ai fianchi” il sistema democristiano ben prima di tangentopoli, a partire appunto dal divorzio tra bankitalia e Ministero del tesoro, che può considerarsi senza dubbio l’inizio della fine del keynesianesimo all’italiana. Può dunque essere il caso di fare una breve digressione sul tema.
Il libero mercato – in mancanza di correttivi adeguati – spinge naturalmente il lato dell’offerta verso le concentrazioni e l’oligopolio. E gli oligopolisti, non dovendo per definizione temere la concorrenza dei loro pari, finiscono per concepire la questione della produttività in termini di ricerca tecnologica e riduzione di costi. Dal canto suo, il sistema finanziario – che nel frattempo, anche in Italia, aveva visto la cancellazione della distinzione tra banche d’affari e banche a tutela del risparmio e del credito diffuso – non vedeva di buon occhio politiche espansive, in quanto potenzialmente inflattive, e per altro verso aveva tutto l’interesse a prestare danaro ai “solidi” oligopolisti piuttosto che non alla piccola borghesia imprenditoriale, meno remunerativa in termini di rendimento e meno affidabile in termini di solvibilità. Se dunque lo stato non poteva più iniettare ricchezza nell’economia usando il debito monetizzato, ecco che le banche potevano sostituirlo, ovviamente lucrandoci sopra. Ma, a differenza dello Stato che era stato disposto per ragioni politiche a “finanziare” ampiamente anche la piccola borghesia imprenditoriale, le banche (ormai tutte banche d’affari) avevano un chiaro interesse a prestare soldi esclusivamente alle imprese più “performanti”, ossia quelle grandi e strutturate. Per altro verso, se lo stato dismetteva le sue partecipazioni nelle grandi imprese pubbliche, ecco che le finanziarie di venture capital potevano sostituirlo, ma per fare utile. E, anche qui, investire soldi in grandi imprese in situazione di oligopolio era certamente un affare assai più lucrativo che non tutelare il risparmio e far credito alla piccola e media impresa. Infine, se lo stato non poteva più far debito pubblico “facile”, l’inflazione restava bassa e le imprese potevano comprimere i costi, soprattutto quello del lavoro. Una situazione che conveniva sia alle grandi imprese (che tagliavano i costi invece che fare ricerca e innovazione) sia alle banche (che potevano iniziare a fare credito al consumo anche ai lavoratori a basso reddito che non erano più in grado di risparmiare).
Questo significa, in sostanza, che tanto gli oligopolisti quanto le grandi banche d’affari e i grandi investitori istituzionali – tra le altre cose – erano (e sono) tutt’altro che contrari, da un lato, alla distruzione della piccola e media impresa (concorrenti fastidiosi e debitori meno affidabili) e, dall’altro, a un’economia a crescita moderata, sostenuta dal lavoro di una massa di proletari poco pagati e finanziata da un sistema creditizio che elargisce prestiti a tassi contenuti alle poche imprese di grandi dimensioni che in tal modo si spartiscono il mercato esercitando una posizione dominante collettiva. Ecco dunque spiegate le ragioni per cui tanto la finanza quanto la grande impresa sono state disposte a scendere a patti con gli eredi della nostra sinistra storica, ad esempio concedendo che alla massa degli ugualmente poveri – invece di un lavoro stabile e adeguatamente remunerato – fosse concesso, ad integrazione di impieghi precari e poco pagati, un sussidio o qualche posto pubblico precarizzato.
Da parte sua, alla sinistra che era stata comunista, bastava rinunciare al dogma del monopolio pubblico dei fattori produttivi e i termini dell’accordo col grande capitale erano belli e pronti: riduzione complessiva del welfare pubblico e aumento della tassazione sulla classe media (anche su patrimonio e risparmio) con utilizzo delle risorse, da un lato, per fornire servizi gratuiti di assistenza solo ai cittadini in situazione di indigenza certificata e, dall’altro lato, per attuare politiche di incentivo sul lato dell’offerta di fatto accessibili solo per le grandi imprese e i grandi operatori finanziari e – infine – concedendo dei sussidi assistenziali agli inoccupati e/o ai salariati sottopagati, con conservazione delle “vecchie” garanzie di stabilità e progressione salariale solo per il pubblico impiego, al prezzo – per il settore privato – di accettare una generalizzata compressione dei salari e una progressiva precarizzazione del lavoro (compensata appunto dai sussidi di stato).
Tra sinistra ex comunista, grandi oligopoli nazionali e stranieri e finanza internazionale si è insomma creata – a partire dagli anni novanta del secolo scorso – una convergenza di interessi nel senso di trasformare progressivamente l’Italia (ma il discorso vale anche per altri stati del sud Europa, come ad esempio Francia e Spagna) da una società del welfare diffuso in una società orizzontale di ugualmente poveri e sussidiati, sostenuta dall’influenza degli oligopoli e della finanza così come dal voto dei rentier così come dei poveri sussidiati, di quello dei dipendenti privati sindacalizzati e delle varie burocrazie e clientele pubbliche. Nel contesto di questo nuovo modello sociale, gli ex comunisti potevano infatti ritagliarsi il ruolo di elite burocratica e politica che gestisce il potere e le risorse pubbliche (dunque, grosso modo, il ruolo che avrebbero rivestito in un sistema di socialismo reale), lasciando tuttavia agli oligopoli privati sostenuti dalle banche e dagli investitori istituzionali (invece che alle imprese di stato) il compito di dare lavoro (poco pagato) ad una parte della popolazione attiva e di creare la ricchezza necessaria per consentire allo stato di distribuire ancora salari e posti pubblici e/o sussidi agli inoccupati. Il tutto garantendo la presenza costante nel paese di una grande massa di cittadini impoveriti e sussidiati e di dipendenti pubblici che, avendo un interesse alla continuità del “sistema”, sarebbero stati elettori assai fedeli di quella stessa sinistra che faceva favori ai loro padroni. E quando i poveri autoctoni hanno iniziato a scarseggiare (per ragioni demografiche), ecco che la soluzione per mantenere il sistema in piedi veniva immediatamente trovata dalla nuova sinistra nell’importazione dei poveri da altri paesi, mediante una politica dell’immigrazione (e – in prospettiva – della concessione della cittadinanza) a maglie a dir poco larghe.
Il vecchio comunismo socialista, a valle dello schianto del blocco sovietico, si è insomma evoluto in un neo-statalismo più mercantilista che marxista, nel senso che diversi principi tradizionali della vecchia sinistra ortodossa sono stati sacrificati dai post comunisti sull’altare dell’alleanza strategica con gli interessi degli oligopoli e la finanza. Questa è dunque l’essenza ultima dell’azione politica delle forze della neo-sinistra italiana (PD e M5S), ma che ispira anche – in Europa – la cosiddetta “grande coalizione” tra popolari e socialisti. Questa deriva del resto spiega bene anche perché l’ex PC (ora PD) manifesti di recente sempre più forti simpatie sia verso i democratici americani e professi una incondizionata adesione, per non dire aperta sudditanza, vero le politiche rigoriste e deflattive dell’UE a trazione tedesca. I post comunisti di casa nostra sono fatalmente attratti dal vincolo esterno dell’UE rigorista e deflattiva, in quanto vi scorgono – analogamente a quanto accadeva con l’URSS prima della caduta del muro – l’appiglio ideologico ideale per continuare la loro narrazione fondata sull’eterna lotta al kulako che impoverisce il proletario. Certo, tutto questo avviene al prezzo di consegnare il tenore di vita del proletario ai padroni delle ferriere e ai grandi banchieri. Però, tutto sommato, se quei padroni sono pochi, dare in pasto agli elettori di sinistra la rovina della piccola borghesia potrebbe bastare per evitare che la base elettorale del partito scenda al di sotto di un certo livello. Il resto lo fanno il deep state, l’informazione e la cultura “amiche” oltre naturalmente all’influenza economica di quegli stessi padroni. Sinora peraltro, lo schema ha funzionato molto bene, contando che il PD è da dieci anni che governa senza quasi mai aver vinto le elezioni.
Per giungere ad un simile risultato, come si diceva, la sinistra giallorossa ha accettato di sacrificare il tema del benessere diffuso dei cittadini in nome dell’ugualitarismo classista al ribasso, “finanziato” e sostenuto dalla pretesa maggiore efficienza, in termini aggregati, dal mercato oligopolistico a trazione finanziaria e dalle politiche deflattive e rigoriste imposte all’Italia dai paesi del nord Europa per mezzo del vincolo esterno dell’UE. La nuova sinistra ha smesso di promettere progresso economico al paese, riducendosi a garantire ai suoi elettori che – nella decrescita – almeno il loro vicino di casa non potrà avere qualcosa più loro (tutto questo, ovviamente, al prezzo di far accettare a quegli stessi elettori che i pochissimi padroni del vapore abbiano tantissimo). La deriva dalle “sorti progressive” di un tempo verso la decrescita felice con sollecitazione dell’invidia verso il kulako di oggi, insomma, è il destino cui vanno incontro gli eredi della tradizione del PCI così come gli ex contestatori del sistema a suon di vaffa. Un destino mesto e – visti i presupposti ideologici di partenza – ben poco esaltante. Non stupisce dunque che la “nuova sinistra” sia oggetto di critica anche “da sinistra”.
Di recente si sono moltiplicate infatti nel dibattito le voci che, dichiarandosi “di vera sinistra”, sostengono che la neo-sinistra piddo-grillina sarebbe niente meno che “neoliberista”, dunque omettendo di considerare che il fatto che la sinistra attuale di certo ha abbandonato alcuni dogmi marxisti, ma in compenso è restata classista (seppure restando legata alle classi ottocentesche, senza essere capace di usare l’analisi marxista per rileggere i rapporti di classe alla luce della situazione sociale attuale) e pure in certo modo è ancora leninista nel suo odio per la classe media, dunque che – in sostanza – è ancora “un po’ comunista”. Ma è proprio qui che emerge il tic gauchista più duro a morire (e che, come vedremo, rende velleitari i tentativi di criticare la sinistra da sinistra): l’incapacità di separare Marx (e la sua teoria sociale ed economica) da Lenin (e il sistema di socialismo reale), con conseguente difficoltà a ripensare Marx in modo non integralista, vale a dire riuscendo a mettere in discussione alcuni dei suoi aspetti.
Quello che i neo-gauchisti faticano a intuire è probabilmente che la nuova sinistra “ufficiale” – ossia PD e M5S – persegue in fin dei conti lo stesso fine ultimo di Marx (uguaglianza di un popolo fatto quasi solo di lavoratori dipendenti) per mezzo di una struttura sociale simile a quella che voleva lo stesso Lenin (elite ristretta che gestisce in autonomia e in modo centralizzato il potere politico ed economico), con la differenza però che – per la neo-sinistra in salsa europeista giallorossa – gli apparati politici e burocratici occupati dal partito spartiscono l’appartenenza alla cerchia della ristretta elite di potere con pochi grandi (oligo)capitalisti e con i padroni della moneta privata (dunque non rispettando il dogma marxista della proprietà pubblica dei mezzi di produzione). Siccome però lo stesso Marx sosteneva che la società comunista sarebbe sorta spontaneamente per effetto delle contraddizioni del capitalismo (mentre Lenin, con la dittatura del proletariato e il socialismo reale sovietico, intendeva solo dare un “aiutino” alla storia per velocizzare il processo dialettico), ecco che per un elettore medio di sinistra (che sia poco attento all’ortodossia ideologica, ma dotato della naturale invidia che spesso lo connota) è possibile leggere questa nuova fase come un passaggio intermedio (alternativo al socialismo reale ispirato al leninismo) nell’evoluzione del sistema capitalistico verso la società comunista dell’uguaglianza (al ribasso) che da sempre quel tipo di elettore vagheggia. Ed ecco spiegato il modo in cui la sinistra giallorossa – facendo leva in pratica solo sull’invidia sociale – riesce ad autoassolversi davanti a Marx, continuando ad apparire “autenticamente di sinistra” ai suoi elettori. Questa è del resto anche la ragione per cui i post comunisti del PD (così come i neo pauperisti del M5S) non hanno avuto problemi di sorta a mandare al macero il Keynesianesimo per sposare una specie di leninismo del mercato capace di sostenere al contempo gli oligopoli e le grandi banche, il rigore dei conti pubblici, la disoccupazione assistita, il reddito di cittadinanza e il mercantilismo globalista. Anzi, proprio la deriva antikeynesiana dei postcomunisti da quando sono arrivati al governo, rappresenta la conferma definitiva del fatto che il comunismo italiano non è mai stato keynesiano, ma – nella sua effettiva attuazione in prassi politica – profondamente leninista e sovietico (ancor più che marxista).
Chi invece critica la nuova sinistra da sinistra lo fa proponendo un “ritorno” al modello di sviluppo keynesiano, sul presupposto che quel modello sarebbe “autenticamente di sinistra”, perché corrisponde a quello pensato dai vecchi comunisti e socialisti italiani che hanno contribuito alla stesura della carta costituzionale. Il problema è che, a differenza della DC (e degli altri partiti che poi avrebbero costituito il “pentapartito”) che erano keynesiani, il socialismo tradizionale e il comunismo in Italia – come si è visto all’inizio di questo scritto – non sono mai stati keynesiani. Questo significa che i “neo socialisti costituzionali” di oggi si trovano costretti a proporre, spacciandola per autenticamente di sinistra, una costituzione economica (keynesiana) che i veri marxisti e socialisti dell’epoca (cui, si badi bene, questi nuovi “veri socialisti” vorrebbero ispirarsi) criticavano duramente proprio perché non la consideravano abbastanza socialista. Il che finisce per disorientare – inconsciamente – l’elettore medio di sinistra, per il quale essere di sinistra, proprio grazie alla lunga stagione del PCI, non può significare tornare alle politiche democristiane, ma semmai consiste nel considerare ancora il kulako come la sola causa di tutti i mali dei poveri, con la conseguenza che, per l’elettore medio che si riconosce nell’ideologia delle sinistra storica italiana, è difficile pensare che possa essere essere davvero “di sinistra” una qualunque proposta di politica economica che consente ai bottegai o agli idraulici di arricchirsi più degli operai.
Criticare la sinistra giallorossa “da sinistra”, nel nome della tradizione socialista e comunista, non porta dunque molto lontano, per il semplice fatto che i cittadini che mettono l’uguaglianza davanti alla crescita equilibrata della ricchezza (tratto assai comune a sinistra, sia nell’elettorato del vecchio PCI che in quello piddo-grillino cresciuto a pane e odio verso Berlusconi) si sono ormai quasi tutti naturalmente convertiti alle idee della “nuova” sinistra giallorossa, parte politica che sostiene con forza la retorica (tradizionale del comunismo italiano ma proseguita con l’antiberlusconismo) della lotta alle disuguaglianze mediante la disgregazione del benessere del ceto medio. I giallorossi, dunque, in sostanza cercano e trovano ancora i loro voti come i loro illustri predecessori, essenzialmente aizzando la massa degli ultimi contro i penultimi, ma lo fanno ora per favorire (oltre a sé stessi a livello politico) i pochissimi primi del grande capitale globalizzato. I nuovi “keynesiani socialisti” si sforzano invece di criticare la sinistra giallorossa sostenendo le stesse ricette democristiane che il socialismo tradizionale in passato non ha mai condiviso ideologicamente, ma anzi ha sempre attaccato. Critica che – dunque – è inevitabilmente destinata ad infrangersi contro la spessa coltre di invidia sociale che la sinistra ufficiale (comunista prima e antiberlusconiana poi) non ha mai smesso di creare nel paese dal dopoguerra ad oggi.
Tutto questo mi porta a concludere che, se qualcuno volesse proporre oggi in modo credibile il ritorno alle ricette dell’epoca d’oro del dopoguerra keynesiano, dovrebbe per prima cosa avere il coraggio di smarcarsi dall’eredità ideologica comunista e socialista, rifacendosi assai più a un De Gasperi e a un Mattei piuttosto che non, tanto per fare quale esempio illustre, a un Lelio Basso o a un Berlinguer. Ma i neogauchisti di casa nostra questo difficilmente potranno farlo, in sostanza perché sono ancora dei nostalgici, che – a livello profondo – non hanno ben metabolizzato la caduta dell’URSS, non accettando in particolare il dato storico per cui il socialismo reale sovietico è fallito perché modello economico meno efficiente, in termini di produzione di ricchezza aggregata, rispetto al mercato. Riconoscere questo, infatti, li avrebbe obbligati ad ammettere che la strada per l’attuazione del marxismo pensata in URSS (e risalente al bolscevismo leninista) non rappresenta più il modello cui un marxista moderno dovrebbe ispirarsi per far evolvere il capitalismo nella società comunista descritta da Marx. Questa resistenza inconscia a restare marxisti pur “lasciando Mosca” fa in modo che la maggior parte di chi critica la sinistra da sinistra non riesca a collocarsi politicamente: risulterà infatti non abbastanza “socialista” (nel senso non sufficientemente anti piccolo borghese) per la massa dei convertiti alla neo-sinistra piddo-grillina dell’invidia sociale, sarà ovviamente troppo marxista per i liberali ma – quel che è paggio – risulterà ancora troppo “comunista” per tutti i moderati (di centro) che, non essendo liberisti, sarebbero comunque a favore di politiche keynesiane volte a creare un benessere maggiore e diffuso. I nostalgici del socialismo postbellico (quello comunista e marxista), nella misura in cui parlano da Keynesiani ma usando come auctoritas dei padri costituenti socialisti e comunisti, si condannano dunque all’irrilevanza politica.
Dalla sostanziale sterilità delle critiche “da sinistra” alla nuova sinistra si deduce che quello che con ogni probabilità manca nel nostro panorama politico e sociale – come credibile antitesi dialettica del pensiero unico vertente sul dirigismo oligopolistico e mercantilista del nuovo centro-sinistra giallorosso – è un movimento keynesiano, che – senza cercare padri nobili o geniture ideologiche nella tradizione socialista e comunista del dopoguerra – metta semplicemente al centro del proprio programma delle politiche economiche espansive e anticicliche. Un movimento che, in altre parole, persegua – restando equidistante sotto il profilo ideologico tanto dal socialismo quanto dal neo-liberalismo classico – la creazione di un benessere diffuso e ben distribuito mediante lo stimolo alla domanda interna e la creazione di lavoro, evitando di cadere nella facile retorica della dekulakizzazione del ceto medio così come nella facile scappatoia dell’assistenzialismo strutturale come misura idonea per risolvere il problema della povertà indotta dalla carenza di lavoro. D’altro canto, questo movimento neo-keynesiano dovrebbe respingere con decisione una serie di concetti liberali che invece oggi vanno per la maggiore, quali l’austerità come virtù a prescindere, l’inoccupazione sussidiata e la estrema flessibilità del lavoro come valido strumento di soluzione del disagio sociale, il taglio della spesa pubblica come bene assoluto e l’inflazione come male assoluto. Sul versante dell’impiego pubblico, essere keynesiani vuol dire ammettere che assumere dipendenti pubblici (o investire in appalti pubblici) per fare cose utili è cosa buona, mentre non essere socialisti significa riconoscere d’altro canto che invece non è affatto cosa buona assumere persone che non vanno a fare cose utili né è cosa buona finanziare con danaro pubblico attività inutili. E si noti che mi sono riferito ad attività “utili” e non “necessarie”, per sottolineare che l’impiego di risorse pubbliche nell’economica non va ritenuto un male da ridurre al minimo, bensì – quando serve a far qualunque qualcosa che vada oltre il solo fatto di dotare di reddito spendibile una persona (per quello basta il reddito di cittadinanza, che è misura più socialista che keynesiana) – è comunque un arricchimento per il paese. Il debito pubblico è infatti ricchezza privata. Essere keynesiani ma non liberisti, infine, dovrebbe significare anche – contro i dogmi del capitalismo finanziario – riconoscere che il credito e le banche devono avere anche la funzione di favorire il risparmio diffuso e l’incentivo a far credito alla piccola e media impresa territoriale, non rappresentando solo strumenti per la moltiplicazione del danaro e per l’investimento speculativo.
Si tratta peraltro di principi tutti ampiamente riconosciuti nella nostra Costituzione (che ha un impianto keynesiano, anche se questo assetto deriva in realtà dal compromesso tra liberali e comunisti, sotto la spinta del mondo cattolico) e che si pongono nel solco della dottrina sociale tradizionale della chiesa cattolica, ai quali potrebbero dunque prestare adesione sia elettori liberali moderati, sia di area cattolica. Per altro verso, si tratta di principi che non dovrebbero dispiacere a quegli elettori di sinistra, che hanno saputo superare il “trauma sovietico” e la retorica leninista fondata sull’invidia sociale verso il kulako.
Per tutti questi elettori il mercato può insomma ancora ben rappresentare la trave portante dell’economia nazionale, a patto che non si guardi con sfavore preconcetto – come invece predica la vulgata attuale del mainstream mercantilista della nuova sinistra europea – all’intervento pubblico per stimolare la domanda interna e la crescita della piccola e media impresa. Si badi bene, infatti, che anche nella società del mercantilismo oligopolista a trazione finanziaria vengono spesi soldi pubblici. E ne vengono spesi anzi parecchi, ma solo per alimentare le burocrazie e le clientele pubbliche e per incentivare le grandi imprese e banche private. Chi invece lavora nel privato (dipendente o kulako che sia), viene tagliato fuori dal circuito degli incentivi e, anzi, è chiamato a subire (sia fiscalmente che a livello di reddito) la forte deflazione artificialmente indotta dal meccanismo del rigore dei conti pubblici in presenza di una alta spesa pubblica di cui non può beneficiare. Un movimento neo keynesiano (non socialista) dovrebbe dunque proporsi come interprete della coscienza di classe di questa ampia e trasversale categoria di classi lavoratrice e produttrici oppresse dai percettori di rendite pubbliche e private. Che poi è quello che era riuscita a fare – più o meno consapevolmente, grazie al gioco delle correnti interne – la vecchia democrazia cristiana.
Certo, per portare avanti una linea politica di questo genere occorrono risorse (che non siano reperite nei redditi e nei risparmi del ceto medio lavoratore). Questo significa che, per attuare il paradigma keynesiano in un sistema di economia di mercato, diviene ineludibile sottrarre i decisori politici alla necessità di farsi prestare le risorse della finanza privata, che in cambio chiede incentivi alla produttività, strette fiscali mirate sui lavoratori, precariato e compressione salariale. Dunque, voler essere keynesiani oggi in Europa significa mettere sul tavolo il tema di un ritorno alla possibilità per le banche centrali di acquistare i titoli emessi dal tesoro e di emettere moneta per farlo, tornando ad agire come prestatori di ultima istanza. Inoltre, occorre anche affrontare la questione della restituzione ai governi nazionali della possibilità di svalutare competitivamente la moneta, invece di obbligarli – con un sistema di cambi fissi in aree economiche non omogenee – a svalutare il lavoro. Tutto questo porta inevitabilmente al “problema dei problemi”, rappresentato dal rapporto dell’Italia con l’Euro e con la costituzione economica del trattato UE.
Si tratta di un problema ormai ineludibile: la nostra costituzione economica è chiaramente keynesiana e dunque è ispirata a principi pressoché opposti rispetto a quella dei trattati fondamentali dell’UE. Questo significa che qualunque movimento che voglia oggi essere keynesiano ma non socialista deve dunque in certa misura essere anche sovranista (quanto meno sui temi di politica monetaria e sulla questione del controllo del tesoro sulla banca centrale). Quella del sovranismo in politica economica è infatti questione tutt’altro che ideologica, considerando che l’attuazione della nostra costituzione economica nazionale, in passato, ci ha resi ricchi ed ammirati nel mondo (tanto da giungere ad essere la quinta potenza economica mondiale), mentre – da quando abbiamo iniziato ad adeguarci alla costituzione economica impostaci dall’unione europea – ci siamo impoveriti progressivamente e, ormai, veniamo trattati dagli altri paesi dell’UE come uno stato mezzo fallito e come un popolo di incapaci e fannulloni. E la scusa della spesa pubblica eccessiva (con annessa retorica del “vivere al di sopra della proprie possibilità”) non regge di fronte alla constatazione che – prima dell’esplosione del debito da covid – il paese è stato in costante avanzo primario per due decenni e che, se il debito si allargava, era solo per pagare gli interessi su operazioni finanziarie (sbagliate) fatte dal Tesoro decenni addietro: interessi che, manco a dirlo, stanno arricchendo le grandi banche d’affari internazionali. In sostanza: siamo rimasti in debito per pagare interessi spropositati alle banche d’affari che ci avevano prestato soldi quando gli interessi erano alti e che, invece, noi dobbiamo restituire quando gli interessi sono bassi. Quello della spesa pubblica eccessiva è dunque un mito. Del resto, se fosse stato così, come si potrebbe spiegare il fatto che per decenni sono stati tagliati tutti i servizi pubblici, sono aumentate le imposte e il debito pubblico è comunque salito?
Dunque la verità è che gli stati del nord Europa è da decenni che ci legano mani e piedi – con regole unioniste di rigore di bilancio ritagliate per funzionare bene solo coi loro modelli economici – per poi poterci meglio accusare di non saper stare al loro passo ed obbligarci ad adottare misure di austerità che ci legano ancora di più. La cosa più grave non è peraltro la comprensibile volontà degli altri stati di perseguire il loro interessi nazionali a danno nostro, bensì il fatto che – qui da noi – tanto i liberal-liberisti all’amatriciana quanto gli ex comunisti e molti dei neo tribuni della plebe grillini (tutti folgorati sulla via di Bruxelles) si fanno in quattro per sostenere questa retorica anti-italiana, forse dimenticando che – quando quelle splendide regole unioniste non c’erano e dunque la piccola borghesia nazionale e le imprese di stato erano lasciate libere di fare “a modo nostro” – nel paese c’erano meno disuguaglianze e più ricchezza, tanto che erano gli stati del nord Europa a dover rincorrere noi.
Ma forse qualcosa si muove, per effetto dello scossone subito dal sistema per effetto del ciclone Covid. Se si presta attenzione alle fibrillazioni politiche seguite alla chiamata a Palazzo Chigi di Mario Draghi per guidare un governo di salvezza nazionale (e – soprattutto – a quelle attualmente in corso per il Quirinale), si comprende che in pentola sta bollendo qualcosa di grosso. Non credo che tutti gli attori politici del processo siano consapevoli di quel che sta accadendo, ma – per dirla con Hegel – la dialettica storica agisce spesso a prescindere dagli (e addirittura contro gli) intenti delle persone che di volta in volta la incarnano. Fatto sta che Mario Draghi è allievo di Federico Caffè, non è di certo né socialista né marxista, è vicino a certo mondo cattolico, non ha mai mostrato particolare simpatia per le politiche rigoriste dell’UE (dunque risultando inviso ai tedeschi), ma soprattutto a Rimini, l’estate dell’anno scorso, ha tenuto un discorso interessante (qui il mio commento). Inoltre – con le prossime elezioni politiche italiane e, ancora prima, con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica – assisteremo con ogni probabilità a uno spostamento verso destra (e verso una destra che include una forte componente sovranista) del baricentro politico delle istituzioni nazionali. Il che potrebbe favorire l’inizio di una stagione politica nel segno della discontinuità rispetto al decennio piddino prima e piddo-grillino dopo.
Contando allora che – nel frattempo – si svolgeranno anche elezioni politiche sia in Germania (con probabile vittoria dei falchi dell’austerità, che dovrebbero far cessare le attuali politiche monetarie espansive della BCE) sia Francia (in cui Macron è sempre più debole di fronte alla destra nazionalista e, in caso di cessazione della politica espansiva, si troverebbe a gestire un bilancio pubblico peggiore del nostro); ma contando anche sul fatto che è in atto da tempo un duro scontro a livello geopolitico tra Stati Uniti e Germania (sempre più vicina alla Cina e alla Russia); e contando infine sul fatto che gli Stati Uniti hanno adottato un poderoso pacchetto di stimoli economici monetari alla loro economia che andrà avanti qualche anno, mentre l’UE – sotto spinta della Germania e dei soliti “frugali” – sta già iniziando a mostrare i primi segni di voler cessare il quantitative easing post covid; tenendo conto di tutti questi fattori – dicevamo – il quadro geopolitico appare propizio per consentire un cambiamento di traiettoria in senso neo-keynesiano nella nostra politica economica nazionale. Stiamo dunque a vedere, perché viviamo tempi difficili ma anche interessanti e – forse – di svolta. Potrebbe essere infatti che questa volta la “crisi” sia vera, nel senso di corrispondere all’etimo greco della parola.