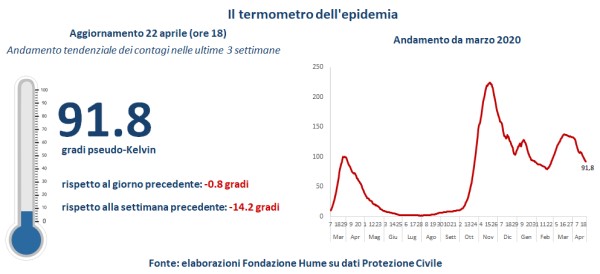Brevetti su standard essenziali e shortage di vaccini Covid.
Per questo contributo al sito della Fondazione torno a parlare di diritto, anche se di questioni legali che hanno a che fare col covid. Parto dalla considerazione che l’Italia ha pochi vaccini, in sostanza c’è (ma il discorso vale forse anche per il resto dell’Europa) un surplus di domanda rispetto all’offerta; il che – ovviamente – favorisce l’offerta. Di qui la stipulazione di contratti troppo favorevoli ai titolari dei vari brevetti sui vaccini (che, ovviamente, sono tutti brevettati). Sennonché l’Italia è uno dei principali fabbricanti di farmaci generici d’Europa, dunque avrebbe tutte le potenzialità per produrre da sé i vaccini che gli servono. Ovviamente, per farlo servirebbe il consenso dei titolari del brevetti. Ma siamo davvero sicuri che sia così?
Forse no. I giudici di tutta Europa – Corte di Giustizia UE inclusa – conoscono infatti l’istituto dei brevetti sui cosiddetti standard essenziali (standard essential patents o SEP). Il SEP è un brevetto che copre una tecnologia che è stata inserita, da un ente certificatore, nell’elenco di quelle necessarie per realizzare un certo tipo di prodotto (ad esempio di telefonia mobile). Questa situazione attribuisce al titolare del brevetto un potere di mercato assai maggiore – dunque sproporzionato – rispetto all’effettivo valore della singola tecnologia brevettata. L’esistenza dello standard e l’essenzialità delle tecnologie brevettate necessarie per realizzare prodotti conformi, in altre parole, crea un posizione dominante collettiva di cui beneficiano tutti quanti i titolari dei SEP necessari per realizzare un prodotto che rientri nello standard medesimo. E delle posizioni dominanti, anche se derivano da legittimi diritti esclusivi di proprietà industriale o intellettuale, non si può mai abusare, altrimenti si violano le norme antitrust.
Proprio per questa ragione le corti degli stati europei hanno iniziato a sostenere che – per i SEP – non vale il normale diritto di esclusiva brevettuale “pieno”, bensì un diritto “attenuato”, nel senso che chi intende utilizzare un SEP per realizzare un prodotto che rientri nello standard, ha la facoltà di chiedere al titolare una licenza non esclusiva a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (fair, reasonable and non-discriminatory, di qui – appunto – l’acronimo FRAND). Se il titolare del brevetto rifiuta una offerta che rispetta i criteri FRAND, il giudice di fatto ha il potere di “paralizzare” il diritto esclusivo del titolare, in quanto abuso di posizione dominante, non emettendo provvedimenti restrittivi che impediscano al terzo di attuare il brevetto e, nella causa relativa ai danni, condannerà il terzo solo a pagare il canone FRAND, evitando di gravarlo di spese processuali o di costi ulteriori. Inutile dire che, in una simile situazione, il titolare non avrà interesse a continuare a litigare con il possibile licenziatario, ma concederà una licenza a condizioni ragionevoli. Questo schema è stato avallato anche dalla Corte di Giustizia UE, dunque può dirsi ormai acquisito come fonte di principi generali validi sia in Italia che negli altri paesi UE.
Lasciando per un attimo sullo sfondo la questione – peraltro assai importante – della individuazione dei criteri per definire la equità e ragionevolezza del canone di licenza (questione su cui sia la dottrina che i giudici non sono ancora unanimi), possiamo concentrarci sul principio ispiratore di questo genere di licenze, per verificare che si tratta di strumento che intende rimediare ad un problema che presenta una stretta analogia con la situazione dei vaccini Covid. Anche per i vaccini, infatti, abbiamo a che fare con imprese (oltretutto grandi imprese) che – a causa dell’emergenza pandemica – sono titolari di brevetti il cui oggetto ha un valore di mercato assai maggiore (e dunque sproporzionato) rispetto all’oggettivo contenuto tecnologico di quello che, in fin dei conti, è un vaccino contro una nuova variante influenzale. I titolari dei brevetti sui vaccini in questione sono dunque in posizione (contingentemente) dominante rispetto alla domanda di vaccino da parte degli stati. Il che potrebbe giustificare l’applicazione per analogia della dottrina dei SEP anche ai brevetti sui vaccini covid, con conseguente possibilità per chiunque intendesse realizzare quei vaccini, di farlo alla sola condizione di essere disposto ad offrire ai titolari dei brevetti di accettare una licenza non esclusiva con canone e a condizioni FRAND.
Siccome, come si diceva, in Italia abbiamo tanti fabbricanti di farmaci generici, lo stato (o eventualmente anche le regioni, da cui dipende la sanità pubblica) potrebbe allora commissionare alle imprese nazionali che hanno le capacità tecnologiche e produttive la realizzazione dei vaccini covid, al fine di acquistarli e distribuirli alla popolazione, dichiarandosi al contempo disposto a corrispondere ai titolari dei relativi brevetti – in luogo dei fabbricanti – una royalty FRAND. Ovviamente far ciò significherebbe scavalcare l’UE nella gestione dei vaccini, però – se davvero, come in tanti dicono, siamo “in guerra” – lo stato di eccezione dovrebbe poter valere anche per derogare “verso l’alto” alle norme unioniste e non solo per derogare alle regole (anche costituzionali) che, verso il basso, tutelano le libertà fondamentali dei cittadini. E tutto questo a maggior ragione tenendo conto del fatto che la gestione dei contratti di fornitura dei vaccini tra UE e case farmaceutiche è stata, non solo poco trasparente, ma anche assai deludente.