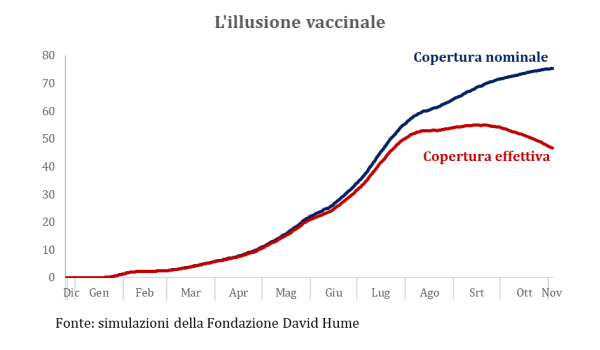Fa riflettere l’articolo di Marco Damilano, Clima sovrano, pubblicato da ‘L’Espresso’ il 31 ottobre u.s. Al di là della legittima polemica contro le destre, infatti, esso si richiama a una idea di democrazia liberale molto diversa da quella teorizzata e praticata dai paesi euroatlantici che sulla sovranità del demos hanno fondato le istituzioni della libertà. Cito il lungo incipit “Con un voto segreto, autorizzato dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle ore 13,30 di mercoledì 27 ottobre, l’aula del Senato ha affossato il disegno di legge sull’omofobia firmato dal deputato del Pd Alessandro Zan. La stessa aula che quattro anni fa al termine della precedente legislatura, con altri rapporti di forza tra i partiti, non era riuscita ad approvare la legge sullo ius culturae. In comune tra le due sconfitte c’è l’indifferenza verso le persone, con le loro storie, i loro drammi, i loro volti, il loro desiderio di vivere. La società va da una parte, il Parlamento dall’altra. I sovranisti scelgono i diritti come terreno di scontro, i democratici non riescono ad avere la forza politica delle loro buone ragioni, oltre che quella numerica. Si offrono nuove, ottime ragioni alla sfiducia, alla mancanza di credibilità, alla delegittimazione delle nostre istituzioni democratiche. La democrazia è più fragile quando i cittadini si sentono traditi dalle aule rappresentative. Ad avvantaggiarsi, è il fronte della negazione. Negano l’esistenza dei diritti delle persone Lgbtq+, degli immigrati, negano la pandemia e gli effetti del cambiamento climatico”. La retorica politica ha le sue regole (non esaltanti) e la squalifica morale dell’avversario è una di esse. Ci si chiede, però, fino a che punto la critica durissima di chi dissente da noi non si traduca in una delegittimazione degli avversari che segna la morte della democrazia come regime in cui partiti diversi si alternano al governo e all’opposizione. Per Damilano, un apprezzato giornalista che si è formato negli ambienti della sinistra cattolica, la bocciatura del ddl Zan attesta sic et simpliciter “l’indifferenza verso le persone, con le loro storie, i loro drammi, i loro volti, il loro desiderio di vivere”. Insomma, da una parte stanno i Valori, dall’altra biechi interessi, inconfessabili pregiudizi, cinismo etico. E quanti non negano affatto” l’esistenza dei diritti delle persone Lgbtq+, degli immigrati, la pandemia e gli effetti del cambiamento climatico” ma ad esempio sarebbero stati anche d’accordo con lo spirito della legge respinta dal Senato purché se ne fossero depennati gli articoli 1 e 7, non hanno alcun diritto di venir presi in considerazione. Anche se difendono (e ammettiamo pure con deboli ragioni) valori da tutti condivisi come la libertà di opinione e il diritto di richiamarsi a una teoria antropologica sui sessi diversa dalla filosofia Zan. In un magistrale articolo su ’Repubblica’, I diritti negati dall’ideologia’ del 29 u.s., Carlo Galli ha rilevato che “Il ddl apre anche la porta, sia pure in via indiretta, all’ideologia gender, la cui essenza è politica. Infatti, il nucleo più radicale delle sue formulazioni è che la civiltà occidentale è socialmente e culturalmente strutturata e istituzionalizzata in senso duale, binario, cioè intorno a due soli generi (maschile e femminile), che sono anche identità esistenziali e comportamentali. A tale struttura binaria si oppone il diritto di libera scelta individuale del genere (e in alcuni casi anche del sesso, e sempre della sessualità e dell’affettività): si afferma così una fluidità indefinita delle identità, che dovrebbe frammentare la struttura binaria vigente. Al di là del fatto che una parte del femminismo è ostile alle teorie gender perché, proiettate verso il superamento della logica binaria, rischiano di trascurare la presente disuguaglianza economica e sociale fra uomini e donne, alla (legittima) ideologia del ddl se ne è opposta un’altra – del centro-destra nella sua versione laica e moderata (distinta quindi dalle posizioni reazionarie e intolleranti, che sottotraccia sono pure rilevabili) -. Qui si considerano i problemi di genere come questioni individuali, come casi eccezionali rispetto alla normalità, e le persone coinvolte come soggetti da tutelare nei loro diritti, ma da non considerare come leva per mettere in discussione l’assetto della società. Sullo sfondo–discreta ma ferma, affidata alla Congregazione per la dottrina della fede – c’è poi la posizione ufficiale della Chiesa fondata sulla Bibbia (“maschio e femmina li creò”, dice la Genesi): l’essere umano naturale, nei due sessi e nei due generi, è immagine di Dio, e quindi portatore di una essenza e di una dignità immodificabili. A questa posizione la Chiesa ha richiamato i politici cattolici. Insomma, uno scontro ideologico, e non da poco”.
Ma se questo è vero, indipendentemente dalle convinzioni che ciascuno di noi nutre in cuor suo, un linguaggio come quello di Damilano non è la negazione stessa di quel liberalismo pluralistico, teorizzato da Isaiah Berlin, che vede valori, interessi e idealità da una parte e dall’altra e che, in caso di conflitti tra Weltanschuungen irriducibili, cerca la via del compromesso e della tutela di diritti sui quali si trovano tutti d’accordo? “Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde” (Matteo 12,30). In virtù di questa logica, discorsi equilibrati come quelli fatti da Luca Ricolfi o da Mattia Feltri (non certo esponenti di FdI) e da altri politici e studiosi moderati diventano qualcosa di equivoco, che porta acqua (involontariamente?) al mulino della reazione e dell’oscurantismo.
Se ci si chiede, però, cosa ci sia dietro l’intolleranza di Damilano, si scopre che “Though this be madness, yet there is method in it” e che la madness è un prodotto di una concezione della democrazia che viene da lontano, dal momento giacobino della Rivoluzione francese. Nell’articolo si legge che la democrazia “è lo strumento inventato per riequilibrare le disuguaglianze, per garantire le libertà, per consentire a tutti di partecipare alla costruzione del bene comune”. Ne deriva che quando questi obiettivi non vengono raggiunti il Transatlantico di Montecitorio, diventa “sempre più simile alla sua sinistra fama di corridoio dei passi perduti”: “fuori dal Parlamento c’è il popolo dei referendum e della democrazia diretta”. Bisogna pensare pertanto a una “mobilitazione della società” a una “battaglia politica e culturale. Tutto il resto è una scorciatoia che produce una reazione ancora più minaccio-sa”. Insomma non uno ma cento, mille cortei per esprimere l’indignazione del ‘paese reale’ contro il paese legale– il Parlamento–che ne ha tradito le aspettative, non volendo rendere la filosofia Zan pedagogia di Stato.
A leggere certe parole vengono i brividi e il pensiero corre all’aula “sorda e grigia” che ‘quello lì’ avrebbe potuto trasformare in un bivacco di manipoli o all’esaltazione che Giovanni Gentile faceva degli artefici dell’unità nazionale “che quando si trattò di agire e di farla, questa Italia, sdegnarono il chiacchierio fazioso delle assemblee”; ma corre anche alla intramontabile ideologia italiana che vede nelle forze vive della società civile, nei movimenti per i diritti, nelle rivendicazioni delle minoranze reiette la rousseauiana volontà generale contrapposta alla effimera ‘volontà di tutti’ che si esprime nelle urne. In base a questa filosofia politica, ci sono Valori e Diritti universali di cui le classi dirigenti debbono farsi carico ovvero tradurre in leggi e in istituti, sotto pena di perdere ogni diritto al governo della società. Va da sé che tali diritti e valori siano quelli dell’Illuminismo, depositario della Scienza e della Felicità dei popoli e che tutto ciò che ad essi si oppone va, tutt’al più tollerato, e qualora rispecchi il sentire della maggioranza va neutralizzato con una efficace politica di rieducazione collettiva, fatta anche di dimostrazioni di piazza, proteste, sit in (Una nota columnist, coerentemente, aveva proposto, nel caso di approvazione del ddl Zan, di non dare più sussidi statale alle scuole private gestite da religiosi che, contrari alla giornata contro l’omofobia, si fossero rifiutati di insegnare che i sessi non sono due come pretende la ‘Bibbia’!).
Sennonché, c’è un’altra visione della democrazia che non la vede come una freccia rossa che non deve mai arrestarsi giacché “chi si ferma è perduto” – come ripeteva uno degli alfieri della ‘democrazia sostanziale” nella sua versione “organizzata, centralizzata, autoritaria”, certo diversa da quella libertaria, dannunziana e sessantottesca ma come questa antiformalista e antiproceduralista. Ed è la visione che si potrebbe definire della ‘democrazia come registrazione’: registrazione dei desideri, delle aspettative, delle esigenze dei cittadini dettate da valori non necessariamente ‘progressisti’ ma egualmente rispettabili giacché sono quelli di cittadini, di persone, che su di essi hanno costruito la loro identità etico-sociale. E’ questo il ‘pluralismo preso sul serio’ e che non ha nulla a che vedere con la retorica pluralistica che apprezza solo la pluralità dei valori (ritenuti) buoni”. Per il primo, non c’è democrazia liberale senza un polo conservatore, che guarda al passato e vuole andare avanti preservandone, nella misura del possibile, le eredità e un polo innovatore che guarda all’avvenire e vuole sgomberare la strada, che da esso conduce, da tutte le catene lasciate dal ‘mondo di ieri’.
Per una parte rilevante dell’opinione pubblica, essere buoni democratici significa elaborare un progetto riformatore, battersi per una estensione indefinita dei diritti individuali e collettivi, in ogni campo. Nulla da eccepire purché si sia disposti poi a rispettare il verdetto della maggioranza degli elettori in disaccordo con gli innovatori. (Ovviamente non si parla qui di un governo reazionario deciso a violare le libertà politiche e civili giacché ci si troverebbe allora in una situazione rivoluzionaria dove solo il ricorso alla violenza potrebbe ristabilire le ‘regole del gioco’).
In non pochi ambienti accademici – e già nell’Ottocento – la democrazia procedurale evoca qualcosa di algido, la dittatura del numero, le regole che infiammano i cuori e illuminano le menti quanto un orario ferroviario o un manuale di istruzioni. E non meraviglia giacché, nel nostro paese, è difficile accettare l’idea che la fabbrica di valori sia nella società civile considerata in tutte le sue componenti; la fabbrica dei valori si trova, sì, nella società civile ma in quelle frange politicizzate che fanno da pendant alle masse amorfe, estranee ai grandi ideali della politica, zavorra a disposizione in ogni svolta autoritaria. Sono le minoranze consapevoli che fecero l’Italia nel Risorgimento, che invasero le piazze per chiedere l’intervento dell’Italia nella Grande Guerra, che parteciparono alla marcia su Roma e nel Sessantotto operarono una vera e propria ‘rivoluzione culturale’ (di cui risentiamo ancora gli effetti). Per questo stile di pensiero, della legittimità politica non è depositario il popolo sovrano, né il Parlamento ma le ‘avanguardie’ che mediano tra il primo e il secondo.
Eppure continuiamo a dirci tutti liberali e tra i liberali, che leggono i classici del pensiero politico, non se ne trova uno che non esprima la sua grande ammirazione per Alexis de Tocqueville Ma quanti poi hanno meditato davvero sulla Democrazia in America (1835) di cui riporto un brano inequivocabile? “I repubblicani negli Stati Uniti apprezzano i costumi, rispettano le credenze religiose, riconoscono ì diritti. Essi professano l’opinione che un popolo deve essere morale, religioso e moderato in proporzione alla sua libertà. Ciò che si chiama repubblica negli Stati Uniti è il regno tranquillo della maggioranza. La maggioranza, dopo che ha avuto il tempo di riconoscersi e di constatare la propria esistenza, diviene la fonte comune dei poteri. |…| Ma, in Europa, noi abbiamo fatto strane scoperte. La repubblica, secondo alcuni di noi, non è il governo della maggioranza, come si è creduto fino ad ora, è il governo di coloro che si fanno garanti e interpreti della maggioranza. ||sottolineatura mia || Non è il popolo che dirige in questa specie di governi, ma coloro che conoscono quale sia il vero bene del popolo felice distinzione che permette di agire in nome delle nazioni senza consultarle e di reclamare la loro riconoscenza calpestandole. Il governo repubblicano del resto è il solo, al quale si debba riconoscere il diritto di fare tutto, e che possa disprezzare ciò che gli uomini hanno fino ad ora rispettato, dalle più alte leggi della morale fino alle elementari re-gole del senso comune. Si era pensato, fino ad ora, che il dispotismo fosse odioso, qualunque fosse-ro le sue forme. Ma si è scoperto ai giorni nostri che vi. erano nel mondo tirannidi legittime e sante ingiustizie, purché fossero esercitate in nome del popolo “. E’ proprio il caso di parafrasare; de nobis fabula narratur!
Pubblicato su HuffPost del 1° novembre 2021