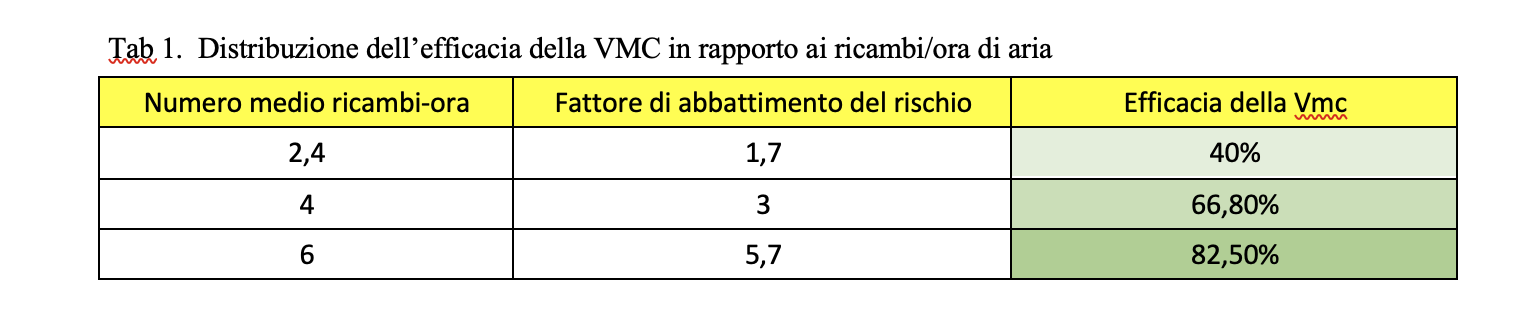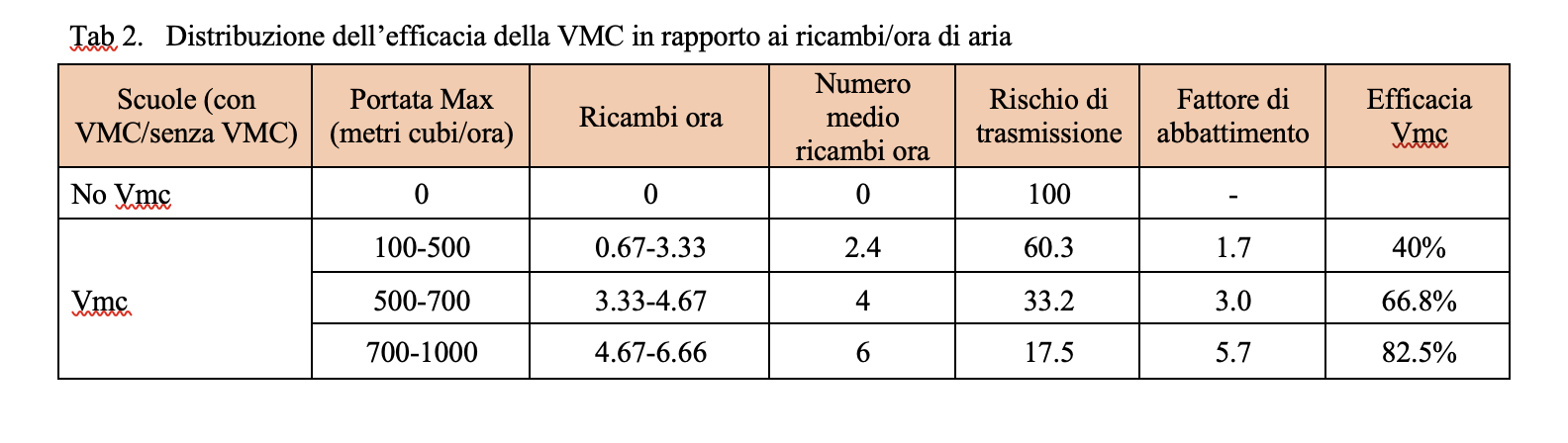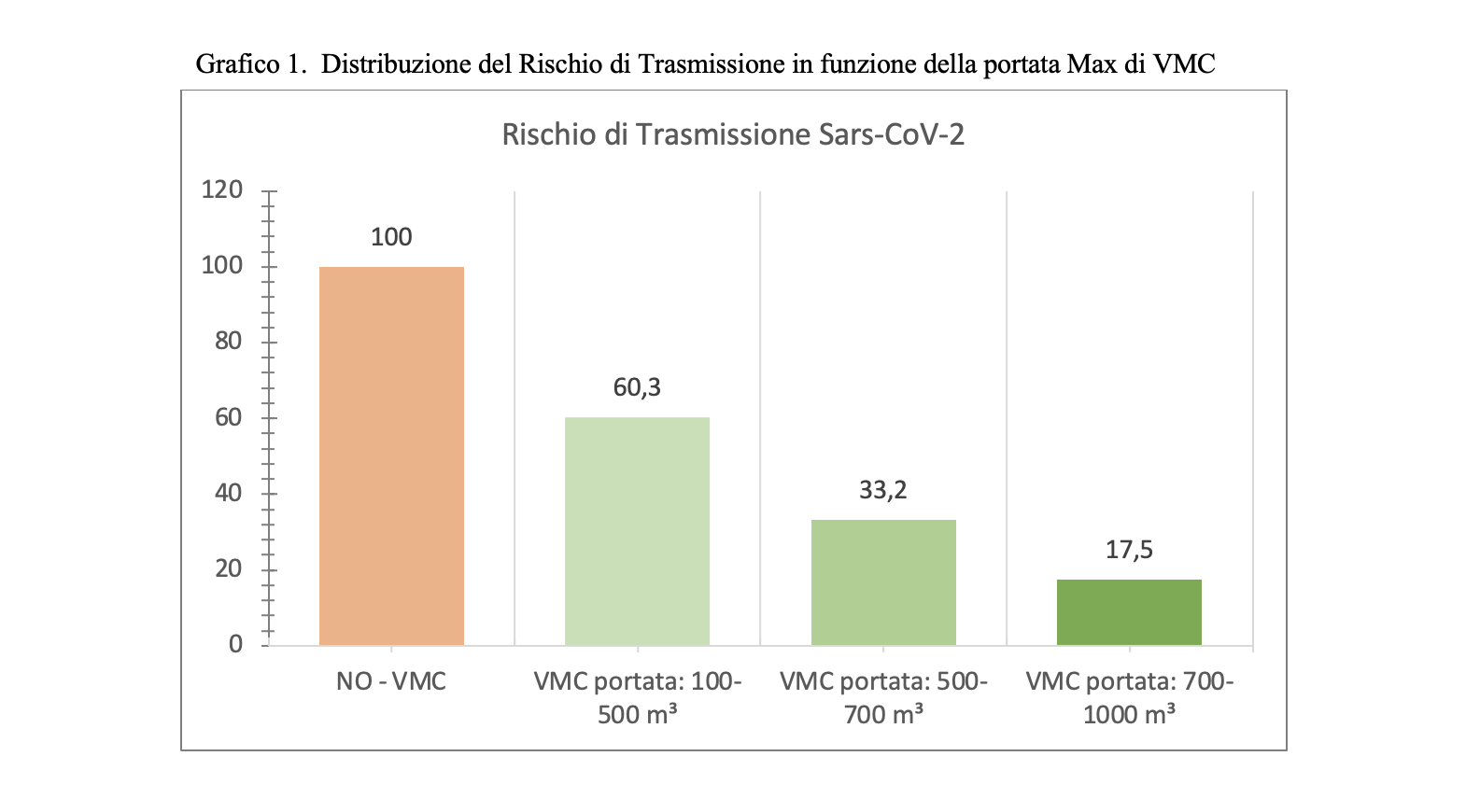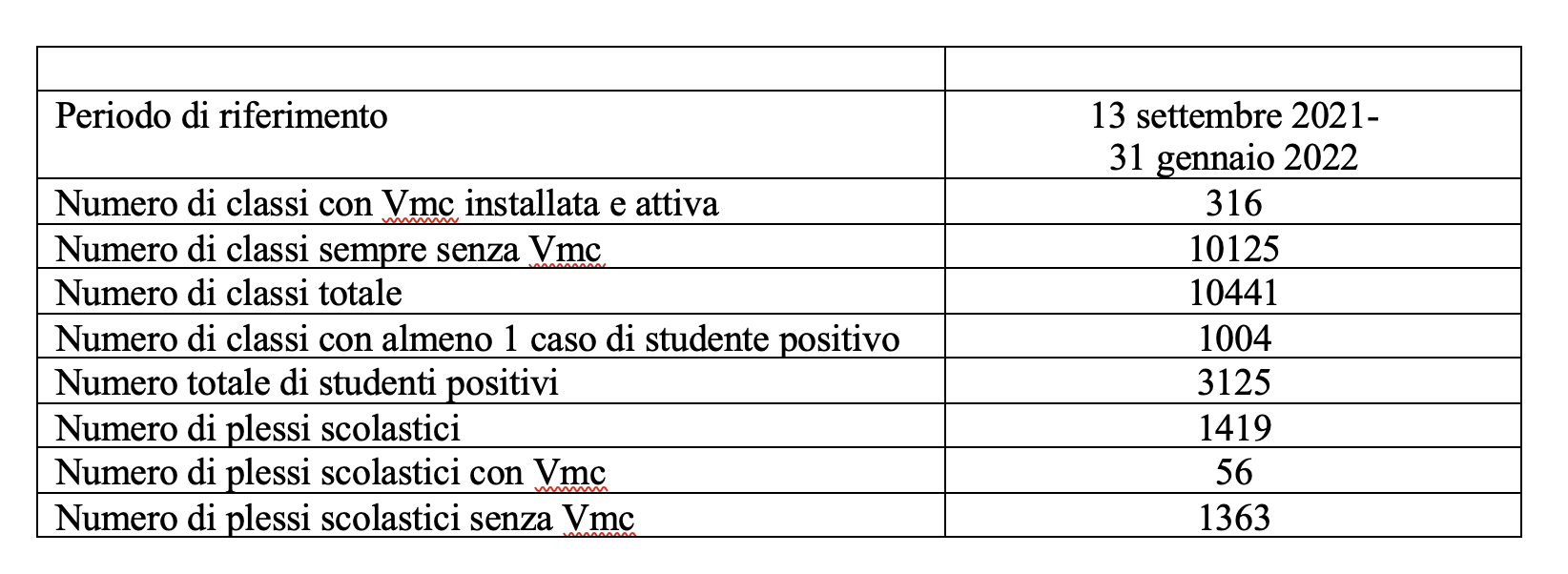Fino a qualche tempo fa, sui manuali di diritto privato utilizzati dagli studenti del primo anno di giurisprudenza si studiava che non ogni evento negativo che poteva capitare nella vita delle persone consisteva in un danno da considerarsi ingiusto nel senso di contrario al diritto (contra ius) ai sensi del fondamentale precetto di cui all’art. 2043 del codice civile.
C’erano – così almeno si studiava – i cd. danni leciti, ovvero le conseguenze sfavorevoli di un certo comportamento o di un evento della natura per cui l’ordinamento riteneva più opportuno non far conseguire alcun rimedio particolare: se la vista di cui godevo dalla finestra di casa mia viene pregiudicata dalla costruzione di un nuovo fabbricato nel rispetto della normativa edilizia e sulle distanze, non ho una pretesa da far valere (vorrà dire che semmai uscirò più spesso a fare una passeggiata per prendermi qualche raggio di sole).
Inoltre, sempre secondo il citato art. 2043 c.c., affinché ci sia un danno risarcibile è necessario che sia ravvisabile dolo o almeno colpa da parte di chi ha tenuto quella data condotta.
Le ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva sono infatti limitate e circoscritte nel nostro ordinamento giuridico, assolvendo fondamentalmente ad una funzione economica di ripartizione del rischio (si pensi ad esempio alle garanzie assicurative prestate rispetto a determinate attività d’impresa o, più semplicemente, in materia di circolazione stradale).
Da qualche tempo, tuttavia, il quadro appare mutato ed in continua evoluzione.
Ed infatti, da un lato si assiste alla individuazione – per via giurisprudenziale ma anche da parte del legislatore – di sempre nuove figure di danno risarcibile, anche al di là della originaria limitazione espressa dall’art. 2058 c.c. per i danni cd. non patrimoniali (si pensi, tra i tanti, al danno da cd. “vacanza rovinata”).
Dall’altro, nell’opinione comune si è fatta strada la convinzione che di qualunque evento dannoso debba essere comunque individuato un responsabile, anche quando non è ravvisabile un giudizio di riprovevolezza in termini di colpa, per effetto di presunzioni che fatalmente ne prescindono (si pensi alle fattispecie di colpa medica, che di fatto tende ad essere riconosciuta ogniqualvolta non si ottenga il risultato sperato da una terapia o da un intervento chirurgico, anche non di routine).
Ciò che pare essere diventato intollerabile è che la vita delle persone possa essere più o meno pesantemente condizionata dal caso o dalla sfortuna, nella consolatoria ma fallace pretesa che sia sempre colpa di qualcuno.
È con tutta evidenza una questione che attiene, prima che ancora che al diritto, alla weltanschauung, alla concezione che abbiamo del mondo e della vita (per citare Brodskij, “un uomo libero, quando è sconfitto, non dà la colpa a nessuno”).
In termini di civiltà giuridica, può forse essere opportuno tenere presente che attribuire responsabilità a soggetti a cui in realtà non dovrebbero essere imputate significa aggiungere ingiustizia ed arbitrio, con l’ulteriore grave conseguenza di deresponsabilizzare per il futuro i comportamenti anziché provare – nei limiti del possibile – a migliorarli.
Se dal diritto dei privati ci spostiamo alla sfera dei rapporti con l’Autorità e/o il potere pubblico, a quello che negli ordinamenti continentali è comunemente indicato come diritto amministrativo, le cose assumono contorni ancora più netti, la tendenza in atto è ancora più marcata.
Di fatto, negli ultimi decenni (quantomeno a partire dagli anni ’70) si assiste al tentativo – non so quanto consapevole – di neutralizzare il più possibile ogni sorta di rischio incombente in capo ai soggetti privati.
Si va dalla pletora di indennizzi e ristori riconosciuti (anche giustamente, per carità, in periodi di pandemia) a favore di categorie di operatori economici e/o semplici privati svantaggiati (dagli effetti dell’epidemia da coronavirus ma ancor prima, ad esempio, dal mancato rinnovo delle concessioni demaniali dei balneari, da fenomeni meteorologici anche se imprevisti ed imprevedibili – alluvioni, frane, ecc. -); alle richieste di pagamento del subappaltatore avanzate direttamente nei confronti dell’Amministrazione appaltante, in deroga ai generali principi in materia di libertà e responsabilità contrattuale; alla miriade di bonus e superbonus fiscali degli ultimi tempi.
Si tratta di situazioni anche eterogenee tra loro per cui tuttavia si registra un’invincibile pressione a che lo Stato e/o la politica se ne faccia carico.
Malauguratamente, è un punto di vista che, da una parte, fatalmente tende a porre a carico della collettività e della fiscalità generale situazioni personali, da un punto di vista economico (ma, come dovrebbe essere noto, nessun pasto è gratis); e che dall’altro porta via via a comprimere e a far scemare il concetto stesso di responsabilità individuale.
Ma dove, se possibile, il corto circuito di cui si è detto diventa ancora più evidente, è l’ambito della responsabilità penale, soprattutto quello dei reati contro la P.A. o dove sono comunque coinvolti amministratori pubblici o pubblici funzionari.
Non c’è fenomeno naturale, alluvione, frana, od anche semplice smottamento, in cui non sia ravvisabile – in aggiunta a quella patrimoniale dell’Ente pubblico (che, beninteso, potrà anche avere delle effettive responsabilità rispetto ad eventuali negligenze ed incurie) – una penale e personale responsabilità, potremmo dire di posizione, del Sindaco o del dirigente a capo del settore (che rispondono anche se il bambino a scuola lascia il dito schiacciato nella porta d’ingresso; o, in materia ambientale, se il registro di carico della discarica comunale presenta delle mere irregolarità formali; ecc.).
Non ci deve poi stupire troppo se capita “di notare una leggera flessione del senso sociale” (Max Gazzè) o, più prosaicamente, la qualità della nostra classe politica è crollata verticalmente, essendo disponibile a ricoprire determinati incarichi pubblici solo chi non è particolarmente qualificato professionalmente o tiene effettivamente comportamenti delinquenziali.