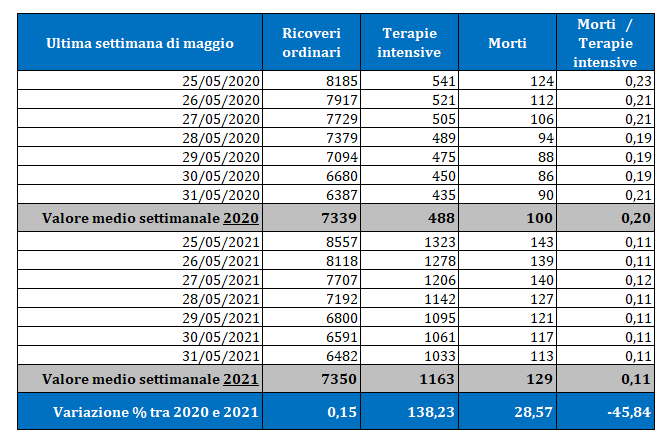Negli ultimi tempi nel nostro Paese è avvertita, da molti se non da tutti, la necessità di procedere alla riforma – tra le altre – della giustizia. Ed in effetti, le ultime vicissitudini del Csm, la per lo più generalizzata constatazione dell’enorme potere esercitato dalle Procure, il perdurante circuito mediatico-giudiziario, a cui fa da contraltare l’intollerabile lungaggine dei processi civili e la frequente invasione di campo dei TAR, deporrebbero a favore dell’improcrastinabilità della riforma.
Dopo di che, in quale direzione si debba effettivamente andare, al di là di generiche prese di posizione riguardo alla necessità di moralizzare e rendere più efficiente il sistema, oltre all’immancabile litania sulla digitalizzazione, non è dato sapere.
Sospetto che la questione sia purtroppo ancora un po’ più complicata di come viene generalmente posta. Ritengo – ma pare che si tratti di un’opinione non troppo condivisa – che il problema investa la stessa natura del potere giudiziario e la tradizionale teoria della divisione dei poteri: se si parte dalla premessa che il potere giudiziario – seppur privo di ogni forma di investitura e legittimazione popolare – è potere del tutto autonomo, in particolare da quello politico e legislativo, è evidente come per giustificare le decisioni assunte dal Csm quale organo di autogoverno dei giudici bisogna appellarsi a criteri vaghi orientati al moralismo. Analogo discorso vale per le decisioni prese dai giudici nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali: a chi rispondono?
Ma forse c’è ancora di più. Dalle nostre parti, vale per la cultura giuridica accademica ma anche per il sentire comune, per l’opinione dell’uomo della strada, per governare una collettività è condizione essenziale – si pensa – produrre regole, che saranno evidentemente nuove, emanare leggi, legiferare.
E’ quello che gli addetti ai lavori chiamano giuspositivismo, che è un tratto comune della storia giuridica dell’Europa continentale e che risale al processo di codificazione degli stati nazionali ed ha poi trovato nuovo impulso nei principi della rivoluzione francese: il diritto è il prodotto dell’attività legislativa, la legge e i codici. Nulla preesiste, di giuridicamente vincolante, alla produzione legislativa, che interviene a disporre quello che è giusto o sbagliato facendo tabula rasa dell’assetto precedente, ipotizzando e presumendo di poter di volta in volta illuministicamente plasmare una società nuova e migliore. Chi la pensa diversamente è un ingenuo, che ancora non ha capito la differenza tra il diritto, che solo ha validità ed efficacia vincolante erga omnes, e le convinzioni morali e personali di ciascuno.
Ma è realistico pensare che per governare una comunità, con la sua storia, le sue tradizioni, il suo senso di appartenenza, si possa ogni volta tirare una riga su comportamenti ritenuti leciti fino ad un istante prima, modificare repentinamente e bruscamente convinzioni ed abitudini, disattendere affidamenti?
Forse non è necessariamente così. Le persone sanno in genere cosa è giusto e cosa è sbagliato, quello che si deve o non si deve fare: nelle famiglie non ci sono disposizioni scritte per regolare i comportamenti dei propri membri (se mia figlia non vuole fare i compiti probabilmente devo evitare di fornirle un accurato decalogo con l’indicazione delle punizioni conseguenti); nei posti di lavoro, se il clima è buono e produttivo non c’è bisogno di regole di condotta dettagliate; sull’autobus, la buona educazione è forse più importante delle minuziose condizioni generali del contratto di trasporto; la pedante normativa anticorruzione – che sostanzialmente si risolve nella richiesta agli interessati di una sorta di autocertificazione di virtuosità – garantisce effettivamente dai comportamenti illeciti?
Probabilmente è allora arrivato il momento di provare a fare qualche riflessione più generale. Storicamente, la stessa nozione di diritto per come la intendiamo noi oggi è un’invenzione degli antichi romani. Ebbene, per i romani, le norme che disciplinano una comunità, una città, non vengono create dal legislatore, ma preesistono e vengono in qualche modo rinvenute dai giudici così come un linguista codifica le regole grammaticali dall’effettivo uso che ne fa chi parla e scrive una certa lingua. Le collettività, per funzionare, hanno bisogno di comportamenti reiterati e regole potremmo dire immanenti, che si creano e perfezionano nel tempo in una sorta di moto browniano di tutti i soggetti che fanno parte di quella comunità (che ricomprende gli antenati, i presenti e quelli ancora non nati), sulla base di senso di appartenenza, convinzioni religiose e morali, aspettative di reciprocità, timori di riprovazione sociale.
Non è forse un caso che, a distanza di tempo, la modernità, per come la conosciamo oggi, abbia la forma degli ordinamenti anglosassoni.
Anche da quelle parti il diritto, le regole, ciò che è giusto o sbagliato, è per buona parte consuetudinario e prescinde dalla contingenza dell’attività legislativa. Così come per i prati all’inglese – per cui serve prendere un terreno, dissodarlo ed irrigarlo per qualche centinaio d’anni -, allo stesso modo la convivenza sociale si basa su principi secolari, sul rispetto delle libertà individuali fondamentali e dei principi di correttezza e buona fede nei contratti e negli affari – la fairness – che spesso prescinde dalla formalizzazione scritta, realizzandosi invece una lenta e costante opera di rinvenimento e sistematizzazione da parte dei giudici in ossequio al fondamentale rispetto del precedente.
Ecco, il rispetto del precedente. E’ un principio generale dei sistemi di common law, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una fattispecie precedente, nel caso in cui la vicenda portata al suo esame sia identica o simile a quella già trattata.
In fondo, non è un meccanismo troppo dissimile da quello – a cui si accennava sopra – utilizzato dal linguista: sul dizionario Devoto – Oli una certa definizione di un dato termine viene censita quando ne viene registrato un uso costante da parte degli utilizzatori; analogamente, le regole grammaticali altro non fanno che recepire gli usi (una certa costruzione sintattica è corretta perché consolidata nel parlare comune). Ebbene, esattamente allo stesso modo nei repertori giurisprudenziali vengono catalogate le pronunce dei giudici che di fatto recepiscono le valutazioni – in termini di liceità o meno – su determinati comportamenti (se una data condotta è giusta, se una certa violazione determina un obbligo di risarcimento, ecc.), ed a cui quindi riferirsi per le definizioni di liti future.
Nella mia esperienza di giurista pratico, capita regolarmente che il cliente chieda se un dato comportamento è lecito e/o consentito o meno, se una certa cosa si può o meno fare. E’ in definitiva la – fondamentale – domanda che le persone si pongono. Solo che, a differenza che altrove, nel nostro ordinamento per lo più non si riesce a rispondere, se non illustrando una serie infinita di distinguo (a Genova per il Tribunale questa cosa si può fare, ma la Corte d’Appello è di diverso avviso, il dato Giudice ha una posizione particolare, bisogna poi vedere cosa dice la Cassazione, però c’è un orientamento minoritario che …, ecc.): è insomma il regno del latinoroum dell’azzeccagarbugli.
Vige in particolare nel nostro ordinamento l’idea (che ha un fondamento costituzionale: il giudice è soggetto soltanto alla legge in base all’art. 101 Cost.) che la soluzione della controversia e la conseguente pronuncia giurisdizionale – la cui fondamentale qualità dovrebbe consistere nella sua prevedibilità (oltre che celerità), per garantire giustizia sostanziale ed efficienza del sistema – debba invece essere originale, riconoscere sempre nuovi (asseriti) diritti e percorrere strade ancora non battute.
Dalle nostre parti il precedente giurisprudenziale è uno solo tra i tanti argomenti che vengono utilizzati (lo spirito della legge, la volontà del legislatore, l’argomento sistematico, quello teleologico, ecc.) e – in ogni caso – il rispetto di tale principio non è assolutamente ritenuto vincolante: ogni giudice è libero di interpretare il dato normativo e di risolvere la controversia a lui assegnata come ritiene più opportuno, con una decisione di fatto scarsamente verificabile.
Insomma, tirando le fila del ragionamento, nell’Europa continentale, ed in particolare nel nostro Paese, assistiamo a due fenomeni che si sovrappongono e concorrono nel determinare una complessiva arbitrarietà e frammentarietà del sistema giudiziario: da una parte il potere giudiziario è considerato potere costituzionale autonomo, seppur privo di ogni forma di investitura e legittimazione popolare, e non si capisce bene a chi debba rispondere; dall’altro, anche in ragione dell’idea giuspositivistica per cui il diritto è il prodotto dell’attività legislativa, la legge e i codici, e nulla preesiste, di giuridicamente vincolante, alla produzione legislativa (sovrabbondante e spesso schizofrenica), ogni singolo giudice è soggetto soltanto alla legge e non è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una fattispecie precedente (in definitiva, alle convinzioni e alle abitudini della comunità), nel caso in cui la vicenda portata al suo esame sia identica o simile a quella già trattata.
Siamo sicuri che, con queste premesse, i problemi della giustizia in Italia si risolvano con la sempre auspicata digitalizzazione?
Sarebbe invece opportuno fare qualche riflessione di carattere più generale e si potrebbe ad esempio iniziare dal considerare il rispetto vincolante del precedente giurisprudenziale non più come un taboo.