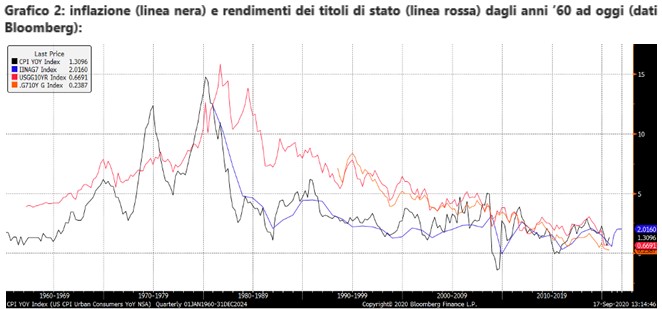Il ritorno della talpa: il diritto di ricevere risposte
Essendo di nuovo rinchiusa, passo molto tempo davanti alla tivù. Voglio sapere, essere informata, ascoltare opinioni. La sera, al buio della mia galleria, mi metto in poltrona e guardo: telegiornali, inchieste speciali, talkshow. Giro per canali e ne pesco uno qua uno là, non importa dove sia e chi parli. Sono avida di gente che parla. Mi aspetto ogni volta che qualcuno m’illumini, che mi dica la verità. Sono affetta da masochismo e vacue speranze, destinata quindi a perenni delusioni e frustrazioni, lo so.
Ma c’è una cosa che sommamente m’indigna: che nessun politico mai risponda alla domanda!
Ho analizzato molto la questione, è da non credere. Il giornalista chiede una cosa specifica (ad esempio: “Perché non avete fatto più tamponi quando i contagi erano bassi ed era utile farli per contenere l’epidemia?”) e il politico, senza la minima difficoltà o vergogna, parla d’altro. Riempie il vuoto con parole non importa quali e, cosa ancor peggiore, secondo uno schema retorico fisso e orribilmente ripetitivo:
1) Intanto mi lasci dire che…
2) Abbiamo passato l’estate a lavorare…
3) Anche gli altri Paesi però…
4) Stiamo facendo molti sforzi per…
Scusate, ma fare sforzi assicura di per sé dei risultati? Non so, sarà che nella vita precedente ho fatto l’insegnante, ma mi viene in mente il solito allievo impreparato, che fa scena muta all’interrogazione e quando l’insegnante gli dà 4 dice: Ma io ho studiato!
La cosa grave è che l’intervistatore tace, non reagisce, non incalza il politico, non gli fa notare che non ha risposto e non pretende che risponda. Nulla. Silenzio. Si passa ad altro. Ad altre domande che innescheranno altre non-risposte. Mistero! Perché il giornalista tollera che il politico non risponda? Qual è il suo lavoro? Per chi lavora?
Nel mondo delle talpe è tutto molto più nitido. Forse siamo delle sempliciotte, ma quel che pensiamo è questo: se ti faccio una domanda, tu per piacere rispondi a quella domanda, non è che te ne puoi partire in tutt’altro discorso. Oppure se non vuoi rispondere lo dici, dici: Mi dispiace, mi scusi, a questo non rispondo, passiamo a un’altra domanda. Onestà. E chiarezza. Non trovate che ci vorrebbero?
Lo dico in un altro modo, con un esempio. Ci troviamo sulla panchina, io e la talpa Cristina mia vicina di casa, chiacchieriamo prendendo un po’ d’aria e godendoci la campagna, e a un certo punto io le chiedo:
Senti, Cristina, tuo figlio ha poi trovato lavoro?
E Cristina mi risponde:
Ma guarda, le patate al forno le puoi fare in vari modi, io le faccio col rosmarino.
Vi par possibile? No, che non vi par possibile. Eppure è quel che succede ogni giorno, più volte al giorno, in ogni rete tivù, a ogni programma, con qualsiasi conduttrice o conduttore, con qualsiasi politico, ministro, sottosegretario o tirapiedi: l’uno pone una domanda precisa e l’altro risponde a tutt’altro. Cioè, non risponde.
E qui, di nuovo, il mio vecchio mestiere mi sovviene: se io durante un’interrogazione chiedevo cos’ha scritto Petrarca, e l’allievo mi rispondeva che Cagliari è una ridente città della Sardegna, io non solo lo mandavo a posto con 2, ma chiamavo anche l’ambulanza, molto preoccupata per la sua salute mentale.
Ora, perché non diamo 2 ai politici? Perché non chiamiamo l’ambulanza?
Perché tolleriamo che non rispondano?
Mi piacerebbe che la smettessimo di tollerare. Che non gliela lasciassimo passar liscia. Mi piacerebbe che, se tu politico non rispondi, io giornalista lo rimarcassi con grande energia: Non hai risposto, Non hai risposto, Non hai risposto! Un po’ à la Sgarbi (può non piacere, ma funziona): Capra! Capra! Capra! E se continui a non rispondere, io chiudo il collegamento dicendo che tu, politico tal dei tali, non hai risposto alle domande. Sancisco la tua non-risposta, ti inchiodo a quel che sei.
Mi piacerebbe che i politici avessero paura di andare in tivù, non che ci andassero allegramente ogni giorno come a un picnic tra amici. Non so se l’avete notato, ma non esiste, qui in Italia, alcun programma tivù in cui i politici temano di andare: non è la prova che il conduttore non sta facendo il suo dovere?
Credo che abbiamo, noi cittadini, il diritto di ricevere risposte. Oggi più che mai, visto il disastro in cui siamo precipitati, credo sia un diritto sacrosanto.
Ebbene, questo diritto io lo vedo continuamente violato, calpestato.
Non capisco perché permettiamo questo, non capisco perché si facciano tante interviste e tanti talkshow se poi si accetta di non avere risposte e si sopportano queste continue elusioni e fughe. È, anche, un’offesa all’intelligenza dei telespettatori, cioè di noi cittadini. Va bene, l’epidemia ci ha resi confusi e inermi, tristi e a tratti disperati. Ma non ci ha ancora instupiditi.
Non capisco che gioco perverso sia, a chi giovi, e chi abbia paura di chi.
Dobbiamo smettere di giocare. E anche di aver paura. Siamo gente libera o no?
Okay, sono risbucata dalla galleria. Siamo di nuovo rinchiusi, quindi le talpe ritornano, e a tratti risbucano.
Non è come l’altra volta, però: adesso dipende da dove abiti. In certi posti sei chiuso, in altri meno, in altri ancora quasi per niente. Questo rende tutto meno semplice, e anche meno chiaro. A marzo c’era una chiarezza adamantina che ci rendeva un pochino più sereni: eravamo tutti chiusi uguale. Ora ce lo chiediamo ogni giorno, se e quanto siamo chiusi, o aperti ma poco, o semichiusi, o chiusi con vista mare, o aperti senza via d’uscita…
Comunque siamo tornati talpe, chi più chi meno. E adesso abbiamo capito che forse la talpitudine non ci abbandonerà mai del tutto, d’ora in poi: sarà uno stato intermittente. Come le lucine di Natale. Avremo una pelliccia marroniccia da indossare in certi periodi, e in certi altri rimettere nell’armadio, con le tasche piene di naftalina. Il mondo è cambiato. Prima, nell’armadio, avevamo solo cappottini di lana o morbidi piumini di penne d’anatra. Ora quella pellicciotta da talpa esiste, e ci squadra con aria minacciosa: Ricordati che sei talpa, e (ogni tanto) talpa ritornerai.
Ogni tanto però usciamo a parlarci, tra talpe. Almeno questo. Parliamoci! Le parole non mi sono mai parse così teneramente inutili… Mi fa tenerezza, la loro abbagliante inutilità. Ma sono convinta che ora meno che mai si debba tacere. Inutili di tutto il mondo, unitevi e parlatevi!
La parola è quel che ci resta, l’unica libertà che nessuno ci può togliere. Meglio se scritta. Scripta manent ancora, tutto sommato: i libri per esempio resisteranno sempre e oggi più che mai devono far sentire la loro voce.
Usiamola dunque, questa parola! Con lealtà, e parsimonia… Ad esempio per esigere risposte.
Pubblicato su La Stampa del 15 novembre 2020