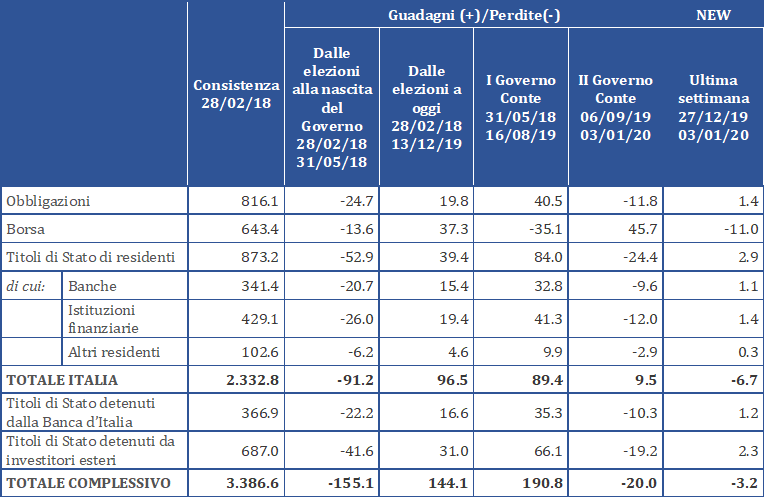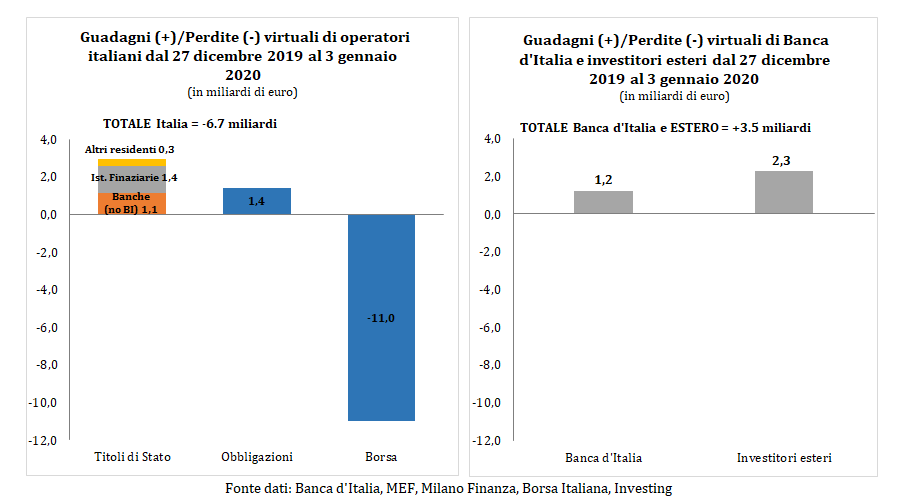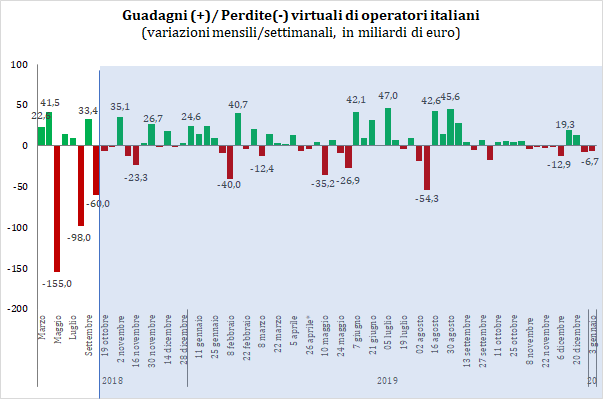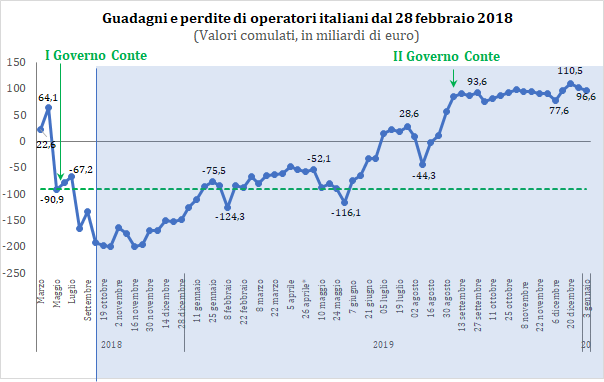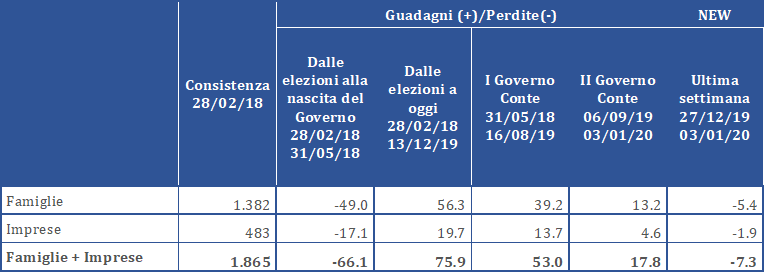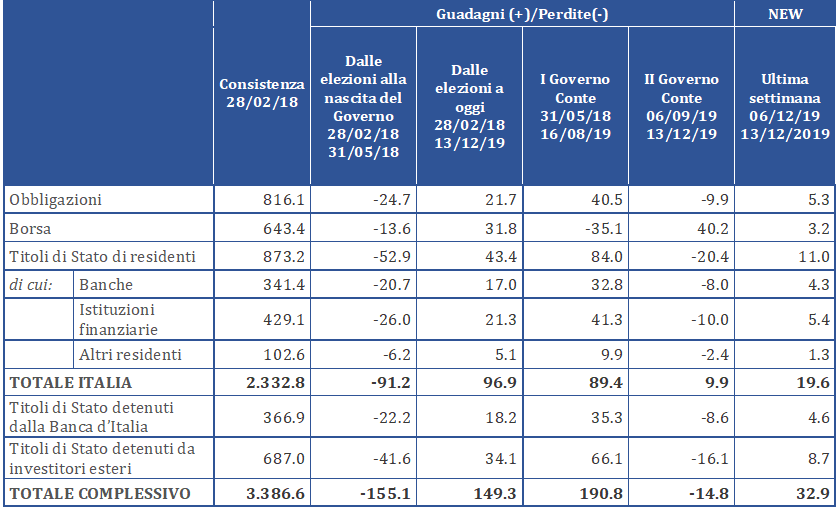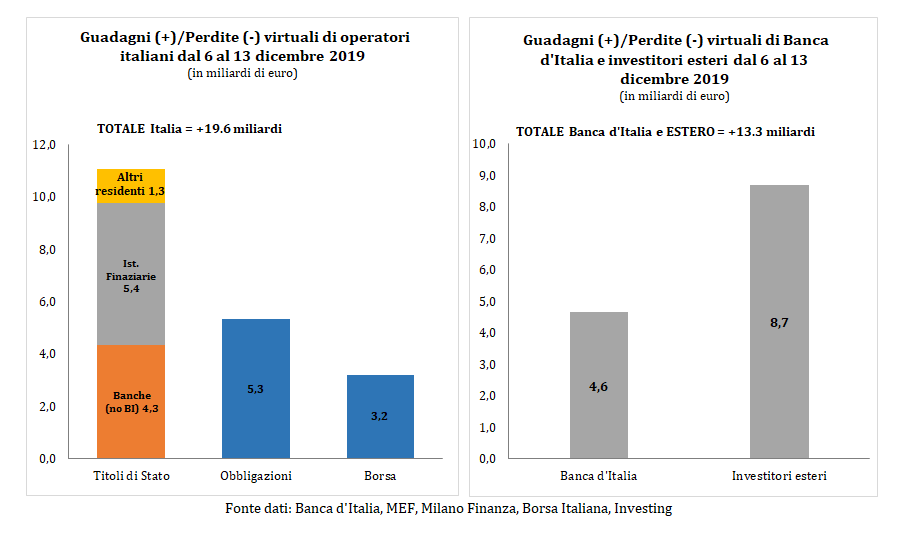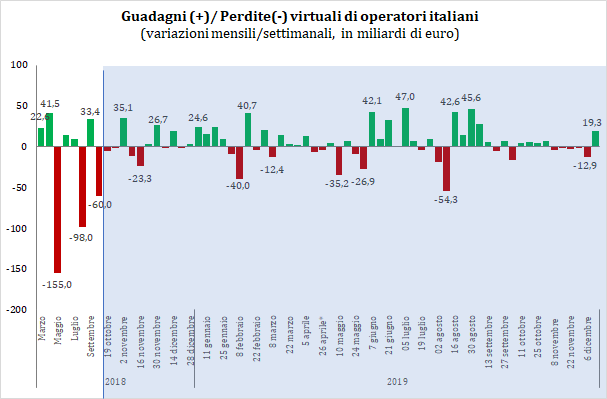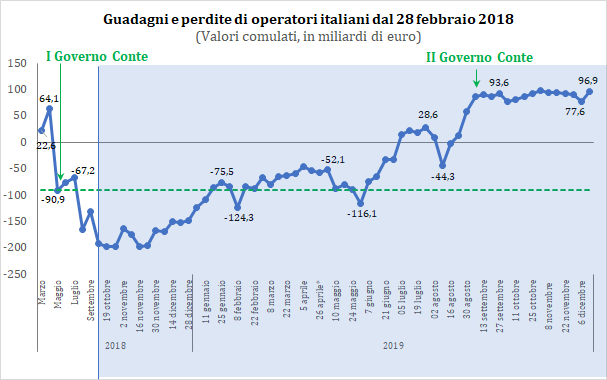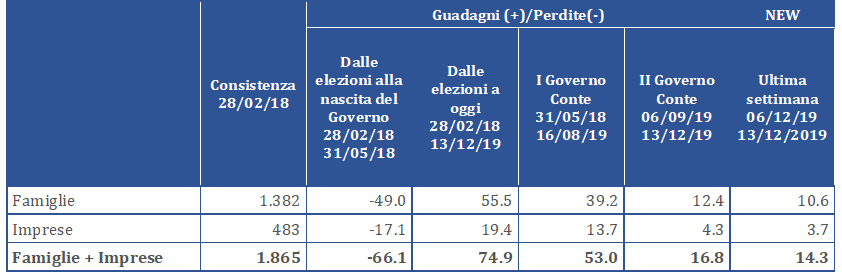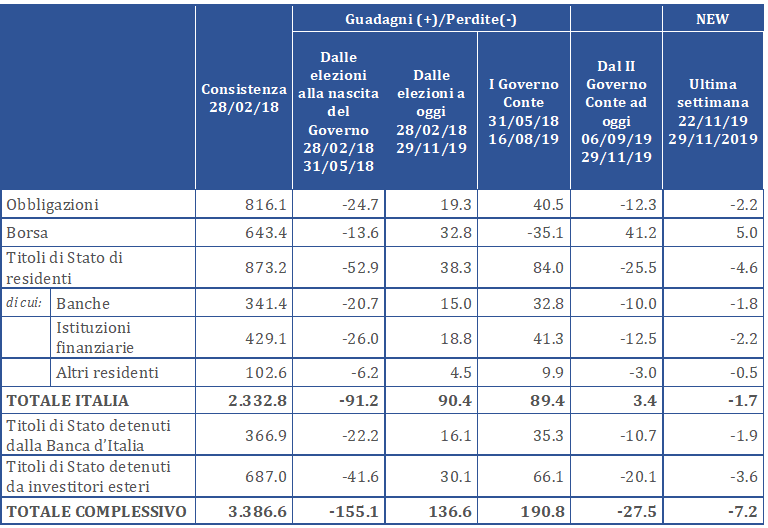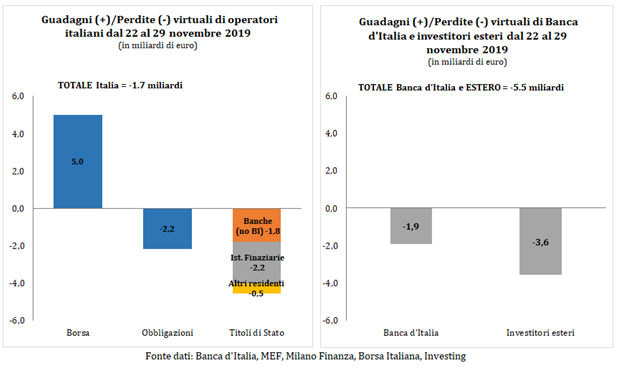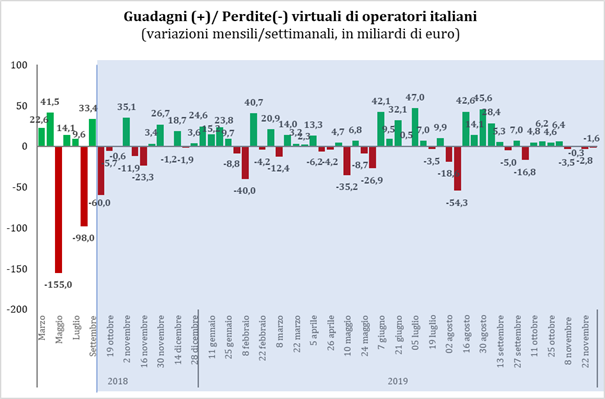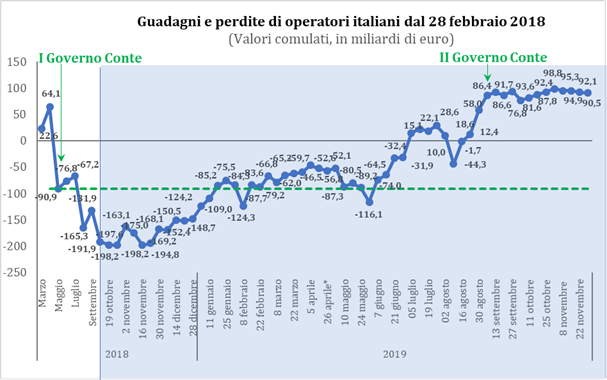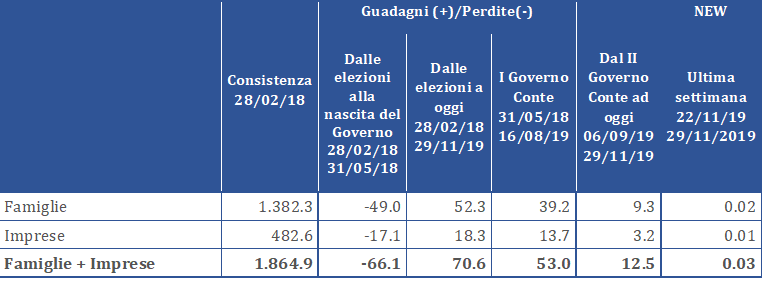L’eredità del debito nell’economia post Covid
Il mondo travolto dalla pandemia ha un evidente problema di debito. Lo segnalano i dati diffusi dal Fondo Monetario Internazionale che già ad aprile aveva ipotizzato una risalita del peso delle pendenze pubbliche sul Pil pari a circa 13 punti percentuali fino a quota 96%. La successiva revisione al rialzo delle stime prefigura oggi il superamento di quota 100%, un record storico. Il fenomeno non sorprende. La recessione da Covid-19 dovrebbe costare al Pianeta quasi 5 punti di Pil per l’anno in corso e la crisi economica imporrà un aumento della spesa pubblica da finanziare con nuove emissioni. Una combinazione di fattori che produce un allargamento della forbice tra ricchezza prodotta e indebitamento complessivo. Il ricorso a misure d’emergenza nel contesto attuale, ha notato Gavyn Davies, presidente di Fulcrum Asset Management, sulle colonne del Financial Times, sembra trovare un consenso quasi unanime tra gli economisti. L’ipotesi è intuitiva: l’epidemia lascerà in eredità un’imprevista quota di debito da gestire.
Tra le numerose questioni aperte tre temi, in particolare, potrebbero caratterizzare il dibattito nei mesi e negli anni a venire: la sostenibilità in termini fiscali; l’autonomia delle banche centrali; i rischi affrontati dai mercati emergenti e in via di sviluppo. Sono problematiche essenziali destinate a intrecciarsi con l’eredità delle politiche monetarie dell’ultimo decennio. Ma sono soprattutto questioni irrisolte nel contesto di una crisi del tutto peculiare.
Un crisi completamente diversa
Undici anni fa la Grande Recessione post Lehman si sviluppò come conseguenza di una drastica riduzione del credito disponibile. All’epoca, come noto, le banche centrali risposero avviando una politica monetaria espansiva senza precedenti basata sul riacquisto di prodotti finanziari di qualità variabile (dai titoli di Stato alle asset-backed securities) garantendo così un abnorme e costante apporto di liquidità al sistema. I programmi di sostegno al comparto bancario hanno fatto il resto. Da allora la ricetta monetaria espansiva si è diffusa più o meno ovunque producendo essenzialmente due conseguenze strettamente correlate: una disponibilità senza precedenti di credito a basso costo e un rally borsistico ultradecennale.
La crisi del Grande Lockdown ha stimolato inevitabilmente un’ulteriore accelerazione delle iniziative di alleggerimento monetario. Non è un caso che dopo un’iniziale e tutt’altro che trascurabile correzione ribassista gli indici di borsa abbiano ripreso a correre trascinando al rialzo quasi tutte le asset class finanziarie presenti sul mercato (dalle azioni alle obbligazioni passando per l’oro). Ma la contrazione economica legata alla pandemia, come detto, ha origini completamente diverse. Si tratta, semplificando, di una crisi da “economia reale” manifestatasi in primis sul fronte dell’offerta – l’esplosione dell’epidemia in Cina ha impattato direttamente sulla catena di fornitura globale – e in seguito su quello della domanda. La lunga fase della quarantena ha depresso i consumi e alcuni settori – dall’automotive al turismo senza dimenticare il comparto petrolifero – sono entrati in un tunnel senza luce generando nei Paesi più esposti contrazioni economiche a doppia cifra percentuale. È in questo contesto che la spesa per il welfare e le politiche di sostegno a imprese e consumatori sono entrate in una fase espansiva alimentando la necessità di un crescente indebitamento.
In linea teorica una futura ripresa economica accompagnata da bassi tassi d’interesse potrebbe favorire una contrazione della forbice debito/Pil. Ma questa dinamica dovrà essere sorretta, per così dire, da un’opportuna strategia fiscale. Molti Paesi, ha osservato ancora il Fondo Monetario Internazionale, saranno chiamati a intraprendere «solide politiche di risanamento di bilancio nel medio periodo» attraverso le classiche strategie suggerite dalla teoria e dalla logica: «taglio della spesa superflua, allargamento della base imponibile, introduzione di una maggiore progressività fiscale e minimizzazione dell’elusione». Un percorso possibile?
Gli ostacoli fiscali
Forse. Ma non mancano gli ostacoli. Il primo grande problema, ad esempio, è dato proprio dalle palesi difficoltà rappresentate dalla stessa fiscal consolidation – il risanamento di bilancio, appunto – che, come noto, non potrà essere uguale per tutti. Paesi caratterizzati da un’onda lunga di crescita modesta, alti livelli di spesa e forte indebitamento – l’Italia, ovviamente, ma un discorso simile vale anche per il Giappone – rischiano di pagare quegli effetti negativi sulla crescita che sono tipicamente associati alle strategie di ristrutturazione dei conti pubblici. Anche per questo, forse, il dibattito su nuove forme di tassazione che escludano i contribuenti tradizionali attira oggi un significativo interesse. In una ricerca pubblicata all’inizio di luglio, il think tank Bruegel (Brussels European and Global Economic Laboratory) ha proposto di intervenire sul sistema di scambio di quote di emissione (ETS) e sull’Energy Taxation Directive (ETD) dell’Unione Europea raddoppiando il carbon price (che si aggira oggi attorno ai 25 euro per tonnellata di CO2). L’operazione, sostengono i ricercatori, potrebbe generare introiti per 90 miliardi, oltre la metà del fabbisogno fiscale destinato alle politiche di risanamento di bilancio (pari a oltre l’1% del Pil, più o meno 140 miliardi di euro).
Ipotesi interessante, non c’è dubbio. Ma il rischio è che la palude delle trattative che caratterizza abitualmente le iniziative di riforma in sede europea possa produrre schemi di tassazione eccessivamente annacquati e per questo scarsamente efficaci (tradotto: capaci di generare gettiti assai più modesti rispetto alle attese). I precedenti non mancano. L’ultima bozza normativa relativa all’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie all’interno dei dieci Paesi della cooperazione rafforzata UE (tra cui l’Italia) si ispira all’esperienza francese, basata sull’applicazione di un’imposta nel trading azionario delle maggiori compagnie quotate. I ricavi annuali previsti, secondo le stime, ammonterebbero a 3,5 miliardi di euro, circa un decimo del gettito ipotizzato dalla Commissione Europea nel 2013 di fronte a proposte di tassazione decisamente più ambiziose in termini di base imponibile.
Impasse politica, si potrebbe dire. E non è certo una novità. Il contrasto all’elusione fiscale, restando alle raccomandazioni del FMI e al contesto continentale, ad esempio, fa i conti con le divisioni nel Vecchio Continente. A gennaio, intervenendo al World Economic Forum di Davos, il sottosegretario alle finanze polacco Jan Sarnowski e il direttore del think tank governativo Polish Economic Institute di Varsavia, Piotr Arak, hanno presentato uno studio per denunciare il peso delle pratiche elusive da parte di individui e imprese che, secondo le loro stime, costerebbero all’Europa circa 170 miliardi di mancati introiti ogni anno. L’80% dei profitti trasferiti, precisa la ricerca, sarebbe convogliato verso altri Paesi della UE «che dovrebbero essere definiti come paradisi fiscali», vale a dire Irlanda, Paesi Bassi, Malta, Cipro, Belgio e Lussemburgo. Lo scorso anno, tramite una risoluzione, il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di riconoscere formalmente come tax haven cinque Stati membri (i Paesi di cui sopra con l’eccezione del Belgio). La richiesta, ad oggi, non è ancora stata accolta.
Il ruolo delle banche centrali
In tutto questo la strategia espansiva delle banche centrali resta una costante. Il costo del denaro nelle principali economie globali viaggia da anni attorno a quota zero; i programmi di acquisto sul mercato – tradotto: l’immissione di liquidità – sono storicamente impressionanti. In meno di 15 anni il controvalore degli asset a bilancio dei quattro maggiori istituti centrali del Pianeta – Fed, Bce, Bank of Japan e People’s Bank of China – è quintuplicato passando da 5 a 25,2 trilioni di dollari (dati a giugno 2020). In termini teorici si parla di rischio-bolla ma il problema, in realtà, sembrerebbe essere più ampio. Lo ha suggerito alla fine di giugno Agustín Carstens, General Manager della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements, BIS) intervenendo all’assemblea annuale dell’ente a Basilea. In sintesi: l’intreccio tra le politiche fiscali – di pertinenza dei governi – e quelle monetarie – in capo alle banche centrali – si è consolidato negli anni e le cosiddette misure non convenzionali, a partire dall’alleggerimento quantitativo, hanno perso il loro carattere estemporaneo assumendo al contrario una persistenza sostanziale. Lo insegna l’esperienza del decennio post crisi e lo confermerebbe il contesto attuale.
Per quanto necessarie, argomenta Carstens, le azioni fin qui condotte «possono minacciare l’indipendenza e la credibilità delle banche centrali stesse». In particolare, ha aggiunto, «data la massiccia risposta fiscale e il significativo aumento del debito pubblico che inevitabilmente seguirà, saranno in molti a chiedere che i costi di finanziamento siano mantenuti artificialmente bassi». Anche per questo, una volta superata la crisi, «sarà fondamentale che le banche centrali si mantengano indipendenti per adempiere ai loro mandati». A partire dal mantenimento della stabilità dei prezzi.
Tutto ampiamente auspicabile ma l’esperienza recente racconta una storia diversa. Fed e Bce sono sottoposte da tempo a una pressione più o meno esplicita da parte dei governi. La scorsa estate, da parte sua, la banca centrale indiana è arrivata persino a sostenere direttamente la spesa del governo.
I rischi per i Paesi emergenti
Ogni analisi sulla sostenibilità globale del debito, infine, non può prescindere da una valutazione sulla delicata posizione dei mercati emergenti e in via di sviluppo. Dal 2005 ad oggi, ha rilevato di recente il Financial Times, il debito dei Paesi più vulnerabili è passato da meno di mille miliardi a 3,2 trilioni di dollari, pari al 114% del loro Pil. Le pendenze complessive pubbliche e private (Stati, famiglie, imprese e società finanziarie) dei mercati emergenti, rileva l’Institute of International Finance, ammontano a 71 mila miliardi (16.700 dei quali ascrivibili ai governi).
Lo sbilanciamento fiscale è evidente: alla fine del quarto trimestre 2019 il debito pubblico dei Paesi emergenti aveva raggiunto quota 52,7% del Pil con una crescita di 3,2 punti percentuali rispetto a dodici mesi prima. Le pendenze pubbliche e private totali di queste nazioni valgono oggi il 220% del prodotto interno lordo contro il 147% del 2007. E i segnali di crisi non mancano di certo. Il drastico calo delle riserve valutarie impatta negativamente sulla capacità di ripagare i debiti in essere tanto più di fronte alla presenza di due fattori concomitanti: la crescita dei costi di rifinanziamento e un rilevante deflusso di capitali.
In questo quadro, infine, pesa l’incognita delle tensioni politiche tra Stati Uniti e Cina. La possibile escalation del conflitto commerciale tra Washington e Pechino, nota Bloomberg, «potrebbe ritardare la ripresa dell’economia globale, spingere gli operatori a investire nei beni rifugio come i titoli di Stato USA e rafforzare il dollaro». Un fenomeno, quest’ultimo, che renderebbe ancora più gravosa la gestione dei debiti dei mercati emergenti e in via di sviluppo denominati in valuta statunitense che, escludendo il settore bancario, ammontavano alla fine del 2019 a 3,9 trilioni di dollari.