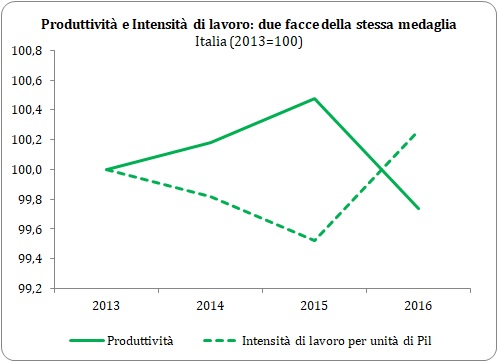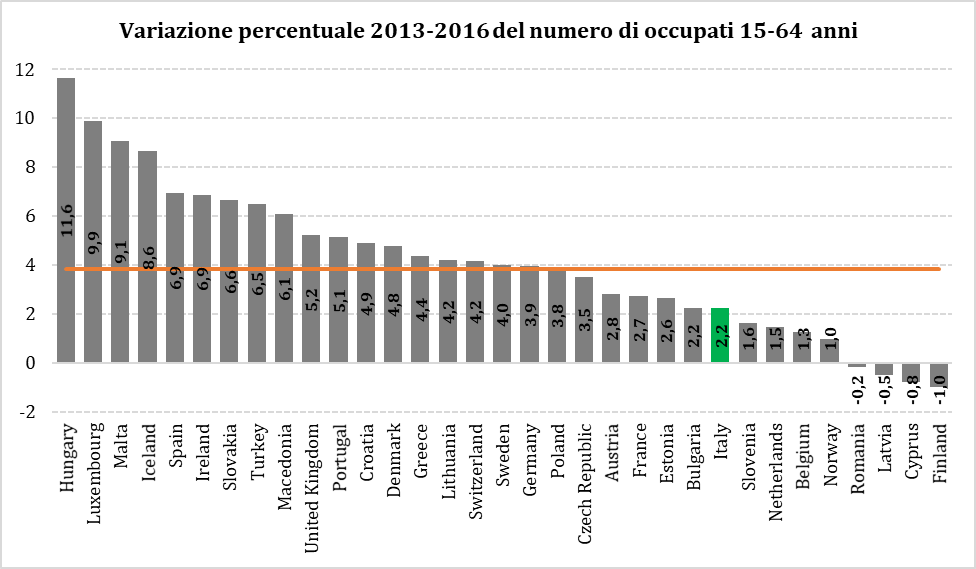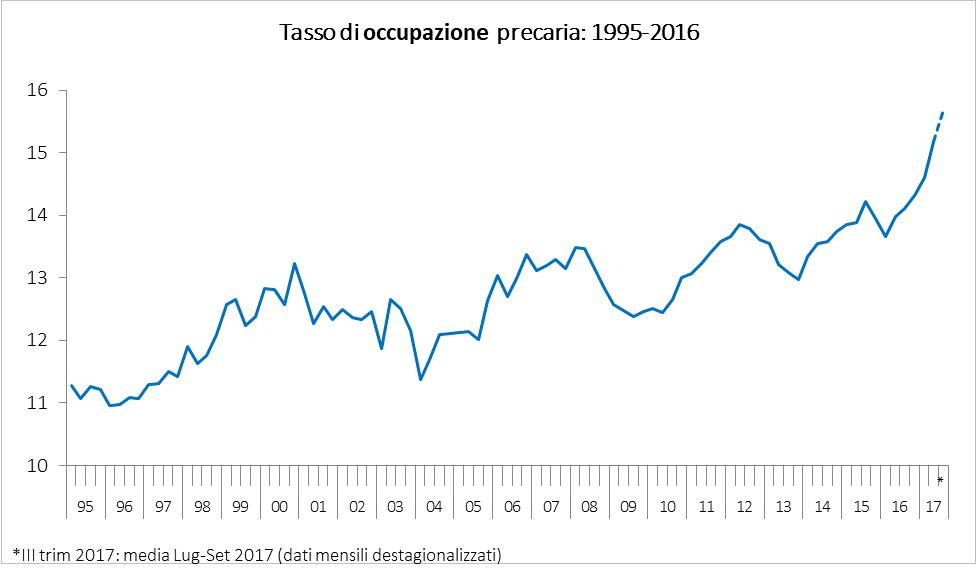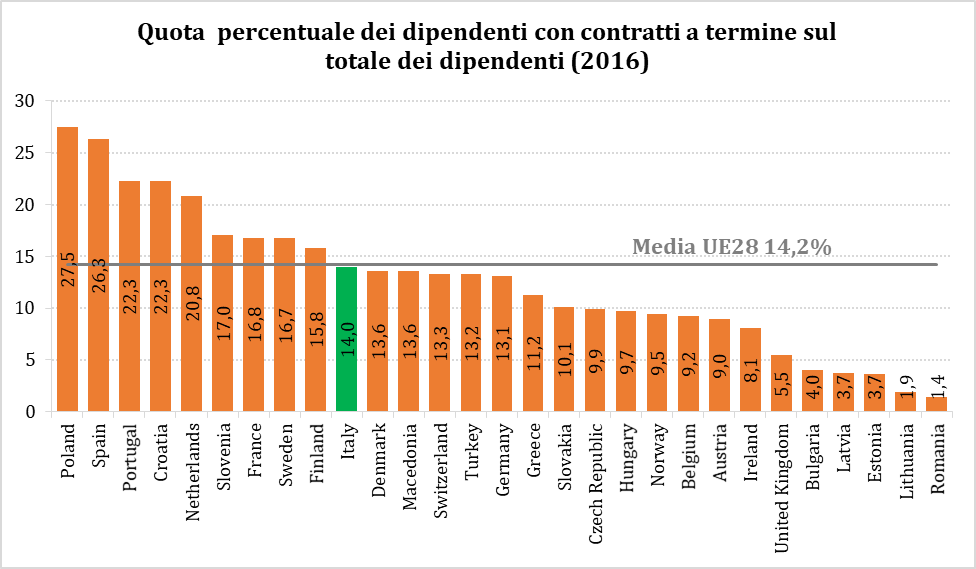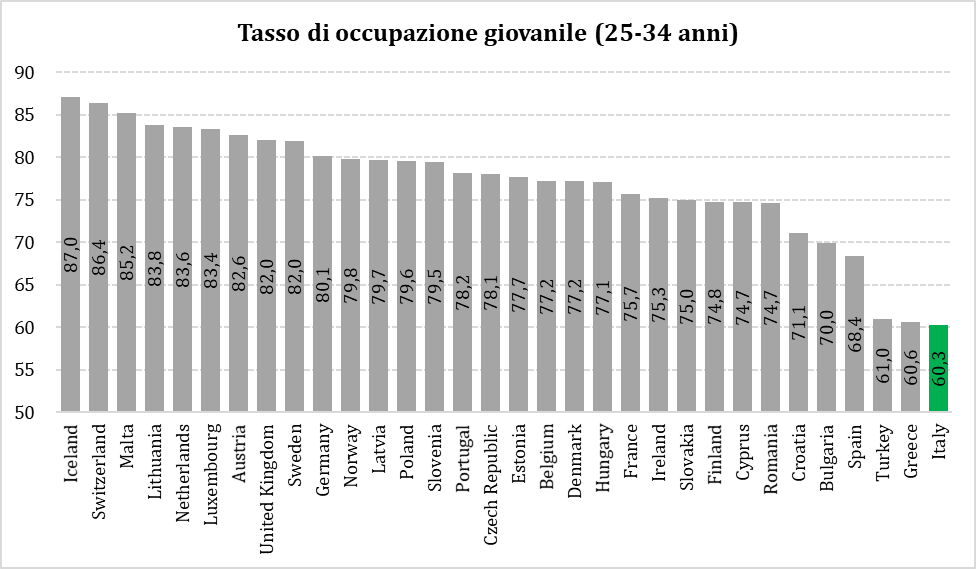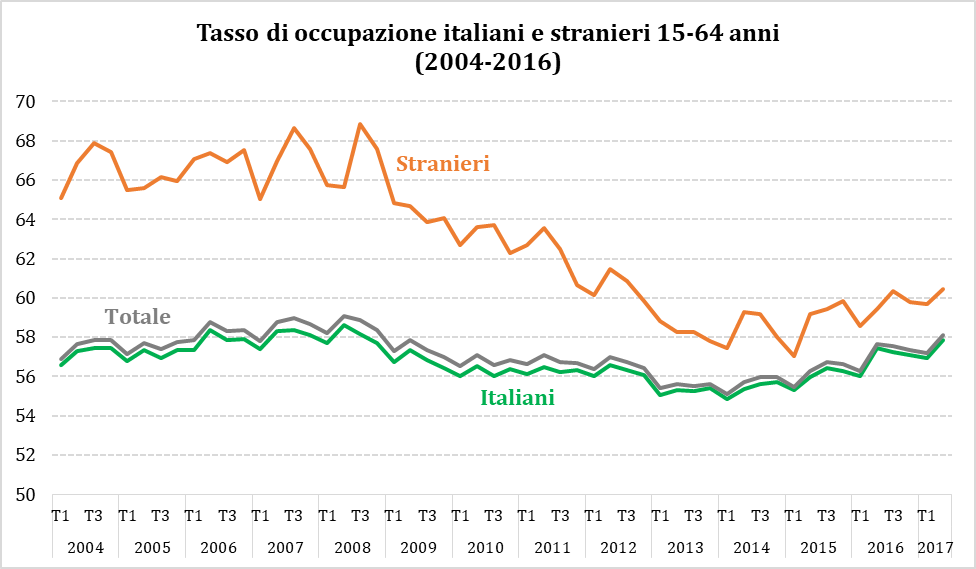La tenda a ossigeno
Da qualche settimana siamo sommersi dai “segno +”. Di qualsiasi cosa si parli, consumi, esportazioni, inflazione, occupazione, disoccupazione, fiducia dei consumatori, pressione fiscale, Pil, è tutto un compiacerci che finalmente la barca va, il Paese si è rimesso in moto. Tv e giornali non si stancano di riprendere, con grande risalto, ogni bit di nuova informazione statistica sui progressi dell’Italia.
Questo profluvio di buone notizie, tuttavia, non ha impedito ai commentatori più attenti (e inascoltati), di puntare l’attenzione anche sull’unico vero grave fattore di rischio dell’Italia: l’andamento della finanza pubblica. Detto in poche parole, il timore è che, dopo la grande sbornia delle promesse elettorali, a primavera l’Italia si possa trovare di nuovo in una situazione molto critica, come nel 2011.
Sono giustificati questi timori?
Difficile dare una risposta secca, perché ci sono fattori che stanno riducendo i nostri rischi, e altri che li stanno aumentando. Fra i fattori favorevoli, che ci proteggono dal rischio di una crisi, si devono menzionare soprattutto tre elementi che nel corso del 2017 hanno ridotto la vulnerabilità dei nostri conti pubblici: la crescita del Pil, la ripresa dell’inflazione, la riduzione della quota di debito pubblico detenuta da investitori esteri. Ma i fattori favorevoli si fermano qua, per il resto, sfortunatamente, possiamo solo guardare con apprensione al 2018, o meglio a quel che potrà succedere dopo il voto di marzo.
Alcuni fattori di rischio sono ben noti. Il più noto è l’uscita dell’Italia dalla tenda ad ossigeno che l’ha protetta negli ultimi anni: nel 2018 la Banca centrale europea allenterà il Quantitative Easing, ovvero l’acquisto di titoli di Stato dei paesi della zona Euro; nel 2019 scadrà il mandato di Mario Draghi, il “cavaliere bianco” che ci ha protetti e salvati in questi anni (così lo chiama Roberto Napoletano, in un libro di grande interesse sulla crisi del 2011: Il cigno nero e il cavaliere bianco, La nave di Teseo 2017). Un secondo fattore di rischio ben noto è l’incertezza politica, nelle sue due varianti fondamentali: una situazione di stallo, con possibile ricorso a nuove elezioni; la formazione di un governo delle forze più anti-europee (Cinque Stelle e Lega). Un terzo fattore di rischio è il probabile arrivo, fra marzo e aprile, di una richiesta della Commissione europea all’Italia di effettuare una manovra correttiva dei conti pubblici. Un altro fattore di rischio è il possibile aumento del tasso di riferimento della Bce, con conseguente aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato. E infine, un ultimo fattore di rischio è un cambiamento delle regole bancarie, che potrebbe condurre a una valutazione dei titoli di Stato detenuti dalle banche agganciata al rating delle Agenzie (100 euro di Bot italiani valgono meno di 100 euro di Bund tedeschi), con conseguente repentina svalutazione dei patrimoni delle banche italiane, i cui bilanci sono tuttora appesantiti da più di 300 miliardi di titoli di Stato).
Quel che è meno noto, a giudicare da quanto poco se ne parla, è che a qualche giorno prima del voto potrebbe arrivare la notizia che nel 2017, ancora una volta, il governo italiano ha mancato la promessa di iniziare a ridurre il rapporto debito/Pil.
Secondo le stime ufficiali, nel 2017, per la prima volta da dieci anni, il rapporto debito/Pil comincerà a scendere, sia pure in misura irrisoria, dal 132.6% al 132.5%. Ma se guardiamo gli ultimi dati del Pil, pubblicati dall’Istat, e gli ultimi dati del debito, pubblicati dalla Banca d’Italia, il quadro che ci si presenta è assai poco rassicurante.
Nel corso del 2017 il Pil nominale, che è quello che conta ai fini del calcolo del rapporto debito/Pil, dovrebbe registrare una crescita compresa fra il 2.1 e il 2.2%. Questo è il parametro chiave per capire se, nel 2017, il rapporto debito/Pil scenderà come promesso, o continuerà a salire come temuto: se, quando la Banca d’Italia comunicherà i dati del debito al 31 dicembre 2017, il debito stesso sarà salito meno del 2.1% rispetto all’anno precedente, il rapporto debito/Pil risulterà in discesa, e il ministro Padoan potrà giustamente esultare per aver mantenuto la promessa di ridurlo; se, viceversa, il debito sarà cresciuto più del 2.2% ancora una volta dovremo constatare che i governi si impegnano a ridurre il debito ma poi, invariabilmente, si accorgono di non esserci riusciti.
Ebbene, qual è la dinamica del debito pubblico dell’Italia nel 2017? L’ultimo dato disponibile è relativo a ottobre 2017 e, per quel che se ne sa, non include ancora tutti gli esborsi per i salvataggi bancari. Ebbene la tendenza a ottobre, rispetto a 12 mesi prima (ottobre 2016), segna +2.9%, dunque ben oltre la soglia del 2.2%; la tendenza a settembre è ancora più preoccupante: +3.2%; quella di agosto è +2.5%, e solo nei mesi precedenti si colloca al di sotto del 2%. Se consideriamo la media degli ultimi tre mesi, la tendenza del debito è a crescere del 2.9%. Una deriva preoccupante, iniziata nei primi mesi dell’anno: fra febbraio e settembre del 2017 la velocità di crescita del debito è sempre aumentata, passando dall’1.1% di febbraio al 3.2% di settembre.
Che dire?
Forse, semplicemente, che l’Italia avrebbe fatto meglio, in questi anni, a non sprecare il dividendo dell’euro e, soprattutto, i benefici del Quantitative Easing, che ci hanno permesso, di pagare interessi sempre minori sul debito pubblico. Se, anziché disperdere risorse preziose in benefici elettorali, avessimo cominciato a ridurre la montagna del debito, magari avviando finalmente qualcuna delle tante privatizzazioni messe in agenda e mai attuate, oggi il voto del 4 marzo ci si presenterebbe con un volto meno minaccioso.