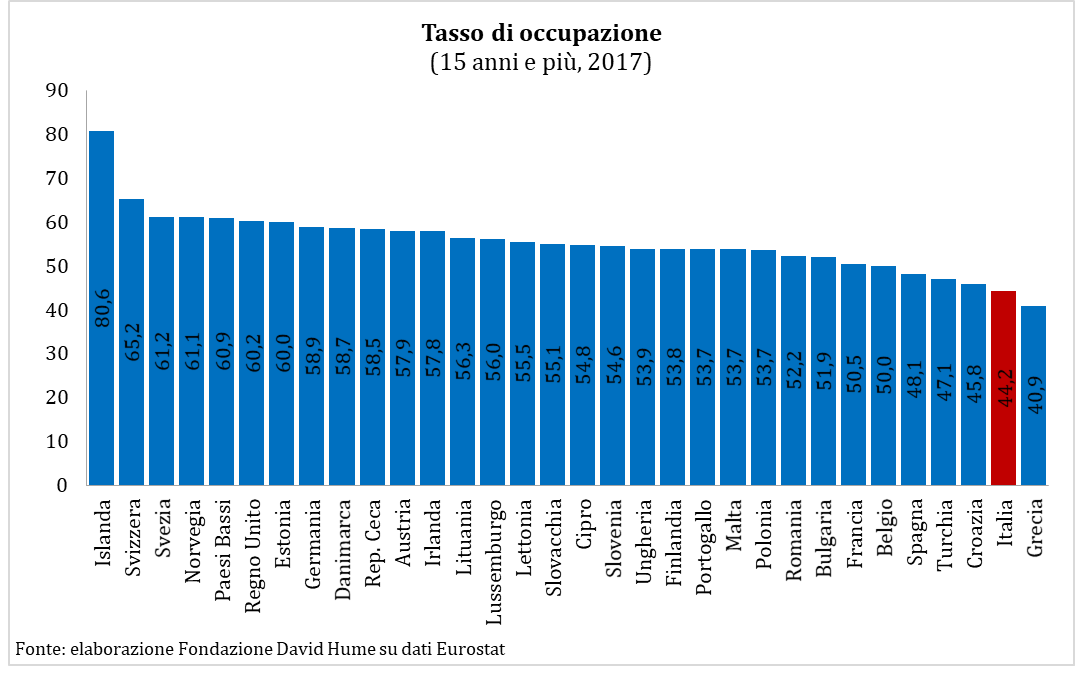Non solo Salvini. Le origini dell’insicurezza
Fra le convinzioni più granitiche del mondo progressista vi è quella che la domanda di sicurezza, e la connessa paura dello straniero, siano l’amaro frutto della propaganda di destra, e in particolare della spregiudicatezza comunicativa di Matteo Salvini, sempre pronto ad amplificare qualsiasi episodio di violenza che veda come vittima un italiano e come autore uno straniero, specie se migrante, richiedente asilo o rifugiato.
A sostegno di questa tesi vengono citati, quasi sempre, i dati sull’andamento dei delitti, un po’ vecchiotti (fermi al 2016) ma piuttosto univoci: in era renziana i delitti totali, compresi quelli di maggiore allarme sociale come omicidi, furti, violenze sessuali, mostrano una netta tendenza alla diminuzione. Se i delitti calano, come spiegare il crescente senso di insicurezza degli italiani, nonché la conseguente impetuosa crescita della domanda di sicurezza, se non come il risultato di una manipolazione dell’opinione pubblica, scientemente aizzata ad avere paura?
Questa lettura di quel che è successo non è insensata, o puramente autoconsolatoria. Penso anch’io che, senza l’azione combinata della politica e dei media, il senso di insicurezza degli italiani non sarebbe aumentato tanto quanto è aumentato in questi ultimi anni. E tuttavia credo che, da sola, quella spiegazione non funzioni. Quando si parla di insicurezza, e si imputa la sua crescita essenzialmente agli “imprenditori della paura”, a mio parere si dimenticano due importantissimi fattori che, in questi anni, hanno contribuito non poco ad alimentare insicurezza e domanda di protezione.
Per illustrare il primo fattore riporto qualche passaggio di una mail, alquanto cruda, che ho ricevuto qualche tempo fa da un giovane studioso italiano che ha avuto la ventura di entrare per la prima volta negli Stati Uniti per un convegno. Parlando degli “sbarchi via aereo”, comincia con il farmi notare la ingombrante burocrazia dei visti d’ingresso, le domande cui tutti – bianchi e non bianchi – devono rispondere (tipo: cosa vieni a fare? quando te ne vai? a che indirizzo pernotti? quanti soldi hai?). Per poi concludere: “la mera esistenza di questa procedura di selezione degli ingressi (che fa anche un po’ paura, ci sono stemmi della polizia intimidatori ecc.) dà l’impressione che per lo meno gli USA cercano di proteggere i loro cittadini, mentre in Italia questo è l’ultimo dei problemi. C’è anche questo modo di vederla: se gli accessi fossero regolati e avessero un aspetto meno selvaggio di un barcone pieno di africani, i cittadini italiani avrebbero forse più l’impressione che allo Stato importa qualcosa di loro, cosa di cui l’americano medio non dubita”.
Naturalmente so bene che le situazioni dell’Italia e degli Stati Uniti sono molto diverse, anzi speculari (là il problema è la frontiera con il Messico, qui è il Mediterraneo), però la domanda fondamentale resta la stessa: in questi anni i nostri governi hanno dato l’impressione che allo Stato interessasse proteggere i propri cittadini filtrando rigorosamente gli ingressi?
La risposta è: assolutamente no. Per anni il messaggio è stato esattamente quello contrario: non dovete preoccuparvi, e se lo fate è perché siete preda di paure irrazionali; la nostra missione, e quindi la nostra priorità, è salvare vite umane. C’è voluto l’approssimarsi delle elezioni, e l’avvento di Minniti, per cambiare registro, ma era troppo tardi, e comunque non poteva bastare. Perché la gente non si basa sulle statistiche, ma su quel che vede: 100 mila ingressi regolari e controllati creano meno inquietudine di un solo barcone con 100 migranti che non si potranno mai respingere, anche quando risultasse che non hanno diritto ad alcuna forma di protezione. E dire che, anche a sinistra, qualcuno aveva provato a dirlo, che non c’è dialogo senza sicurezza: “la sensazione di sicurezza da entrambi i lati della barricata è una condizione essenziale per il dialogo fra le culture” scriveva Zygmunt Bauman nel 2011, giusto prima dell’inizio delle primavere arabe (Per tutti i gusti, Laterza 2011).
La rinuncia di chi ha il dovere di proteggere a prendere sul serio il proprio ruolo non è però l’unico fattore che ha fatto lievitare il senso di insicurezza. Ce n’ è anche un altro, molto più subdolo e sottile. Anche in questo caso preferisco spiegarmi con un esempio: qualche giorno fa, guardando un telegiornale, apprendo che, in vista di qualche giornata un po’ calda, le autorità stanno predisponendo una gigantesca campagna di sorveglianza e protezione denominata “estate sicura”, come se un gravissimo pericolo incombesse sulle nostre vite. Lungi da me criticare una simile lodevole iniziativa, ma non posso non notare che una campagna simile era inconcepibile anche solo un paio di decenni fa, e che sono ormai centinaia le iniziative, le pubblicità, gli eventi nei quali siamo implacabilmente avvertiti dei pericoli che corriamo, nonché dei rimedi che, per lo più a pagamento, sono a nostra disposizione purché prendiamo atto della nostra vulnerabilità. Non so se lo avete notato, ma è da anni e anni che sia la pubblicità commerciale, sia la pubblicità progresso, ci terrorizzano con quello che ci potrebbe succedere se non stiamo attenti alla placca dentaria, se non stipuliamo un’assicurazione, se non installiamo impianti di allarme nella nostra casa, se non disinfettiamo la stanza in cui gioca il bambino, se non ci sottoponiamo a controlli medici periodici, se non ci vacciniamo contro l’influenza, se non portiamo il cane e il gatto dal veterinario, se non mettiamo la mascherina anti-smog, se non scegliamo un’auto con 9 airbag (salvo aggiungere: “ma gli airbag non bastano più”, e giù dispositivi elettronici che ci avvertono di tutto e ci proteggono in ogni situazione). E questo martellamento, come stanno documentando molti studi di psicologia (specie negli Stati Uniti), non sta solo impaurendo le generazioni più anziane, ma sta forgiando una generazione di ragazzi sempre più insicura, intimorita, iperprotetta, e proprio per questo non attrezzata ad affrontare le difficoltà della vita adulta. Già una quindicina di anni fa, parlando dell’evoluzione della società americana, Hara Estroff Marano ebbe a coniare l’espressione Nation of Wimps (una “nazione di schiappe”), mentre un’altra psicologa, Jean Twenge, da poco ha pubblicato un libro (iGen, in italiano Iperconnessi, Einaudi 2018) nel cui sottotitolo i ragazzi della generazione internet sono descritti come “del tutto impreparati a diventare adulti”, proprio per l’eccesso di attenzioni protettive da parte di genitori e docenti.
E’ il progresso, ovviamente. Come si fa a non compiacersi degli standard sempre più elevati di sicurezza? Tuttavia forse sfugge l’altra faccia della medaglia: una società bombardata dall’imperativo della sicurezza, ossessivamente invitata a proteggersi da ogni sorta di minaccia, non diventa soggettivamente sempre più sicura, bensì sempre più vigile, e inevitabilmente sempre più sensibile ai problemi della sicurezza. Avete notato quanto è aumentato l’uso, soprattutto nei media, di espressioni come “sicuro”, “sicurezza”? e l’uso ossessivo, nelle situazioni più disparate, dell’espressione “mettere in sicurezza”?
Il paradosso delle campagne per la sicurezza è che il loro effetto collaterale è di aumentare il sentimento di insicurezza. Ma tutto questo non può non avere effetti anche sul modo in cui viene percepito il problema dei migranti. Più una società è impegnata in una ricerca ossessiva della sicurezza, più è destinata a mal digerire qualsiasi evento che appaia fuori controllo.
E’ la dialettica della protezione. Nella società italiana la paura dello straniero è stata certamente alimentata dalle campagne politiche anti-sbarchi e anti-Ong, ma non possiamo dimenticare che il terreno della paura era stato scrupolosamente concimato da due meccanismi, per certi versi opposti, che con Salvini nulla hanno a che fare. Il primo si ha quando chi deve proteggerti (governo) cerca di convincerti che le tue preoccupazioni sono infondate. Il secondo si ha quando chi vuole offrirti un prodotto o un servizio (pubblicità) cerca di convincerti che ti devi preoccupare. Il cocktail fra questi due grandi meccanismi della psicologia sociale, entrambi assai rigogliosi negli anni della crisi, ha reso altamente infiammabili le anime dei cittadini: è forse per questo che è bastato Salvini a farle prendere fuoco.